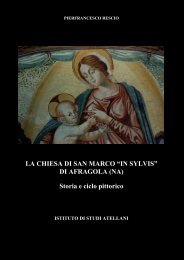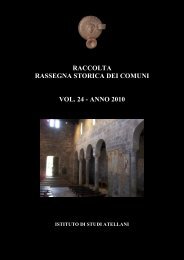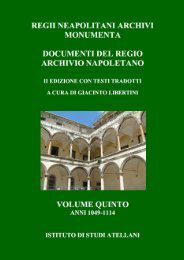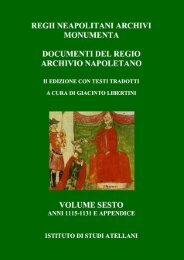Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro
Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro
Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
164<br />
Trentola 0,17% 0,17% 0,22% 0,13% 0,00% 0,01% 0,69%<br />
Totali 19,55% 45,86% 27,92% 5,74% 0,51% 0,41% 100,00%<br />
Sul totale delle entrate circa il 20% era rappresentato dagli <strong>in</strong>troiti da capitali, re<strong>di</strong>mibili<br />
e non, concessi <strong>alla</strong> piccola borghesia locale. I capitali dei luoghi <strong>pii</strong> erano, <strong>in</strong> parte, la<br />
conseguenza della mancata possibilità <strong>di</strong> <strong>in</strong>vestire le monete sonanti <strong>in</strong> immobili a causa<br />
delle leggi <strong>di</strong> ammortizzazione. Era consentito però trasformare i capitali <strong>in</strong> ren<strong>di</strong>te<br />
sicure me<strong>di</strong>ante il re<strong>in</strong>vestimento <strong>in</strong> nuove ipoteche. I tassi d’<strong>in</strong>teresse applicati ai<br />
capitali variavano non solo <strong>in</strong> base al periodo <strong>di</strong> concessione del prestito ma anche <strong>in</strong><br />
base all’entità del prestito stesso 8 . In genere a importi bassi corrispondevano <strong>in</strong>teressi<br />
alti e viceversa. Ciò perché si considerava che un contratto stipulato con un nobile o un<br />
borghese avesse molte più probabilità <strong>di</strong> essere onorato rispetto a quelli, detti prestiti <strong>di</strong><br />
sussistenza, concessi ai “poveri”. C’era anche un altro motivo per cui i prestiti a chi era<br />
solvibile erano più frequenti. Il prestito, detto censo bollare, era re<strong>di</strong>mibile, ossia il<br />
ricevente poteva restituirlo, se voleva, fermo restante che avesse pagato la ren<strong>di</strong>ta<br />
dovuta per tutto il periodo che aveva tenuto il prestito. Le rate versate non potevano<br />
essere detratte dal capitale anche se pagate per lungo tempo. Di conseguenza chi<br />
utilizzava il prestito per <strong>in</strong>vestire <strong>in</strong> immobili o <strong>in</strong> migliorie agrarie ecc. poteva pagare<br />
gli <strong>in</strong>teressi passivi con il frutto dell’<strong>in</strong>vestimento, non solo, ma <strong>in</strong> perio<strong>di</strong> d’<strong>in</strong>flazione<br />
marcata, la ren<strong>di</strong>ta da pagare <strong>di</strong>m<strong>in</strong>uiva sempre più <strong>di</strong> valore 9 . Chi chiedeva un prestito<br />
<strong>di</strong> sussistenza o per il pagamento <strong>di</strong> debiti si obbligava <strong>in</strong> perpetuo a sborsare una<br />
ren<strong>di</strong>ta per un capitale che non gli fruttava niente.<br />
Per dare un’idea dell’entità dei capitali a <strong>di</strong>sposizione dei luoghi <strong>pii</strong> consideriamo che se<br />
essi fossero stati concessi a un tasso d’<strong>in</strong>teresse me<strong>di</strong>o del 4-5%, la ren<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> 8.978<br />
ducati <strong>di</strong> <strong>in</strong>teressi all’anno, <strong>in</strong>cassata dai luoghi <strong>pii</strong> della <strong>di</strong>ocesi aversana,<br />
corrispondeva a un capitale <strong>di</strong> 200.000 ducati circa, una cifra enorme per quei tempi,<br />
sufficiente a comprare proprietà immobiliari considerevoli. Si tenga conto che nel 1778<br />
il feudo <strong>di</strong> Cesa fu acquistato per 71.326 ducati dal marchese Francesco Saverio<br />
Maresca e Giugliano nel 1779 fu acquistato da Marc’Antonio Colonna per 83.627<br />
ducati 10 . Se si considera che i capitali ai quali ci riferiamo riguardano 195 sodalizi sul<br />
totale <strong>di</strong> 273 e, ammesso che essi siano rappresentativi dell’universo, il totale dei<br />
capitali concessi <strong>in</strong> prestito ammonterebbe a circa 300.000 ducati. Come si può notare il<br />
giro <strong>di</strong> capitali era notevole e i benefici ricavati da chi li riceveva erano sufficienti a<br />
comprare proprietà immobiliari, che rendevano ben oltre le annualità che si pagavano al<br />
luogo pio. Che i capitali fossero concessi molto frequentemente <strong>alla</strong> nobiltà e <strong>alla</strong><br />
borghesia per <strong>in</strong>vestimenti immobiliari trova conferma anche d<strong>alla</strong> ricerca condotta da<br />
Augusto Placanica sulla Calabria 11 . L’attività cre<strong>di</strong>tizia dei luoghi <strong>pii</strong> <strong>alla</strong> piccola<br />
borghesia locale per acquistare proprietà immobiliare fu la costante dell’attività<br />
8 Com’è noto il <strong>di</strong>ritto canonico vietava ai cattolici <strong>di</strong> percepire <strong>in</strong>teresse sui prestiti, consentiva<br />
però <strong>di</strong> dare capitali a terzi <strong>in</strong> cambio <strong>di</strong> un importo fisso annuo perpetuo, con la possibilità per il<br />
debitore <strong>di</strong> re<strong>di</strong>mere il censo a suo piacere. Il tasso d’<strong>in</strong>teresse variava dal 5 al 9 %. Per una<br />
descrizione delle modalità <strong>di</strong> cessione dei capitali da parte delle confraternite cfr. Enrica Delle<br />
Donne Robertazzi, op. cit. pp. 160-163.<br />
9 Augusto Placanica, Moneta prestiti usure nel Mezzogiorno moderno, Napoli 1982, pp. 26 – 27.<br />
10 Aurelio Lepre, <strong>Terra</strong> <strong>di</strong> <strong>Lavoro</strong> nell’Età Moderna, Napoli 1978, p. 64.<br />
11 Augusto Placanica, op. cit, pp. 253 e sgg.