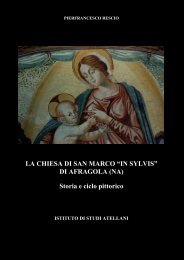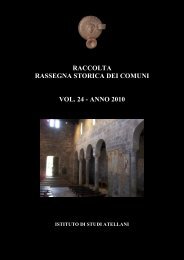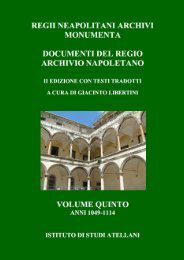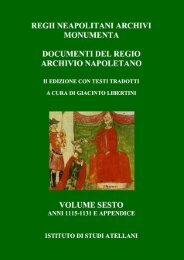Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro
Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro
Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
33<br />
quella <strong>di</strong> controllare gli amm<strong>in</strong>istratori dei Monti, per la <strong>di</strong>stribuzione delle elemos<strong>in</strong>e e<br />
dei maritaggi 113 .<br />
Galanti affermava che “alcuni <strong>di</strong> essi sono impiegati a soccorrere i bisognosi, altri a far<br />
prestiti, altri a far l’uno e l’altro”. Tra i primi ricordava, nella città <strong>di</strong> Napoli, il Monte<br />
della pietà, il Monte dei Poveri, il Monte dei poveri vergognosi e il Monte della<br />
Misericor<strong>di</strong>a, che concedevano prestiti senza <strong>in</strong>teressi per importi bassi, e con un lucro<br />
del 6 per cento per importi superiori. Spesso versavano contributi a ospizi e ospedali, e<br />
dotavano fanciulle povere. Vi ricorrevano per i prestiti “la povertà e l’opulenza. Vi si<br />
depositano, scrive Galanti, i <strong>di</strong>amanti delle dame per farsi una veste <strong>alla</strong> moda; le<br />
camice della femm<strong>in</strong>uccia per aver del pane; le fibbie <strong>di</strong> argento del facch<strong>in</strong>o e del<br />
lacchè per giocare al lotto” 114 . Nel Regno <strong>di</strong> Napoli non vi fu una presenza significativa<br />
nel corso dei secoli XIV e XV né <strong>di</strong> corti signorili né <strong>di</strong> una borghesia arricchitasi con la<br />
mercanzia, la banca o la gestione <strong>di</strong> dazi e gabelle. Questi gran<strong>di</strong> mercanti, che Cipolla<br />
chiama hom<strong>in</strong>es novi, faranno <strong>in</strong> quelle regioni cospicui <strong>in</strong>vestimenti <strong>in</strong> e<strong>di</strong>lizia<br />
ospedaliera o ecclesiastica <strong>in</strong> espiazione dei propri peccati, restituendo a , “attraverso i poveri o la chiesa” gli illeciti guadagni ottenuti con l’usura,<br />
col commercio e con la banca 115 . Nel Regno anche le gran<strong>di</strong> realizzazioni come gli<br />
ospedali furono opera <strong>di</strong> associazioni e <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> cittad<strong>in</strong>i.<br />
Monti <strong>di</strong> maritaggio<br />
La prima <strong>in</strong>iziativa <strong>di</strong> assemblare un fondo <strong>in</strong> cui i genitori potessero versare delle quote<br />
d<strong>alla</strong> nascita <strong>di</strong> una figlia per dare una dote al momento del matrimonio fu presa dal<br />
governo fiorent<strong>in</strong>o nel 1425. Il progetto non ebbe grande successo per la cattiva<br />
amm<strong>in</strong>istrazione del fondo da parte dei funzionari statali. Nel secolo XVI <strong>in</strong> <strong>di</strong>verse<br />
<strong>di</strong>ocesi più povere del Meri<strong>di</strong>one, <strong>in</strong> Abruzzo, Molise e Basilicata, nacquero istituzioni<br />
chiamate Monti <strong>di</strong> Maritaggio “che elargivano somme <strong>in</strong> prestito , o<br />
permettevano <strong>in</strong>vestimenti <strong>in</strong> modo che si potessero pagare le doti” 116 . In questo caso<br />
sembra che non ci fosse partecipazione <strong>alla</strong> costituzione della dote da parte delle<br />
famiglie delle ragazze.<br />
Di natura <strong>di</strong>versa erano i maritaggi assegnati dalle confraternite, o a seguito <strong>di</strong> lasciti<br />
dest<strong>in</strong>ati a questo scopo da benefattori, o perché la loro erogazione rientrava nei compiti<br />
accessori della confraternita stessa, che li <strong>di</strong>stribuivano alle figlie dei propri membri<br />
poveri o ad altre ragazze purché povere e onorate. L’istituto del maritaggio era molto<br />
<strong>di</strong>ffuso a Napoli dal secolo XVII 117 . Le assegnazioni nascevano particolarmente dai<br />
legati pro anima, cioè da <strong>di</strong>sposizioni testamentarie che contenevano “tutti gli atti<br />
<strong>di</strong>spositivi a favore dell’erede con l’imposizione <strong>di</strong> un modus che lo v<strong>in</strong>colava ad<br />
erogare somme o a svolgere attività per f<strong>in</strong>i religiosi o <strong>di</strong> culto. In particolare, i legati <strong>di</strong><br />
cui parliamo potevano essere def<strong>in</strong>iti anche pro anima, quando stabilivano che fossero<br />
compiuti atti <strong>di</strong> culto <strong>in</strong> suffragio della propria anima (…). All’epoca era ancora molto<br />
113<br />
Aurelio Musi, La rivolta <strong>di</strong> Masaniello nella scena politica barocca, Napoli MMIII, p. 69.<br />
114<br />
G. M. Galanti, op. cit., vol. II, p. 110.<br />
115<br />
Carlo M. Cipolla, Storia facile dell’economia italiana dal me<strong>di</strong>oevo a oggi, Milano 1996, pp.<br />
53-55.<br />
116<br />
Cfr. Christopher F. Black, op. cit., p. 235, che cita M. Mariotti, Ricerca sulle confraternite<br />
laicali del Mezzogiorno <strong>in</strong> età moderna. Rapporto sulla Calabria, <strong>in</strong> V. Paglia (a cura <strong>di</strong>),<br />
Confraternite e Meri<strong>di</strong>one nell’età moderna , Roma 1990, <strong>in</strong> particolare pp. 168-169.<br />
117<br />
F. Schiattarella, Maritaggi <strong>di</strong> cuccagna, Napoli 1969.