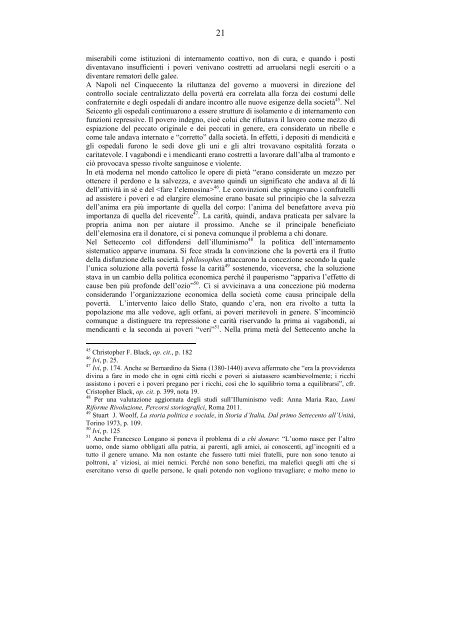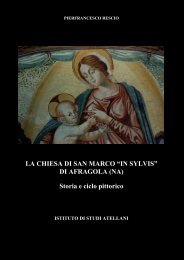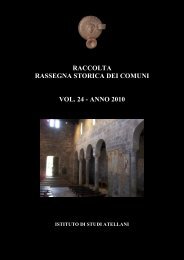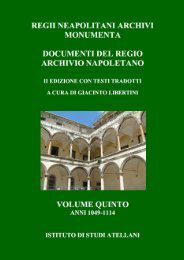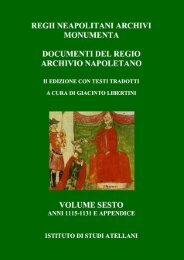Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro
Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro
Dai Luoghi pii alla pubblica assistenza in Terra di Lavoro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
21<br />
miserabili come istituzioni <strong>di</strong> <strong>in</strong>ternamento coattivo, non <strong>di</strong> cura, e quando i posti<br />
<strong>di</strong>ventavano <strong>in</strong>sufficienti i poveri venivano costretti ad arruolarsi negli eserciti o a<br />
<strong>di</strong>ventare rematori delle galee.<br />
A Napoli nel C<strong>in</strong>quecento la riluttanza del governo a muoversi <strong>in</strong> <strong>di</strong>rezione del<br />
controllo sociale centralizzato della povertà era correlata <strong>alla</strong> forza dei costumi delle<br />
confraternite e degli ospedali <strong>di</strong> andare <strong>in</strong>contro alle nuove esigenze della società 45 . Nel<br />
Seicento gli ospedali cont<strong>in</strong>uarono a essere strutture <strong>di</strong> isolamento e <strong>di</strong> <strong>in</strong>ternamento con<br />
funzioni repressive. Il povero <strong>in</strong>degno, cioè colui che rifiutava il lavoro come mezzo <strong>di</strong><br />
espiazione del peccato orig<strong>in</strong>ale e dei peccati <strong>in</strong> genere, era considerato un ribelle e<br />
come tale andava <strong>in</strong>ternato e “corretto” d<strong>alla</strong> società. In effetti, i depositi <strong>di</strong> men<strong>di</strong>cità e<br />
gli ospedali furono le se<strong>di</strong> dove gli uni e gli altri trovavano ospitalità forzata o<br />
caritatevole. I vagabon<strong>di</strong> e i men<strong>di</strong>canti erano costretti a lavorare dall’alba al tramonto e<br />
ciò provocava spesso rivolte sangu<strong>in</strong>ose e violente.<br />
In età moderna nel mondo cattolico le opere <strong>di</strong> pietà “erano considerate un mezzo per<br />
ottenere il perdono e la salvezza, e avevano qu<strong>in</strong><strong>di</strong> un significato che andava al <strong>di</strong> là<br />
dell’attività <strong>in</strong> sé e del 46 . Le conv<strong>in</strong>zioni che sp<strong>in</strong>gevano i confratelli<br />
ad assistere i poveri e ad elargire elemos<strong>in</strong>e erano basate sul pr<strong>in</strong>cipio che la salvezza<br />
dell’anima era più importante <strong>di</strong> quella del corpo: l’anima del benefattore aveva più<br />
importanza <strong>di</strong> quella del ricevente 47 . La carità, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, andava praticata per salvare la<br />
propria anima non per aiutare il prossimo. Anche se il pr<strong>in</strong>cipale beneficiato<br />
dell’elemos<strong>in</strong>a era il donatore, ci si poneva comunque il problema a chi donare.<br />
Nel Settecento col <strong>di</strong>ffondersi dell’illum<strong>in</strong>ismo 48 la politica dell’<strong>in</strong>ternamento<br />
sistematico apparve <strong>in</strong>umana. Si fece strada la conv<strong>in</strong>zione che la povertà era il frutto<br />
della <strong>di</strong>sfunzione della società. I philosophes attaccarono la concezione secondo la quale<br />
l’unica soluzione <strong>alla</strong> povertà fosse la carità 49 sostenendo, viceversa, che la soluzione<br />
stava <strong>in</strong> un cambio della politica economica perché il pauperismo “appariva l’effetto <strong>di</strong><br />
cause ben più profonde dell’ozio” 50 . Ci si avvic<strong>in</strong>ava a una concezione più moderna<br />
considerando l’organizzazione economica della società come causa pr<strong>in</strong>cipale della<br />
povertà. L’<strong>in</strong>tervento laico dello Stato, quando c’era, non era rivolto a tutta la<br />
popolazione ma alle vedove, agli orfani, ai poveri meritevoli <strong>in</strong> genere. S’<strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciò<br />
comunque a <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guere tra repressione e carità riservando la prima ai vagabon<strong>di</strong>, ai<br />
men<strong>di</strong>canti e la seconda ai poveri “veri” 51 . Nella prima metà del Settecento anche la<br />
45<br />
Christopher F. Black, op. cit., p. 182<br />
46<br />
Ivi, p. 25.<br />
47<br />
Ivi, p. 174. Anche se Bernard<strong>in</strong>o da Siena (1380-1440) aveva affermato che “era la provvidenza<br />
<strong>di</strong>v<strong>in</strong>a a fare <strong>in</strong> modo che <strong>in</strong> ogni città ricchi e poveri si aiutassero scambievolmente; i ricchi<br />
assistono i poveri e i poveri pregano per i ricchi, così che lo squilibrio torna a equilibrarsi”, cfr.<br />
Cristopher Black, op. cit. p. 399, nota 19.<br />
48<br />
Per una valutazione aggiornata degli stu<strong>di</strong> sull’Illum<strong>in</strong>ismo ve<strong>di</strong>: Anna Maria Rao, Lumi<br />
Riforme Rivoluzione, Percorsi storiografici, Roma 2011.<br />
49<br />
Stuart J. Woolf, La storia politica e sociale, <strong>in</strong> Storia d’Italia, Dal primo Settecento all’Unità,<br />
Tor<strong>in</strong>o 1973, p. 109.<br />
50<br />
Ivi, p. 125<br />
51<br />
Anche Francesco Longano si poneva il problema <strong>di</strong> a chi donare: “L’uomo nasce per l’altro<br />
uomo, onde siamo obbligati <strong>alla</strong> patria, ai parenti, agli amici, ai conoscenti, agl’<strong>in</strong>cogniti ed a<br />
tutto il genere umano. Ma non ostante che fussero tutti miei fratelli, pure non sono tenuto ai<br />
poltroni, a’ viziosi, ai miei nemici. Perché non sono benefizi, ma malefici quegli atti che si<br />
esercitano verso <strong>di</strong> quelle persone, le quali potendo non vogliono travagliare; e molto meno io