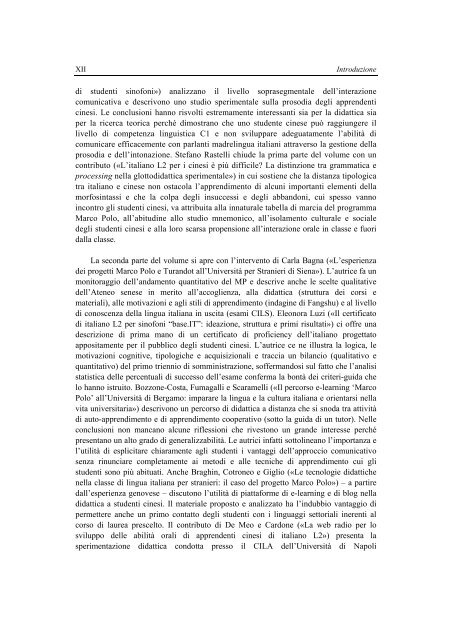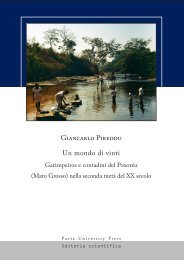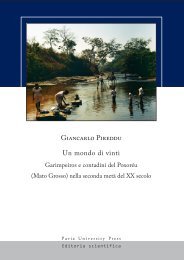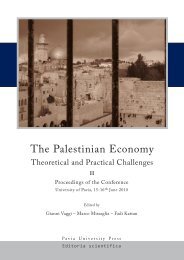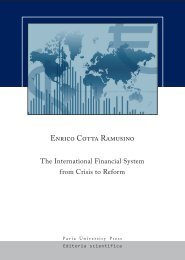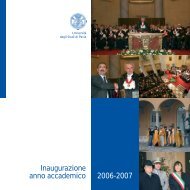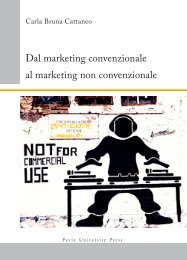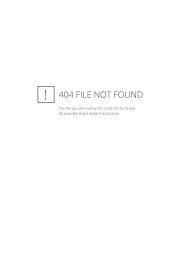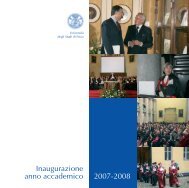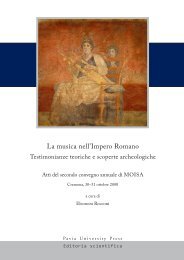La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
XII<br />
Introduzione<br />
di <strong>studenti</strong> sinofoni») analizzano <strong>il</strong> livello soprasegmentale dell’interazione<br />
comunicativa e descrivono uno studio sperimentale sulla prosodia degli apprendenti<br />
<strong>cinesi</strong>. Le conclusioni hanno risvolti estremamente interessanti sia per la <strong>didattica</strong> sia<br />
per la ricerca teorica perché dimostrano che uno studente cinese può raggiungere <strong>il</strong><br />
livello di competenza linguistica C1 e non sv<strong>il</strong>uppare adeguatamente l’ab<strong>il</strong>ità di<br />
comunicare efficacemente con parlanti madrelingua italiani attraverso la gestione della<br />
prosodia e dell’intonazione. Stefano Rastelli chiude la prima parte del volume con un<br />
contributo («L’italiano L2 per i <strong>cinesi</strong> è più diffic<strong>il</strong>e? <strong>La</strong> distinzione tra grammatica e<br />
processing nella glotto<strong>didattica</strong> sperimentale») in cui sostiene che la distanza tipologica<br />
tra italiano e cinese non ostacola l’apprendimento di alcuni importanti elementi della<br />
morfosintassi e che la colpa degli insuccessi e degli abbandoni, cui spesso vanno<br />
incontro gli <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong>, va attribuita alla innaturale tabella di marcia del programma<br />
<strong>Marco</strong> <strong>Polo</strong>, all’abitudine allo studio mnemonico, all’isolamento culturale e sociale<br />
degli <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong> e alla loro scarsa propensione all’interazione orale in classe e fuori<br />
dalla classe.<br />
<strong>La</strong> seconda parte del volume si apre con l’intervento di Carla Bagna («L’esperienza<br />
dei progetti <strong>Marco</strong> <strong>Polo</strong> e Turandot all’Università per Stranieri di Siena»). L’autrice fa un<br />
monitoraggio dell’andamento quantitativo del MP e descrive anche le scelte qualitative<br />
dell’Ateneo senese in merito all’accoglienza, alla <strong>didattica</strong> (struttura dei corsi e<br />
materiali), alle motivazioni e agli st<strong>il</strong>i di apprendimento (indagine di Fangshu) e al livello<br />
di conoscenza della lingua italiana in uscita (esami CILS). Eleonora Luzi («Il certificato<br />
di italiano L2 per sinofoni “base.IT”: ideazione, struttura e primi risultati») ci offre una<br />
descrizione di prima mano di un certificato di proficiency dell’italiano progettato<br />
appositamente per <strong>il</strong> pubblico degli <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong>. L’autrice ce ne <strong>il</strong>lustra la logica, le<br />
motivazioni cognitive, tipologiche e acquisizionali e traccia un b<strong>il</strong>ancio (qualitativo e<br />
quantitativo) del primo triennio di somministrazione, soffermandosi sul fatto che l’analisi<br />
statistica delle percentuali di successo dell’esame conferma la bontà dei criteri-guida che<br />
lo hanno istruito. Bozzone-Costa, Fumagalli e Scaramelli («Il percorso e-learning ‘<strong>Marco</strong><br />
<strong>Polo</strong>’ all’Università di Bergamo: imparare la lingua e la cultura italiana e orientarsi nella<br />
vita universitaria») descrivono un percorso di <strong>didattica</strong> a distanza che si snoda tra attività<br />
di auto-apprendimento e di apprendimento cooperativo (sotto la guida di un tutor). Nelle<br />
conclusioni non mancano alcune riflessioni che rivestono un grande interesse perché<br />
presentano un alto grado di generalizzab<strong>il</strong>ità. Le autrici infatti sottolineano l’importanza e<br />
l’ut<strong>il</strong>ità di esplicitare chiaramente agli <strong>studenti</strong> i vantaggi dell’approccio comunicativo<br />
senza rinunciare completamente ai metodi e alle tecniche di apprendimento cui gli<br />
<strong>studenti</strong> sono più abituati. Anche Braghin, Cotroneo e Giglio («Le tecnologie didattiche<br />
nella classe di lingua italiana per stranieri: <strong>il</strong> caso del <strong>progetto</strong> <strong>Marco</strong> <strong>Polo</strong>») – a partire<br />
dall’esperienza genovese – discutono l’ut<strong>il</strong>ità di piattaforme di e-learning e di blog nella<br />
<strong>didattica</strong> a <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong>. Il materiale proposto e analizzato ha l’indubbio vantaggio di<br />
permettere anche un primo contatto degli <strong>studenti</strong> con i linguaggi settoriali inerenti al<br />
corso di laurea prescelto. Il contributo di De Meo e Cardone («<strong>La</strong> web radio per lo<br />
sv<strong>il</strong>uppo delle ab<strong>il</strong>ità orali di apprendenti <strong>cinesi</strong> di italiano L2») presenta la<br />
sperimentazione <strong>didattica</strong> condotta presso <strong>il</strong> CILA dell’Università di Napoli