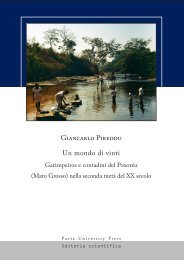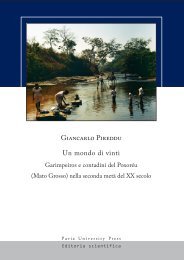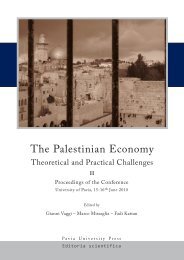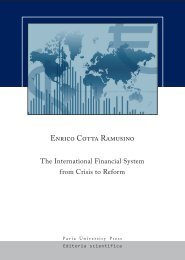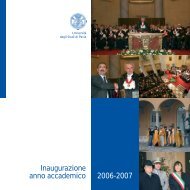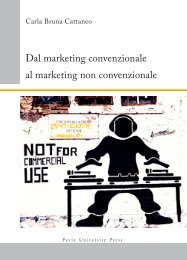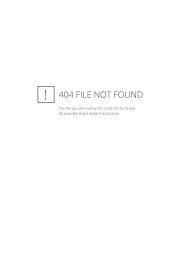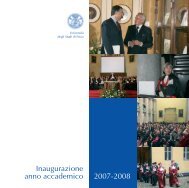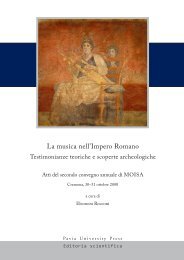La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
46<br />
Elisabetta Bonvino<br />
Elaborazione del materiale raccolto e presentazione finale. L’opuscolo è stato<br />
redatto e le risposte alle domande delle interviste dai differenti punti di vista sono state<br />
tradotte in italiano e in cinese. L’opuscolo è stato effettivamente pubblicato e alcune<br />
parti sono on-line. Gli apprendenti delle diverse lingue hanno avuto modo di conoscere<br />
meglio le rispettive culture, sfatando molti stereotipi e conoscersi meglio<br />
individualmente, di lavorare a un obiettivo comune, di discutere, leggere e scrivere<br />
insieme. Hanno al contempo svolto compiti che hanno permesso loro di ‘notare’ e<br />
individuare forme linguistiche, effettuando, in collaborazione fra pari, una produzione<br />
adeguata alle proprie risorse.<br />
4. Conclusioni<br />
Da quanto detto, emerge che nei corsi di italiano per gli <strong>studenti</strong> “<strong>Marco</strong> <strong>Polo</strong>”<br />
andrebbero priv<strong>il</strong>egiate le attività volte allo sv<strong>il</strong>uppo delle ab<strong>il</strong>ità ricettive, e in particolare<br />
l’ab<strong>il</strong>ità di ascolto. Inoltre si dovrebbe poter dedicare spazio all’apprendimento del<br />
lessico, soprattutto attraverso un approccio classificatorio per associazioni semantiche (ad<br />
esempio, sinonimia, antonimia, etc.) e delle strategie cognitive, meta-cognitive e socioaffettive<br />
che favoriscono la comprensione.<br />
Abbiamo visto che per promuovere l’apprendimento è importante proporre attività<br />
che comportino la collaborazione tra pari, permettano all’apprendente di negoziare i<br />
significati e all’insegnante di capire, almeno in parte, l’universo di conoscenze da cui<br />
proviene l’apprendente.<br />
Ci rendiamo conto della difficoltà di attuazione di un tale programma, in uno spazio<br />
temporale così concentrato, ma la strada per portare a un inserimento proficuo degli<br />
<strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong> nell’università italiana è una strada in salita. Le esperienze dei vari Centri<br />
Linguistici lasciano però ben sperare.<br />
Bibliografia<br />
Ambroso, S. (2009), Innovative Aspects in the Teaching of Italian at the Somali National<br />
University, in Lesson in Survival: The <strong>La</strong>nguage and the Culture of Somalia, a cura di<br />
Puglielli, A., L’Harmanattan, Torino, pp.136-146.<br />
Bandiera, M. (2002), L’organizzazione delle conoscenze, in Qui è la nostra lingua, a cura di<br />
Puglielli, A. – Frascarelli, M. – Bonvino, E., Università degli Studi Roma Tre, Comune<br />
di Roma, Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche, CD-ROM.<br />
Bandiera, M. – Serra Borneto, C. (1994), Interazione tra lingua e pensiero scientifico:<br />
propedeutica linguistica presso l’università nazionale somala, in Lingua, pensiero<br />
scientifico e interculturalità: L’esperienza dell’interazione universitaria in Somalia,<br />
(Roma, 19 ottobre 1992) (Atti dei Convegni Lincei, 107), pp. 99-126.<br />
Consiglio d’Europa (2002), Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:<br />
apprendimento insegnamento valutazione, <strong>La</strong> Nuova Italia, M<strong>il</strong>ano.