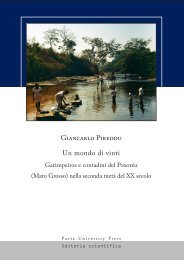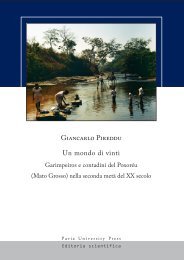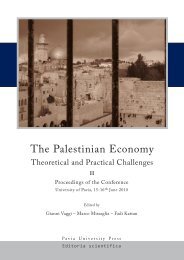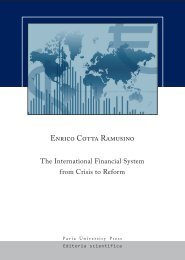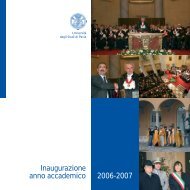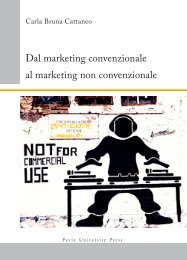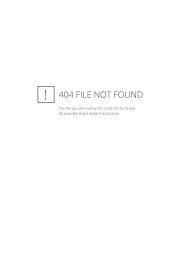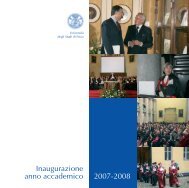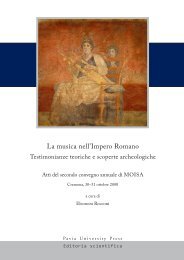La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
40<br />
Elisabetta Bonvino<br />
Il primo punto (a.) è abbastanza scontato: è banale dire che c’è bisogno di esercitare una<br />
certa ab<strong>il</strong>ità al fine di favorirne lo sv<strong>il</strong>uppo. Tuttavia, se si va a vedere, lo spazio dedicato<br />
all’ascolto di materiale autentico in classe è spesso molto poco. Gli ascolti dovrebbero<br />
essere diversificati e comportare strategie (ascolto globale, ascolto selettivo, etc.) e processi<br />
di comprensione (top-down e bottom-up) differenti. Un fattore estremamente importante per<br />
la comprensione orale è la capacità di memorizzazione. Quanto viene compreso deve<br />
rimanere in memoria per collegarsi al resto del testo ascoltato. Queste procedure,<br />
automatiche in L1, non lo sono in L2 e devono essere esercitate.<br />
Un altro fattore imprescindib<strong>il</strong>e per la comprensione è dato dal livello di<br />
competenza lessicale (b.). Il flusso sonoro viene processato in unità linguistiche, e la<br />
conoscenza delle parole aiuta tantissimo a trovare appigli per la segmentazione e la<br />
discriminazione acustica e quindi per la comprensione del testo orale. Gli <strong>studenti</strong><br />
stranieri hanno spesso un controllo molto limitato dell’italiano, specie nell’ambito delle<br />
varie discipline, <strong>il</strong> cui lessico è composto da parole astratte, rare o da termini<br />
specialistici (spesso estranei anche agli <strong>studenti</strong> italiani) e pertanto distante dagli usi<br />
dell’italiano per la comunicazione, varietà di lingua sulla quale di solito si concentrano<br />
i corsi di base. Come abbiamo già accennato, i corsi di lingua italiana dovrebbero, per<br />
quanto possib<strong>il</strong>e, introdurre gli apprendenti alla terminologia specialistica cui andranno<br />
incontro nelle diverse discipline universitarie (cfr. § 2.1).<br />
Si parla sempre di autonomia e consapevolezza dell’apprendente (c): troppo spesso<br />
però i materiali predisposti per l’ascolto nei laboratori, le risorse on-line o <strong>il</strong> lavoro di<br />
ascolto proposto in classe mettono l’apprendente in condizione di passività, mentre<br />
l’insegnante si fa spesso carico dell’intero processo di comprensione. Ad esempio, è<br />
quasi sempre l’insegnante che decide <strong>il</strong> numero di volte in cui è possib<strong>il</strong>e riascoltare un<br />
testo e che ha lo scettro dei comandi audio. Viene dedicato troppo poco tempo ad<br />
analizzare gli aspetti che non hanno funzionato nel processo di ascolto. <strong>La</strong> riflessione<br />
su ciò che impedisce la comprensione renderebbe l’apprendente consapevole di quali<br />
sono le difficoltà reali di comprensione e quali sono le strategie da mettere in atto per<br />
evitarle. Si parte dal presupposto che esista un unico modo di ascoltare qualcosa, e ci si<br />
aspetta che si debba comprendere <strong>il</strong> 100% di un testo (cosa che avviene raramente<br />
anche in lingua materna). 13 Tutto questo comporta che l’apprendente non si senta<br />
responsab<strong>il</strong>e del suo processo di apprendimento, non diventi autonomo e non si<br />
appropri delle strategie necessarie da mettere in atto nei contesti in cui sarà chiamato a<br />
capire testi orali nel mondo reale.<br />
<strong>La</strong> consapevolezza relativa al processo di comprensione può scaturire anche da un<br />
intervento mirato a rendere consci gli apprendenti delle strategie di apprendimento (d.).<br />
Andrebbero promosse attività che sv<strong>il</strong>uppino la consapevolezza delle strategie che<br />
fac<strong>il</strong>itano l’apprendimento linguistico (cfr. § 2.3). <strong>La</strong>vori sperimentali sull’ascolto (cfr.,<br />
fra gli altri, Vandergrift et al. 2006; Coşkun 2010), hanno dimostrato non solo che gli<br />
<strong>studenti</strong> che hanno maggiore consapevolezza di alcune strategie cognitive e metacognitive<br />
hanno migliori risultati nella comprensione, ma anche che accompagnare i<br />
13<br />
Gli spunti di riflessione delineati in questo paragrafo sono adattati dall’introduzione dell’interessante libro<br />
di esercizi per l’ascolto di White (1998).