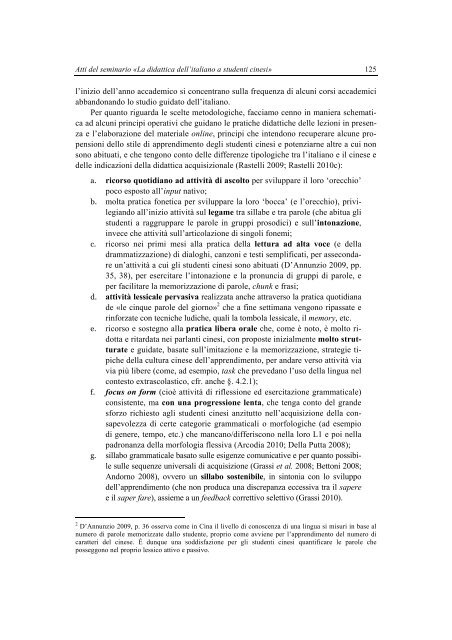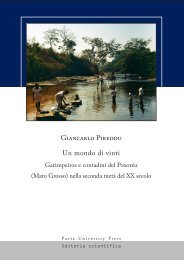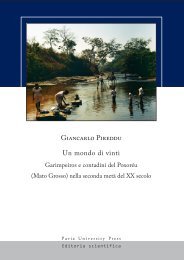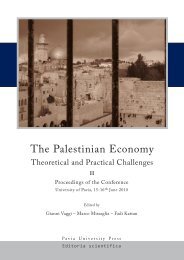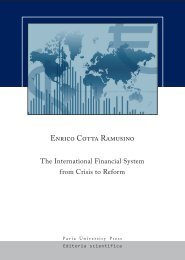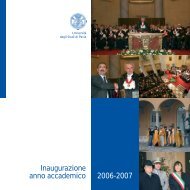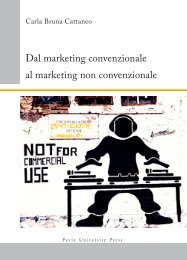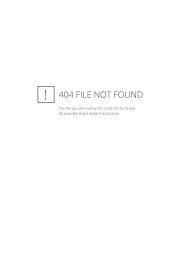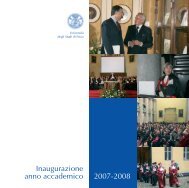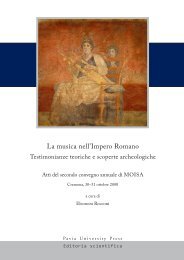La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Atti del seminario «<strong>La</strong> <strong>didattica</strong> dell’italiano a <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong>»<br />
l’inizio dell’anno accademico si concentrano sulla frequenza di alcuni corsi accademici<br />
abbandonando lo studio guidato dell’italiano.<br />
Per quanto riguarda le scelte metodologiche, facciamo cenno in maniera schematica<br />
ad alcuni principi operativi che guidano le pratiche didattiche delle lezioni in presenza<br />
e l’elaborazione del materiale online, principi che intendono recuperare alcune propensioni<br />
dello st<strong>il</strong>e di apprendimento degli <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong> e potenziarne altre a cui non<br />
sono abituati, e che tengono conto delle differenze tipologiche tra l’italiano e <strong>il</strong> cinese e<br />
delle indicazioni della <strong>didattica</strong> acquisizionale (Rastelli 2009; Rastelli 2010c):<br />
a. ricorso quotidiano ad attività di ascolto per sv<strong>il</strong>uppare <strong>il</strong> loro ‘orecchio’<br />
poco esposto all’input nativo;<br />
b. molta pratica fonetica per sv<strong>il</strong>uppare la loro ‘bocca’ (e l’orecchio), priv<strong>il</strong>egiando<br />
all’inizio attività sul legame tra s<strong>il</strong>labe e tra parole (che abitua gli<br />
<strong>studenti</strong> a raggruppare le parole in gruppi prosodici) e sull’intonazione,<br />
invece che attività sull’articolazione di singoli fonemi;<br />
c. ricorso nei primi mesi alla pratica della lettura ad alta voce (e della<br />
drammatizzazione) di dialoghi, canzoni e testi semplificati, per assecondare<br />
un’attività a cui gli <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong> sono abituati (D’Annunzio 2009, pp.<br />
35, 38), per esercitare l’intonazione e la pronuncia di gruppi di parole, e<br />
per fac<strong>il</strong>itare la memorizzazione di parole, chunk e frasi;<br />
d. attività lessicale pervasiva realizzata anche attraverso la pratica quotidiana<br />
de «le cinque parole del giorno» 2 che a fine settimana vengono ripassate e<br />
rinforzate con tecniche ludiche, quali la tombola lessicale, <strong>il</strong> memory, etc.<br />
e. ricorso e sostegno alla pratica libera orale che, come è noto, è molto ridotta<br />
e ritardata nei parlanti <strong>cinesi</strong>, con proposte inizialmente molto strutturate<br />
e guidate, basate sull’imitazione e la memorizzazione, strategie tipiche<br />
della cultura cinese dell’apprendimento, per andare verso attività via<br />
via più libere (come, ad esempio, task che prevedano l’uso della lingua nel<br />
contesto extrascolastico, cfr. anche §. 4.2.1);<br />
f. focus on form (cioè attività di riflessione ed esercitazione grammaticale)<br />
consistente, ma con una progressione lenta, che tenga conto del grande<br />
sforzo richiesto agli <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong> anzitutto nell’acquisizione della consapevolezza<br />
di certe categorie grammaticali o morfologiche (ad esempio<br />
di genere, tempo, etc.) che mancano/differiscono nella loro L1 e poi nella<br />
padronanza della morfologia flessiva (Arcodia 2010; Della Putta 2008);<br />
g. s<strong>il</strong>labo grammaticale basato sulle esigenze comunicative e per quanto possib<strong>il</strong>e<br />
sulle sequenze universali di acquisizione (Grassi et al. 2008; Bettoni 2008;<br />
Andorno 2008), ovvero un s<strong>il</strong>labo sostenib<strong>il</strong>e, in sintonia con lo sv<strong>il</strong>uppo<br />
dell’apprendimento (che non produca una discrepanza eccessiva tra <strong>il</strong> sapere<br />
e <strong>il</strong> saper fare), assieme a un feedback correttivo selettivo (Grassi 2010).<br />
2 D’Annunzio 2009, p. 36 osserva come in Cina <strong>il</strong> livello di conoscenza di una lingua si misuri in base al<br />
numero di parole memorizzate dallo studente, proprio come avviene per l’apprendimento del numero di<br />
caratteri del cinese. È dunque una soddisfazione per gli <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong> quantificare le parole che<br />
posseggono nel proprio lessico attivo e passivo.<br />
125