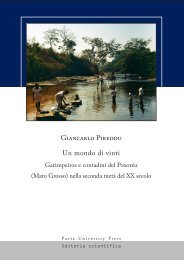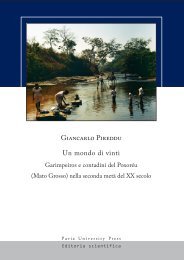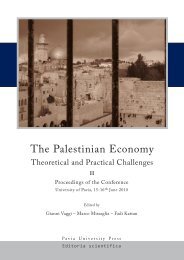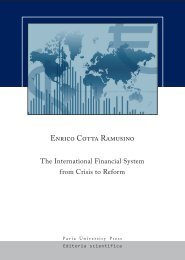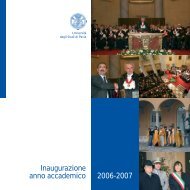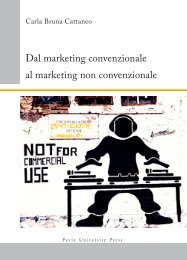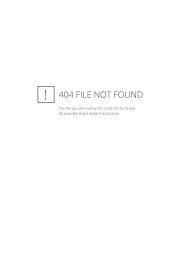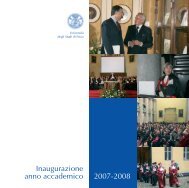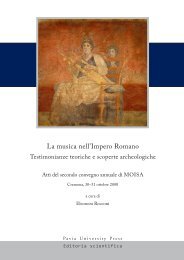La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Atti del seminario «<strong>La</strong> <strong>didattica</strong> dell’italiano a <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong>»<br />
2.1. Apprendere in una L2<br />
Nella cornice teorica del costruttivismo, la concezione di apprendimento può essere<br />
ricondotta a un modello di organizzazione delle conoscenze. L’apprendimento è un<br />
processo attivo in cui l’apprendente è un attore centrale che costruisce la conoscenza a<br />
partire dalla sua esperienza del mondo e dalle informazioni che gli derivano<br />
dall’ambiente socioculturale nel quale è inserito. Apprendere è quindi la capacità di<br />
(ri)costruire sistematicamente la rete delle proprie conoscenze selezionando fra le<br />
nuove conoscenze quelle pertinenti.<br />
L’assim<strong>il</strong>azione che ne consegue è al contempo apprendimento e modificazione<br />
dell’assetto di conoscenze: per accrescimento, quando si produce un aumento<br />
quantitativo di conoscenze all’interno degli schemi già esistenti; per messa a punto, se<br />
l’integrazione dell’informazione avviene mediante un adattamento, un assestamento<br />
degli schemi; per ristrutturazione, ovvero per creazione di nuovi schemi a seguito della<br />
soppressione di segmenti anche estesi dei vecchi schemi che si sono rivelati inadeguati<br />
o scorretti (Bandiera 2002).<br />
Ne deriva che c’è apprendimento solo se si hanno strutture di conoscenza su cui<br />
appoggiarsi. L’intervento formativo è produttivo se l’input supera le attuali competenze<br />
dell’apprendente, ma non troppo da risultargli incomprensib<strong>il</strong>e; insomma, se si situa<br />
all’interno di quell’area in cui l’apprendente può estendere le sue competenze e risolvere<br />
problemi grazie all’aiuto degli altri (si pensi al concetto di ‘zona di sv<strong>il</strong>uppo prossimale’<br />
di Vygotskij, intesa come differenza tra quello che l’apprendente sa già e quello che è <strong>il</strong><br />
suo sv<strong>il</strong>uppo potenziale). Se si parte da questa concezione dell’apprendimento, allora per<br />
l’apprendente è importante riuscire a trovare, all’interno delle conoscenze già in suo<br />
possesso in un determinato ambito, degli ‘agganci’ affinché le nuove conoscenze non<br />
scivolino via. 6<br />
Tali riflessioni di carattere teorico ci portano ad alcune considerazioni che riguardano<br />
la prima fase del percorso degli <strong>studenti</strong> <strong>Marco</strong> <strong>Polo</strong> (i corsi di lingua italiana).<br />
In primo luogo, l’impatto principale degli <strong>studenti</strong> con <strong>il</strong> mondo italiano<br />
dell’insegnamento è costituito dal corso di lingua. Sarebbe importante tener conto dell’assetto<br />
delle conoscenze dei vari apprendenti <strong>cinesi</strong> riguardo proprio all’apprendimento della lingua,<br />
non tanto per quanto attiene ai contenuti, quanto per l’approccio didattico e le tecniche<br />
ut<strong>il</strong>izzate. Sappiamo che <strong>il</strong> modo di insegnare/apprendere le lingue in Cina segue spesso<br />
vie diverse da quelle che ormai si sono imposte in larga parte dell’occidente. Il ruolo<br />
del docente è profondamente diverso, ma anche <strong>il</strong> modo di apprendere è diverso. Non<br />
intendiamo in questa sede addentrarci in complesse questioni interculturali. È stato<br />
comunque più volte notato nel corso delle varie esperienze “<strong>Marco</strong> <strong>Polo</strong>” che<br />
l’approccio comunicativo crea all’inizio un effetto di spaesamento notevole negli<br />
<strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong>. Per questo sarebbe fondamentale per i primi tempi affiancare gli<br />
<strong>studenti</strong> ad altri <strong>studenti</strong> <strong>cinesi</strong> già inseriti nell’università italiana o a mediatori italiani<br />
esperti del mondo della formazione in Cina (come avviene a Roma Tre), oppure,<br />
addirittura affidare la prima parte del corso a un insegnante cinese che fornisca – nelle<br />
6 Cfr. Bandiera – Borneto (1992) e si veda l’esperimento condotto da Bandiera in Puglielli et al. (2002).<br />
37