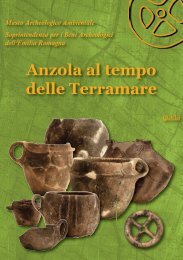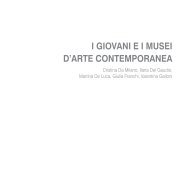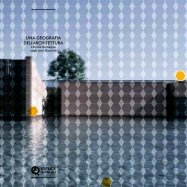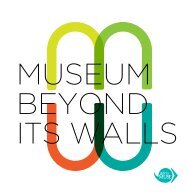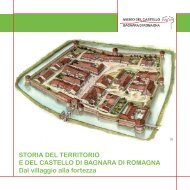Musei in Emilia-Romagna - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e ...
Musei in Emilia-Romagna - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e ...
Musei in Emilia-Romagna - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Prov<strong>in</strong>cia di Ferrara MUSEI IN EMILIA-ROMAGNA<br />
131<br />
20<br />
Ferrara<br />
Palazz<strong>in</strong>a di Marfisa d’Este<br />
La palazz<strong>in</strong>a fu edificata <strong>in</strong>torno al 1559<br />
<strong>per</strong> Francesco I d’Este, marchese di<br />
Massalombarda, figlio di Alfonso I e di<br />
Lucrezia Borgia. Dal 1578 la dimora<br />
passò <strong>in</strong> eredità alla figlia naturale di<br />
Francesco, Marfisa, sposata <strong>in</strong> seconde<br />
nozze al pr<strong>in</strong>cipe di Massa Carrara Alderano<br />
Cybo.<br />
Il ritratto di Marfisa bamb<strong>in</strong>a figura di<br />
fronte a quello della sorella Bradamante<br />
negli affreschi della loggetta, attribuiti<br />
a Camillo Filippi, che nella seconda<br />
metà del XVI secolo eseguì le grottesche<br />
sulle volte dell’edificio, <strong>in</strong> collaborazione<br />
con i pittori della sua bottega.<br />
L’avvicendarsi degli affittuari e i successivi<br />
passaggi di proprietà determ<strong>in</strong>arono,<br />
dalla metà del XVII secolo, crescenti<br />
livelli di degrado dell’<strong>in</strong>tero complesso,<br />
acquistato <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, nel 1861, dal<br />
Comune di Ferrara. All’<strong>in</strong>izio del Novecento,<br />
grazie all’impegno di Giuseppe<br />
Agnelli - direttore della Biblioteca - e<br />
dell’Associazione “Ferrariae Decus” da<br />
lui promossa, fu avviato, con fondi<br />
Ferrara, Palazz<strong>in</strong>a di Marfisa d’Este: Loggia<br />
degli aranci<br />
comunali e non, il progetto di recu<strong>per</strong>o<br />
degli edifici.<br />
Tra il 1910 e il 1915 le decorazioni orig<strong>in</strong>arie<br />
dovute a Camillo, Cesare e Sebastiano<br />
Filippi e alla loro bottega, vennero<br />
<strong>in</strong> gran parte ridip<strong>in</strong>te da Giuseppe<br />
Mazzolani e Enrico Giberti (il restauro<br />
sarebbe stato completato nel ’38 da<br />
Augusto Pagliar<strong>in</strong>i).<br />
I lavori ripresero nel 1937 con l’affidamento<br />
all’<strong>in</strong>gegner Savonuzzi del progetto<br />
di riprist<strong>in</strong>o degli edifici, che a partire<br />
dal 1938 furono dest<strong>in</strong>ati alla rievocazione<br />
museale di una dimora c<strong>in</strong>quecentesca,<br />
secondo una proposta di N<strong>in</strong>o<br />
Barbant<strong>in</strong>i, responsabile dei musei civici<br />
di Venezia e ord<strong>in</strong>atore di Cà Rezzonico.<br />
Perduti gli arredi orig<strong>in</strong>ari, Barbant<strong>in</strong>i<br />
allestì la casa museo con mobili<br />
re<strong>per</strong>iti sul mercato antiquario, molti<br />
dei quali provenienti dalla collezione<br />
veneziana Donà delle Rose. Oltre ad<br />
armadi, cassoni, tavoli e credenze, <strong>in</strong><br />
prevalenza di età compresa tra il XVI<br />
ed il XVII secolo, nel museo figurano<br />
dip<strong>in</strong>ti e sculture come il marmoreo<br />
Busto di Ercole I d’Este, eseguito <strong>per</strong><br />
la Porta degli Angeli dal mantovano<br />
S<strong>per</strong>andio di Bartolomeo Savelli e l’altorilievo<br />
<strong>in</strong> marmo, attribuito alla bottega<br />
di Antonio Lombardi, con la Madonna<br />
<strong>in</strong> trono col Bamb<strong>in</strong>o, S. Giorgio<br />
e il committente, forse identificabile<br />
con Alfonso I.<br />
La decorazione del pavimento orig<strong>in</strong>ario<br />
è documentata da alcune piastrelle<br />
di ceramica, esposte nelle vetr<strong>in</strong>e dell’ultima<br />
sala.<br />
L’ampio giard<strong>in</strong>o, che un tempo collegava<br />
l’<strong>in</strong>tero complesso con Palazzo<br />
Bonacossi, ospita la Loggia degli Aranci,<br />
esempio di <strong>per</strong>golato dip<strong>in</strong>to a<strong>per</strong>to<br />
illusivamente su un f<strong>in</strong>to sfondato.<br />
Amor<strong>in</strong>i musicanti si affacciano dal soffitto<br />
dell’antiloggia, decorata a paesaggi.<br />
Scene di caccia e di pesca sono raffigurate<br />
nella Sala della Grotta.<br />
(m.g.)<br />
R. Varese, Ferrara. Palazz<strong>in</strong>a di Marfisa, Bologna<br />
1980; A.M. Visser Travagli, Palazzo Schifanoia<br />
e palazz<strong>in</strong>a Marfisa a Ferrara, Milano<br />
1991; A.M. Visser Travagli (a cura), Palazz<strong>in</strong>a<br />
di Marfisa d’Este a Ferrara, Roma 1996.<br />
21<br />
Ferrara<br />
Casa dell’Ariosto<br />
All’<strong>in</strong>terno dell’edificio, che risale al<br />
1528, forse su progetto del pittore e<br />
architetto Girolamo da Carpi, è <strong>in</strong> fase<br />
di ord<strong>in</strong>amento un <strong>per</strong>corso museale<br />
dedicato a Ludovico Ariosto. La casa fu<br />
costruita <strong>per</strong> lo stesso Ariosto che sulla<br />
porta d’<strong>in</strong>gresso fece <strong>in</strong>cidere la celebre<br />
iscrizione: Parva sed apta mihi,<br />
sed nulli obnoxia, sed non sordida,<br />
parta meo sed tamen aere domus.<br />
Il prospetto, con due lesene angolari<br />
sovrapposte, mostra i tipici caratteri<br />
della sobria architettura presente nell’edilizia<br />
m<strong>in</strong>ore ferrarese. Passata ai<br />
conti Pompili di Ravenna, la casa fu<br />
qu<strong>in</strong>di ceduta al Cittadella nel 1747 e<br />
successivamente, nel 1811, venne acquistata<br />
dal Comune di Ferrara. Gli ambienti<br />
<strong>in</strong>terni dell’edificio conservano<br />
tuttora le caratteristiche orig<strong>in</strong>ali del<br />
tempo dell’Ariosto, oltre a mobili ed arredi<br />
di pregio.<br />
(e.l.)<br />
22<br />
Ferrara<br />
Museo Bold<strong>in</strong>i<br />
Assieme alle raccolte dell’Ottocento ed<br />
alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea<br />
“Filippo de Pisis”, il museo ha<br />
sede nel Palazzo Bevilacqua-Massari,<br />
sorto alla f<strong>in</strong>e del C<strong>in</strong>quecento e ampliato<br />
nel corso del Settecento con la costruzione<br />
dell’adiacente Palazz<strong>in</strong>a “dei<br />
Cavalieri di Malta” - uno dei pochissimi<br />
esempi di architettura neoclassica a<br />
Ferrara - la realizzazione del parco e l’edificazione<br />
della Coffee-house.<br />
Nel 1860 il palazzo fu acquistato dai conti<br />
Massari.<br />
Nel dopoguerra l’edificio divenne proprietà<br />
del Comune di Ferrara che, nel<br />
1975, dopo gli opportuni restauri, lo<br />
dest<strong>in</strong>ò a sede dei musei di arte moderna.<br />
Il complesso di Palazzo Massari comprende<br />
anche il Padiglione d’Arte Contemporanea,<br />
situato nel giard<strong>in</strong>o e de-