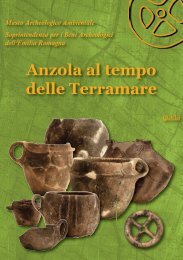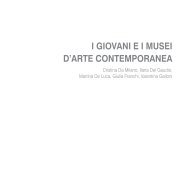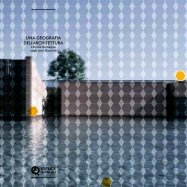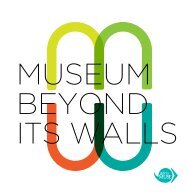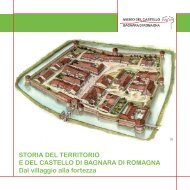Musei in Emilia-Romagna - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e ...
Musei in Emilia-Romagna - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e ...
Musei in Emilia-Romagna - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Prov<strong>in</strong>cia di Parma MUSEI IN EMILIA-ROMAGNA<br />
33<br />
luoghi che furono teatro degli avvenimenti.<br />
Si tratta <strong>in</strong> prevalenza di fotografie,<br />
ritratti dei partigiani che o<strong>per</strong>avano<br />
nel territorio parmense, scene della<br />
Liberazione, immag<strong>in</strong>i dei cippi eretti<br />
<strong>in</strong> ambito comunale.<br />
Il <strong>per</strong>corso espositivo è corredato da<br />
pannelli didascalici che illustrano le diverse<br />
tipologie delle armi usate dai partigiani<br />
e da alcune copie di documenti<br />
dell’epoca.<br />
(p.t.)<br />
15<br />
Parma<br />
Museo Archeologico Nazionale<br />
Allestito nel Palazzo della Pilotta, venne<br />
costituito nel 1761 come Museo Ducale<br />
d’Antichità da don Filippo di Borbone<br />
il quale, emulo del fratello, promotore<br />
delle campagne archeologiche<br />
di Ercolano e Pompei, volle dare sistemazione<br />
ai re<strong>per</strong>ti r<strong>in</strong>venuti nel corso<br />
degli scavi avviati dal 1760 a Mac<strong>in</strong>esso,<br />
<strong>in</strong> prossimità della città romana di<br />
Veleia. Qui, nel 1747, era stata ritrovata<br />
la Tabula Alimentaria, la più grande<br />
iscrizione <strong>in</strong> bronzo dell’età romana.<br />
La raccolta si configura qu<strong>in</strong>di nell’Italia<br />
settentrionale come uno dei primi<br />
esempi di museo dest<strong>in</strong>ato a f<strong>in</strong>i conservativi<br />
<strong>in</strong> funzione di specifici r<strong>in</strong>venimenti<br />
nel territorio.<br />
Oltre al nucleo orig<strong>in</strong>ario costituito dai<br />
re<strong>per</strong>ti di Veleia, il patrimonio archeologico<br />
della Pilotta comprende anche<br />
altri materiali di provenienza locale,<br />
accorpati prima del 1785 dal direttore<br />
Paciaudi a Luceria, vic<strong>in</strong>o a Reggio <strong>Emilia</strong>,<br />
Parma e Fornovo. Più tardi si aggiungevano<br />
oggetti già appartenuti ai<br />
Farnese e ai Gonzaga, mentre le raccolte<br />
numismatiche andavano aumentando<br />
<strong>in</strong> seguito alle acquisizioni di<br />
monete provenienti da collezioni private,<br />
da Montechiarugolo, Chiaravalle e<br />
Lodi. La sistemazione attuale del <strong>per</strong>corso<br />
espositivo, che risale agli anni<br />
Sessanta, distribuisce su due piani le<br />
collezioni del museo. Al piano terreno<br />
sono ord<strong>in</strong>ate le raccolte preistoriche<br />
messe <strong>in</strong>sieme tra il 1867 e il 1875 sotto<br />
la direzione dell’archeologo di Fontanellato<br />
Luigi Pigor<strong>in</strong>i, annoverato<br />
<strong>in</strong>sieme al Chierici e allo Strobel tra i<br />
fondatori della paletnologia italiana. In<br />
questa sezione sono conservati i resti<br />
della palafitta terramaricola di Parma,<br />
dell’<strong>in</strong>sediamento palafitticolo di Castione<br />
dei Marchesi, oltre a ceramiche,<br />
bronzi e manufatti <strong>in</strong> osso provenienti<br />
dal Castellazzo di Fontanellato. Al primo<br />
piano si trovano sculture, suppellettili,<br />
vetri e monete di arte greca,<br />
romana, italiota ed etrusca di provenienza<br />
non locale, la raccolta egizia, nella<br />
quale si segnala il frammento della<br />
tomba del XV secolo a.C. proveniente<br />
da Menphi e, nella sesta sala, l’<strong>in</strong>sieme<br />
dei bronzi di Veleia, preceduto da un<br />
ciclo statuario di dodici sculture r<strong>in</strong>venute<br />
nella basilica della città romana.<br />
Tra i pezzi più rilevanti della raccolta si<br />
ricordano, oltre alla Tabula del II secolo<br />
d.C., un’altra tavola bronzea con frammenti<br />
della lex de Gallia Cisalp<strong>in</strong>a, il presunto<br />
ritratto di Anton<strong>in</strong>o Pio, un ritratto<br />
di giov<strong>in</strong>etta della f<strong>in</strong>e del I secolo d.C.<br />
e l’Ercole ebbro del II secolo d.C.<br />
Un’apposita sezione è dedicata ai resti<br />
di Parma romana e tardoantica, documentata<br />
da stele funerarie, iscrizioni,<br />
pavimentazioni musive e da oreficerie di<br />
età longobarda.<br />
(m.l.p.)<br />
A. Frova, R. Scarani, Parma. Museo Nazionale<br />
di Antichità, Parma 1965; E. Buffi, G. Lanzoni,<br />
Le monete puniche del Museo Archeologico<br />
Nazionale di Parma, «Rivista di Studi Fenici»,<br />
9, 1981, pp. 99-120; M. Calvani Mar<strong>in</strong>i, Il ruolo<br />
del Museo d’Antichità di Parma dagli scavi<br />
borbonici a Veleia alle ricerche della nascente<br />
paletnologia italiana, <strong>in</strong> C. Morigi Govi, G.<br />
Sassatelli (a cura), Dalla Stanza delle Antichità<br />
al Museo Civico. Storia della formazione del<br />
Museo Civico Archeologico di Bologna, Bologna<br />
1984, pp. 483-492; C. Bolondi, L. Laurencich<br />
M<strong>in</strong>elli, La Collezione etnografica del Museo di<br />
Parma, <strong>in</strong> B. Brea, A. Mutti (a cura), ...Le terramare<br />
si scavano <strong>per</strong> concimare i campi...,<br />
Parma 1994, pp. 199-207.<br />
Parma, Galleria Nazionale: Teatro Farnese<br />
16<br />
Parma<br />
Galleria Nazionale<br />
La galleria, che ha orig<strong>in</strong>e dalle collezioni<br />
dell’Accademia di Belle Arti istituita<br />
nel 1752 dal duca don Filippo di<br />
Borbone, è ospitata all’<strong>in</strong>terno del<br />
Palazzo della Pilotta. Il monumentale<br />
complesso, che trae la sua denom<strong>in</strong>azione<br />
dal gioco basco della “pelota”, fu<br />
voluto da Ranuccio I Farnese come<br />
struttura di raccordo con la residenza<br />
ducale. Iniziato nella seconda metà del<br />
XVI secolo su progetto di Giovanni<br />
Boscoli, ma rimasto <strong>in</strong>compiuto, fu<br />
ampliato nel 1583 da Francesco Paciotto.<br />
Fra il 1602 e il 1611 vennero realiz-