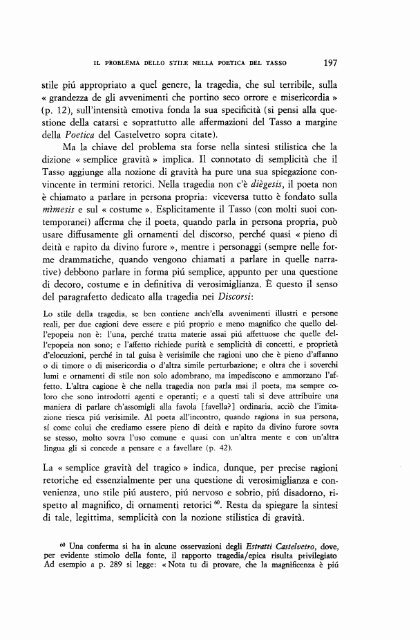U S M F L P u bblicazion i della Facoltà di Lettere e Filosofia La ...
U S M F L P u bblicazion i della Facoltà di Lettere e Filosofia La ...
U S M F L P u bblicazion i della Facoltà di Lettere e Filosofia La ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IL PROBLEMA DELLO STILE NELLA POETICA DEL TASSO 197<br />
stile più appropriato a quel genere, la trage<strong>di</strong>a, che sul terribile, sulla<br />
« grandezza de gli avvenimenti che portino seco orrore e misericor<strong>di</strong>a »<br />
(p. 12), sull'intensità emotiva fonda la sua specificità (si pensi alla que<br />
stione <strong>della</strong> catarsi e soprattutto alle affermazioni del Tasso a margine<br />
<strong>della</strong> Poetica del Castelvetro sopra citate).<br />
Ma la chiave del problema sta forse nella sintesi stilistica che la<br />
<strong>di</strong>zione « semplice gravita » implica. Il connotato <strong>di</strong> semplicità che il<br />
Tasso aggiunge alla nozione <strong>di</strong> gravita ha pure una sua spiegazione con<br />
vincente in termini retorici. Nella trage<strong>di</strong>a non c'è <strong>di</strong>ègesis, il poeta non<br />
è chiamato a parlare in persona propria: viceversa tutto è fondato sulla<br />
mìmesis e sul « costume ». Esplicitamente il Tasso (con molti suoi con<br />
temporanei) afferma che il poeta, quando parla in persona propria, può<br />
usare <strong>di</strong>ffusamente gli ornamenti del <strong>di</strong>scorso, perché quasi « pieno <strong>di</strong><br />
deità e rapito da <strong>di</strong>vino furore », mentre i personaggi (sempre nelle for<br />
me drammatiche, quando vengono chiamati a parlare in quelle narra<br />
tive) debbono parlare in forma più semplice, appunto per una questione<br />
<strong>di</strong> decoro, costume e in definitiva <strong>di</strong> verosimiglianza. È questo il senso<br />
del paragrafetto de<strong>di</strong>cato alla trage<strong>di</strong>a nei Discorsi:<br />
Lo stile <strong>della</strong> trage<strong>di</strong>a, se ben contiene anch'ella avvenimenti illustri e persone<br />
reali, per due cagioni deve essere e più proprio e meno magnifico che quello del-<br />
l'epopeia non è: l'una, perché tratta materie assai più affettuose che quelle del-<br />
l'epopeia non sono; e l'affetto richiede purità e semplicità <strong>di</strong> concetti, e proprietà<br />
d'elocuzioni, perché in tal guisa è verisimile che ragioni uno che è pieno d'affanno<br />
o <strong>di</strong> timore o <strong>di</strong> misericor<strong>di</strong>a o d'altra simile perturbazione; e oltra che i soverchi<br />
lumi e ornamenti <strong>di</strong> stile non solo adombrano, ma impe<strong>di</strong>scono e ammorzano l'af<br />
fetto. L'altra cagione è che nella trage<strong>di</strong>a non parla mai il poeta, ma sempre co<br />
loro che sono introdotti agenti e operanti; e a questi tali si deve attribuire una<br />
maniera <strong>di</strong> parlare ch'assomigli alla favola [favella?] or<strong>di</strong>naria, acciò che l'imita<br />
zione riesca più verisimile. Al poeta all'incontro, quando ragiona in sua persona,<br />
si come colui che cre<strong>di</strong>amo essere pieno <strong>di</strong> deità e rapito da <strong>di</strong>vino furore sovra<br />
se stesso, molto sovra l'uso comune e quasi con un'altra mente e con un'altra<br />
lingua gli si concede a pensare e a favellare (p. 42).<br />
<strong>La</strong> « semplice gravita del tragico » in<strong>di</strong>ca, dunque, per precise ragioni<br />
retoriche ed essenzialmente per una questione <strong>di</strong> verosimiglianza e con<br />
venienza, uno stile più austero, più nervoso e sobrio, più <strong>di</strong>sadorno, ri<br />
spetto al magnifico, <strong>di</strong> ornamenti retorici 60 . Resta da spiegare la sintesi<br />
<strong>di</strong> tale, legittima, semplicità con la nozione stilistica <strong>di</strong> gravita.<br />
60 Una conferma si ha in alcune osservazioni degli Estratti Castelvetro, dove,<br />
per evidente stimolo <strong>della</strong> fonte, il rapporto trage<strong>di</strong>a/epica risulta privilegiato<br />
Ad esempio a p. 289 si legge: « Nota tu <strong>di</strong> provare, che la magnificenza è più