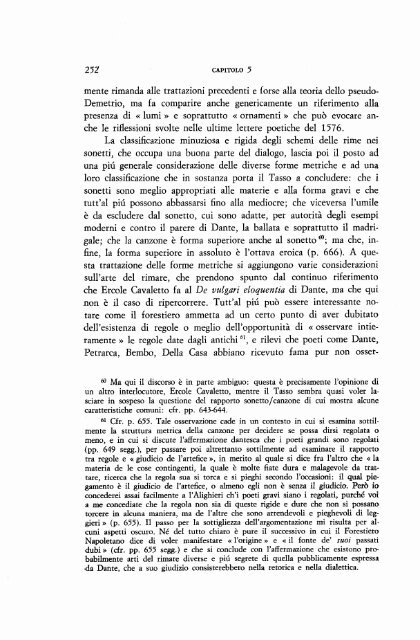U S M F L P u bblicazion i della Facoltà di Lettere e Filosofia La ...
U S M F L P u bblicazion i della Facoltà di Lettere e Filosofia La ...
U S M F L P u bblicazion i della Facoltà di Lettere e Filosofia La ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
252 CAPITOLO 5<br />
mente rimanda alle trattazioni precedenti e forse alla teoria dello pseudo-<br />
Demetrio, ma fa comparire anche genericamente un riferimento alla<br />
presenza <strong>di</strong> « lumi » e soprattutto « ornamenti » che può evocare an<br />
che le riflessioni svolte nelle ultime lettere poetiche del 1576.<br />
<strong>La</strong> classificazione minuziosa e rigida degli schemi delle rime nei<br />
sonetti, che occupa una buona parte del <strong>di</strong>alogo, lascia poi il posto ad<br />
una più generale considerazione delle <strong>di</strong>verse forme metriche e ad una<br />
loro classificazione che in sostanza porta il Tasso a concludere: che i<br />
sonetti sono meglio appropriati alle materie e alla forma gravi e che<br />
tutt'al più possono abbassarsi fino alla me<strong>di</strong>ocre; che viceversa l'umile<br />
è da escludere dal sonetto, cui sono adatte, per autorità degli esempi<br />
moderni e contro il parere <strong>di</strong> Dante, la ballata e soprattutto il madri<br />
gale; che la canzone è forma superiore anche al sonetto 60 ; ma che, in<br />
fine, la forma superiore in assoluto è l'ottava eroica (p. 666). A que<br />
sta trattazione delle forme metriche si aggiungono varie considerazioni<br />
sull'arte del rimare, che prendono spunto dal continuo riferimento<br />
che Èrcole Cavaletto fa al De vulgari eloquentia <strong>di</strong> Dante, ma che qui<br />
non è il caso <strong>di</strong> ripercorrere. Tutt'al più può essere interessante no<br />
tare come il forestiero ammetta ad un certo punto <strong>di</strong> aver dubitato<br />
dell'esistenza <strong>di</strong> regole o meglio dell'opportunità <strong>di</strong> « osservare intie-<br />
ramente » le regole date dagli antichi 61 , e rilevi che poeti come Dante,<br />
Petrarca, Bembo, Della Casa abbiano ricevuto fama pur non osser-<br />
60 Ma qui il <strong>di</strong>scorso è in parte ambiguo: questa è precisamente l'opinione <strong>di</strong><br />
un altro interlocutore, Èrcole Cavaletto, mentre il Tasso sembra quasi voler la<br />
sciare in sospeso la questione del rapporto sonetto/canzone <strong>di</strong> cui mostra alcune<br />
caratteristiche comuni: cfr. pp. 643-644.<br />
61 Cfr. p. 655. Tale osservazione cade in un contesto in cui si esamina sottil<br />
mente la struttura metrica <strong>della</strong> canzone per decidere se possa <strong>di</strong>rsi regolata o<br />
meno, e in cui si <strong>di</strong>scute l'affermazione dantesca che i poeti gran<strong>di</strong> sono regolati<br />
{pp. 649 segg.), per passare poi altrettanto sottilmente ad esaminare il rapporto<br />
tra regole e « giu<strong>di</strong>cio de l'artefice », in merito al quale si <strong>di</strong>ce fra l'altro che « la<br />
materia de le cose contingenti, la quale è molte fiate dura e malagevole da trat<br />
tare, ricerca che la regola sua si torca e si pieghi secondo l'occasioni: il qua! pie<br />
gamento è il giu<strong>di</strong>cio de l'artefice, o almeno egli non è senza il giu<strong>di</strong>cio. Però io<br />
concederei assai facilmente a l'Alighieri ch'i poeti gravi siano i regolati, purché voi<br />
a me conce<strong>di</strong>ate che la regola non sia <strong>di</strong> queste rigide e dure che non si possano<br />
torcere in alcuna maniera, ma de l'altre che sono arrendevoli e pieghevoli <strong>di</strong> leg-<br />
gieri » (p. 655). Il passo per la sottigliezza dell'argomentazione mi risulta per al<br />
cuni aspetti oscuro. Né del tutto chiaro è pure il successivo in cui il Forestiero<br />
Napoletano <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> voler manifestare « l'origine » e « il fonte de' suoi passati<br />
dubi » (cfr. pp. 655 segg.) e che si conclude con l'affermazione che esistono pro<br />
babilmente arti del rimare <strong>di</strong>verse e più segrete <strong>di</strong> quella pubblicamente espressa<br />
•da Dante, che a suo giu<strong>di</strong>zio consisterebbero nella retorica e nella <strong>di</strong>alettica.