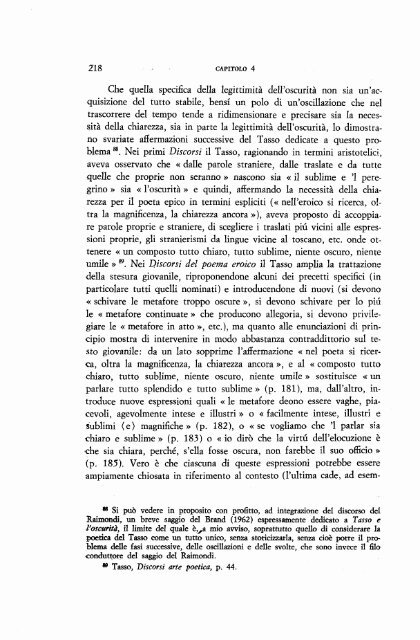U S M F L P u bblicazion i della Facoltà di Lettere e Filosofia La ...
U S M F L P u bblicazion i della Facoltà di Lettere e Filosofia La ...
U S M F L P u bblicazion i della Facoltà di Lettere e Filosofia La ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
218 CAPITOLO 4<br />
Che quella specifica <strong>della</strong> legittimità dell'oscurità non sia un'ac<br />
quisizione del tutto stabile, bensì un polo <strong>di</strong> un'oscillazione che nel<br />
trascorrere del tempo tende a ri<strong>di</strong>mensionare e precisare sia la neces<br />
sità <strong>della</strong> chiarezza, sia in parte la legittimità dell'oscurità, lo <strong>di</strong>mostra<br />
no svariate affermazioni successive del Tasso de<strong>di</strong>cate a questo pro<br />
blema 88 . Nei primi Discorsi il Tasso, ragionando in termini aristotelici,<br />
aveva osservato che « dalle parole straniere, dalle traslate e da tutte<br />
quelle che proprie non scranne » nascono sia « il sublime e '1 pere<br />
grino » sia « l'oscurità » e quin<strong>di</strong>, affermando la necessità <strong>della</strong> chia<br />
rezza per il poeta epico in termini espliciti (« nell'eroico si ricerca, ol-<br />
tra la magnificenza, la chiarezza ancora »), aveva proposto <strong>di</strong> accoppia<br />
re parole proprie e straniere, <strong>di</strong> scegliere i traslati più vicini alle espres<br />
sioni proprie, gli stranierismi da lingue vicine al toscano, etc. onde ot<br />
tenere « un composto tutto chiaro, tutto sublime, niente oscuro, niente<br />
umile » 89. Nei Discorsi del poema eroico il Tasso amplia la trattazione<br />
<strong>della</strong> stesura giovanile, riproponendone alcuni dei precetti specifici (in<br />
particolare tutti quelli nominati) e introducendone <strong>di</strong> nuovi (si devono<br />
« schivare le metafore troppo oscure », si devono schivare per lo più<br />
le « metafore continuate » che producono allegoria, si devono privile<br />
giare le « metafore in atto », etc.), ma quanto alle enunciazioni <strong>di</strong> prin<br />
cipio mostra <strong>di</strong> intervenire in modo abbastanza contrad<strong>di</strong>ttorio sul te<br />
sto giovanile: da un lato sopprime l'affermazione « nel poeta si ricer<br />
ca, oltra la magnificenza, la chiarezza ancora », e al « composto tutto<br />
chiaro, tutto sublime, niente oscuro, niente umile » sostituisce « un<br />
parlare tutto splen<strong>di</strong>do e tutto sublime » (p. 181), ma, dall'altro, in<br />
troduce nuove espressioni quali « le metafore deono essere vaghe, pia<br />
cevoli, agevolmente intese e illustri » o « facilmente intese, illustri e<br />
Sublimi (e) magnifiche » (p. 182), o «se vogliamo che '1 parlar sia<br />
chiaro e sublime» (p. 183) o «io <strong>di</strong>rò che la virtù dell'elocuzione è<br />
che sia chiara, perché, s'ella fosse oscura, non farebbe il suo officio »<br />
(p. 185). Vero è che ciascuna <strong>di</strong> queste espressioni potrebbe essere<br />
ampiamente chiosata in riferimento al contesto (l'ultima cade, ad esem-<br />
88 Si può vedere in proposito con profitto, ad integrazione del <strong>di</strong>scorso del<br />
Raimon<strong>di</strong>, un breve saggio del Brand (1962) espressamente de<strong>di</strong>cato a Tasso e<br />
l'oscurità, il limite del quale èva mio avviso, soprattutto quello <strong>di</strong> considerare la<br />
poetica del Tasso come un tutto unico, senza storicizzarla, senza cioè porre il pro<br />
blema delle fasi successive, delle oscillazioni e delle svolte, che sono invece il filo<br />
conduttore del saggio del Raimon<strong>di</strong>.<br />
89 Tasso, Discorsi arte poetica, p. 44.