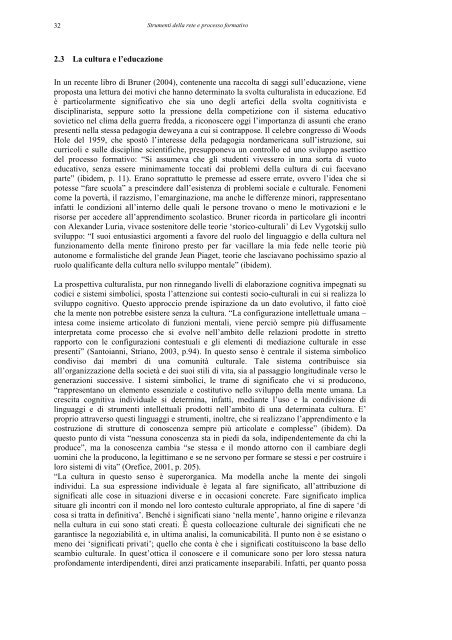32Strumenti della rete e processo formativo2.3 La cultura e l’educazioneIn un recente libro <strong>di</strong> Bruner (2004), contenente una raccolta <strong>di</strong> saggi sull’educazione, vieneproposta una lettura dei motivi che hanno determinato la svolta culturalista in educazione. Edè particolarmente significativo che sia uno <strong>degli</strong> artefici della svolta cognitivista e<strong>di</strong>sciplinarista, seppure sotto la pressione della competizione con il sistema educativosovietico nel clima della guerra fredda, a riconoscere oggi l’importanza <strong>di</strong> assunti che eranopresenti nella stessa pedagogia deweyana a cui si contrappose. Il celebre congresso <strong>di</strong> WoodsHole del 1959, che spostò l’interesse della pedagogia nordamericana sull’istruzione, suicurricoli e sulle <strong>di</strong>scipline scientifiche, presupponeva un controllo ed uno sviluppo asetticodel processo formativo: “Si assumeva che gli studenti vivessero in una sorta <strong>di</strong> vuotoeducativo, senza essere minimamente toccati dai problemi della cultura <strong>di</strong> cui facevanoparte” (ibidem, p. 11). Erano soprattutto le premesse ad essere errate, ovvero l’idea che sipotesse “fare scuola” a prescindere dall’esistenza <strong>di</strong> problemi sociale e culturale. Fenomenicome la povertà, il razzismo, l’emarginazione, ma anche le <strong>di</strong>fferenze minori, rappresentanoinfatti le con<strong>di</strong>zioni all’interno delle quali le persone trovano o meno le motivazioni e lerisorse per accedere all’appren<strong>di</strong>mento scolastico. Bruner ricorda in particolare gli incontricon Alexander Luria, vivace sostenitore delle teorie ‘storico-culturali’ <strong>di</strong> Lev Vygotskij sullosviluppo: “I suoi entusiastici argomenti a favore del ruolo del linguaggio e della cultura nelfunzionamento della mente finirono presto per far vacillare la mia fede nelle teorie piùautonome e formalistiche del grande Jean Piaget, teorie che lasciavano pochissimo spazio alruolo qualificante della cultura nello sviluppo mentale” (ibidem).La prospettiva culturalista, pur non rinnegando livelli <strong>di</strong> elaborazione cognitiva impegnati suco<strong>di</strong>ci e sistemi simbolici, sposta l’attenzione sui contesti socio-culturali in cui si realizza losviluppo cognitivo. Questo approccio prende ispirazione da un dato evolutivo, il fatto cioèche la mente non potrebbe esistere senza la cultura. “La configurazione intellettuale umana –intesa come insieme articolato <strong>di</strong> funzioni mentali, viene perciò sempre più <strong>di</strong>ffusamenteinterpretata come processo che si evolve nell’ambito delle relazioni prodotte in strettorapporto con le configurazioni contestuali e gli elementi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione culturale in essepresenti” (Santoianni, Striano, 2003, p.94). In questo senso è centrale il sistema simbolicocon<strong>di</strong>viso dai membri <strong>di</strong> una comunità culturale. Tale sistema contribuisce siaall’organizzazione della società e dei suoi stili <strong>di</strong> vita, sia al passaggio longitu<strong>di</strong>nale verso legenerazioni successive. I sistemi simbolici, le trame <strong>di</strong> significato che vi si producono,“rappresentano un elemento essenziale e costitutivo nello sviluppo della mente umana. Lacrescita cognitiva in<strong>di</strong>viduale si determina, infatti, me<strong>di</strong>ante l’uso e la con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong>linguaggi e <strong>di</strong> strumenti intellettuali prodotti nell’ambito <strong>di</strong> una determinata cultura. E’proprio attraverso questi linguaggi e strumenti, inoltre, che si realizzano l’appren<strong>di</strong>mento e lacostruzione <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> conoscenza sempre più articolate e complesse” (ibidem). Daquesto punto <strong>di</strong> vista “nessuna conoscenza sta in pie<strong>di</strong> da sola, in<strong>di</strong>pendentemente da chi laproduce”, ma la conoscenza cambia “se stessa e il mondo attorno con il cambiare <strong>degli</strong>uomini che la producono, la legittimano e se ne servono per formare se stessi e per costruire iloro sistemi <strong>di</strong> vita” (Orefice, 2001, p. 205).“La cultura in questo senso è superorganica. Ma modella anche la mente dei singoliin<strong>di</strong>vidui. La sua espressione in<strong>di</strong>viduale è legata al fare significato, all’attribuzione <strong>di</strong>significati alle cose in situazioni <strong>di</strong>verse e in occasioni concrete. Fare significato implicasituare gli incontri con il mondo nel loro contesto culturale appropriato, al fine <strong>di</strong> sapere ‘<strong>di</strong>cosa si tratta in definitiva’. Benché i significati siano ‘nella mente’, hanno origine e rilevanzanella cultura in cui sono stati creati. È questa collocazione culturale dei significati che negarantisce la negoziabilità e, in ultima analisi, la comunicabilità. Il punto non è se esistano omeno dei ‘significati privati’; quello che conta è che i significati costituiscono la base delloscambio culturale. In quest’ottica il conoscere e il comunicare sono per loro stessa naturaprofondamente inter<strong>di</strong>pendenti, <strong>di</strong>rei anzi praticamente inseparabili. Infatti, per quanto possa
Teorie, modelli e artefatti per la costruzione sociale e contestuale della conoscenza 33sembrare che l’in<strong>di</strong>viduo operi per proprio conto nella sua ricerca <strong>di</strong> significati, non lo puòfare, e nessuno lo può fare, senza l’ausilio dei sistemi simbolici della propria cultura. È lacultura che ci fornisce gli strumenti per organizzare e per capire il nostro mondo in formecomunicabili. La caratteristica <strong>di</strong>stintiva dell’evoluzione umana è legata alla particolareevoluzione della mente, che si è sviluppata in modo tale da consentire agli esseri umani <strong>di</strong>utilizzare gli strumenti della cultura. Senza questi strumenti, simbolici o materiali che siano,l’uomo non è una ‘scimmia nuda’, ma solo una vuota astrazione. La cultura dunque, puressendo essa stessa una creazione dell’uomo, al tempo stesso plasma e rende possibilel’attività <strong>di</strong> una mente tipicamente umana” (Bruner, 2004, p.17).La realtà esperienziale risulta quin<strong>di</strong> interpretata soggettivamente attraverso le coor<strong>di</strong>natemesse a <strong>di</strong>sposizione, implicitamente o esplicitamente, dai sistemi culturali <strong>di</strong> appartenenza.“I processi cognitivi vengono così a definirsi in prima istanza come processi ermeneutici piùche come processi elaborativi in quanto interpretano e mettono in relazione esperienze e,attraverso il linguaggio, consentono <strong>di</strong> mettere a confronto e con<strong>di</strong>videre le esperienzevissute da più soggetti allo scopo <strong>di</strong> costruire un adeguato e funzionale patrimonio <strong>di</strong>strumenti <strong>di</strong> deco<strong>di</strong>fica della realtà; in tal modo il soggetto non si trova ogni volta adelaborare ex novo i suoi strumenti interpretativi, ma può trovarli già <strong>di</strong>sponibili in unacultura e, a sua volta, trasmetterli” (Santoianni, Striano, 2003, p.94).In una prospettiva “macro”, il culturalismo guarda alla “cultura come sistema <strong>di</strong> valori, <strong>di</strong><strong>di</strong>ritti, <strong>di</strong> scambi, <strong>di</strong> obblighi, <strong>di</strong> opportunità, <strong>di</strong> potere. Sul versante “micro” esamina comele richieste <strong>di</strong> un sistema culturale influenzino coloro che devono operare al suo interno. Inquesto spirito, il culturalismo si concentra sul modo in cui gli in<strong>di</strong>vidui costruiscono realtà esignificati che permettono loro <strong>di</strong> adattarsi al sistema, con quali costi personali e con qualiaspettative” (Bruner, 2004, p. 25). In entrambi casi risulta centrale il ruolo del linguaggiocome sistema simbolico privilegiato per garantire la funzione principale che è quella del“fare significato”, cioè <strong>di</strong> attribuire significati alle cose in situazioni <strong>di</strong>verse e in occasioniconcrete. Il linguaggio esprime in modo esplicito e <strong>di</strong>rettamente rappresentabile i significatiche costituiscono i no<strong>di</strong> centrali <strong>di</strong> ogni cultura. L’idea principale <strong>di</strong> questo approccio è chele azioni culturalmente con<strong>di</strong>vise sono un modo particolarmente efficace per rappresentare lacultura, anche se non la rappresentano esplicitamente; la rappresentazione è implicita(Moscar<strong>di</strong>no, Axia, 2003, p.26). Gli aspetti impliciti della cultura possono, però, venireoperazionalizzati, ossia formulati in termini operativi per poter essere misurati e indagatiscientificamente. “Ogni essere umano <strong>di</strong> ogni cultura è in grado <strong>di</strong> narrare la propria routinequoti<strong>di</strong>ana, che è conservata in forma schematica nella memoria a lungo termine sotto forma<strong>di</strong> script ben organizzati. Tali script o schemi sono delle strutture <strong>di</strong> conoscenza - spessooperanti al <strong>di</strong> fuori della consapevolezza - che aiutano le persone a orientarsi nella vitaquoti<strong>di</strong>ana, in quanto rappresentano la sequenza <strong>di</strong> eventi e azioni che generalmente siverificano in particolari situazioni sociali (andare al ristorante, fare la spesa al supermercatoecc.). L’indagine della routine si presenta come un mezzo ideale per la psicologia culturale,alla ricerca dei sistemi <strong>di</strong> significato tipici <strong>di</strong> una cultura, e anche per il confrontotransculturale” (ibidem).La riscoperta del valore della comunicazione (nella duplice accezione <strong>di</strong> argomentazione enarrazione) nei processi <strong>di</strong> costruzione delle conoscenze sociali - che è anche alla base dellosviluppo <strong>di</strong> molte delle pratiche messe in atto nel CSCL – ha quin<strong>di</strong> anche una valenzametodologica. La routine può infatti essere indagata attraverso il colloquio, la conversazione,l’intervista, ma può anche essere stu<strong>di</strong>ata attraverso l’osservazione <strong>di</strong>retta e partecipante.La psicologia popolare o psicologia ingenua (folk psycology), spesso contrapposta allascienza cognitiva (Bruner, 1995, p.46), è una fonte preziosa per comprendere quale ricchezza<strong>di</strong> capacità e <strong>di</strong> comportamenti caratterizzino le persone nel loro agire ed interagirenell’ambiente in cui sono inserite. Pensare, apprendere, costruire conoscenze sono processiche nella gran parte dei casi passano attraverso la forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>aloghi, <strong>di</strong> “resoconti” o storie,ovvero vengono inscritti in un tessuto <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci interpretativi socio-culturalmente definiti che
- Page 1 and 2: TESIUMANISTICA- 3 -
- Page 3 and 4: Giovanni BonaiutiStrumenti della re
- Page 5 and 6: Strumenti della rete e processo for
- Page 7 and 8: Strumenti della rete e processo for
- Page 9 and 10: Strumenti della rete e processo for
- Page 11 and 12: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 13 and 14: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 15 and 16: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 17 and 18: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 19 and 20: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 21 and 22: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 23 and 24: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 25 and 26: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 27 and 28: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 29 and 30: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 31 and 32: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 36 and 37: 34Strumenti della rete e processo f
- Page 39 and 40: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 41 and 42: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 43 and 44: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 45 and 46: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 47 and 48: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 49 and 50: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 51 and 52: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 53 and 54: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 55 and 56: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 57 and 58: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 59 and 60: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 61 and 62: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 63 and 64: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 65 and 66: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 67 and 68: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 69 and 70: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 71 and 72: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 73 and 74: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 75 and 76: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 77 and 78: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 79 and 80: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 81 and 82: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 83 and 84:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 85 and 86:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 87 and 88:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 89 and 90:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 91 and 92:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 93 and 94:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 95 and 96:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 97 and 98:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 99 and 100:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 101 and 102:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 103 and 104:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 105 and 106:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 107 and 108:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 109 and 110:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 111 and 112:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 113 and 114:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 115 and 116:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 117 and 118:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 119 and 120:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 121 and 122:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 123 and 124:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 125 and 126:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 127 and 128:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 129 and 130:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 131 and 132:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 133 and 134:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 135 and 136:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 137 and 138:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 139 and 140:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 141 and 142:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 143 and 144:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 145 and 146:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 147 and 148:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 149 and 150:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 151 and 152:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 153 and 154:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 155 and 156:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 157 and 158:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 159 and 160:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 161 and 162:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 163 and 164:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 165 and 166:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 167 and 168:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 169 and 170:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 171 and 172:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 173 and 174:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 175 and 176:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 177 and 178:
Strumenti della rete e processo for
- Page 179 and 180:
Strumenti della rete e processo for
- Page 181 and 182:
Strumenti della rete e processo for
- Page 183 and 184:
Strumenti della rete e processo for
- Page 185 and 186:
Strumenti della rete e processo for
- Page 187 and 188:
Strumenti della rete e processo for
- Page 189 and 190:
Strumenti della rete e processo for
- Page 191 and 192:
Strumenti della rete e processo for
- Page 193 and 194:
Strumenti della rete e processo for
- Page 195 and 196:
Strumenti della rete e processo for
- Page 197 and 198:
Strumenti della rete e processo for
- Page 199 and 200:
Strumenti della rete e processo for
- Page 201 and 202:
Strumenti della rete e processo for
- Page 203 and 204:
Strumenti della rete e processo for
- Page 205 and 206:
Strumenti della rete e processo for
- Page 207 and 208:
Strumenti della rete e processo for
- Page 209:
RingraziamentiRingrazio nella perso