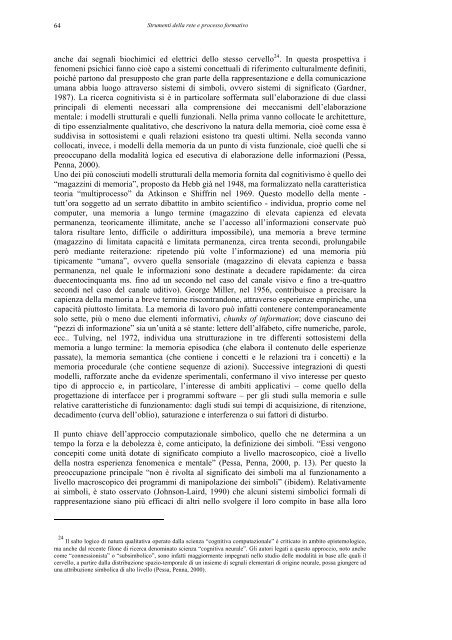64Strumenti della rete e processo formativoanche dai segnali biochimici ed elettrici dello stesso cervello 24 . In questa prospettiva ifenomeni psichici fanno cioè capo a sistemi concettuali <strong>di</strong> riferimento culturalmente definiti,poiché partono dal presupposto che gran parte della rappresentazione e della comunicazioneumana abbia luogo attraverso sistemi <strong>di</strong> simboli, ovvero sistemi <strong>di</strong> significato (Gardner,1987). La ricerca cognitivista si è in particolare soffermata sull’elaborazione <strong>di</strong> due classiprincipali <strong>di</strong> elementi necessari alla comprensione dei meccanismi dell’elaborazionementale: i modelli strutturali e quelli funzionali. Nella prima vanno collocate le architetture,<strong>di</strong> tipo essenzialmente qualitativo, che descrivono la natura della memoria, cioè come essa èsud<strong>di</strong>visa in sottosistemi e quali relazioni esistono tra questi ultimi. Nella seconda vannocollocati, invece, i modelli della memoria da un punto <strong>di</strong> vista funzionale, cioè quelli che sipreoccupano della modalità logica ed esecutiva <strong>di</strong> elaborazione delle informazioni (Pessa,Penna, 2000).Uno dei più conosciuti modelli strutturali della memoria fornita dal cognitivismo è quello dei“magazzini <strong>di</strong> memoria”, proposto da Hebb già nel 1948, ma formalizzato nella caratteristicateoria “multiprocesso” da Atkinson e Shiffrin nel 1969. Questo modello della mente -tutt’ora soggetto ad un serrato <strong>di</strong>battito in ambito scientifico - in<strong>di</strong>vidua, proprio come nelcomputer, una memoria a lungo termine (magazzino <strong>di</strong> elevata capienza ed elevatapermanenza, teoricamente illimitate, anche se l’accesso all’informazioni conservate puòtalora risultare lento, <strong>di</strong>fficile o ad<strong>di</strong>rittura impossibile), una memoria a breve termine(magazzino <strong>di</strong> limitata capacità e limitata permanenza, circa trenta secon<strong>di</strong>, prolungabileperò me<strong>di</strong>ante reiterazione: ripetendo più volte l’informazione) ed una memoria piùtipicamente “umana”, ovvero quella sensoriale (magazzino <strong>di</strong> elevata capienza e bassapermanenza, nel quale le informazioni sono destinate a decadere rapidamente: da circaduecentocinquanta ms. fino ad un secondo nel caso del canale visivo e fino a tre-quattrosecon<strong>di</strong> nel caso del canale u<strong>di</strong>tivo). George Miller, nel 1956, contribuisce a precisare lacapienza della memoria a breve termine riscontrandone, attraverso esperienze empiriche, unacapacità piuttosto limitata. La memoria <strong>di</strong> lavoro può infatti contenere contemporaneamentesolo sette, più o meno due elementi informativi, chunks of information; dove ciascuno dei“pezzi <strong>di</strong> informazione” sia un’unità a sé stante: lettere dell’alfabeto, cifre numeriche, parole,ecc.. Tulving, nel 1972, in<strong>di</strong>vidua una strutturazione in tre <strong>di</strong>fferenti sottosistemi dellamemoria a lungo termine: la memoria episo<strong>di</strong>ca (che elabora il contenuto delle esperienzepassate), la memoria semantica (che contiene i concetti e le relazioni tra i concetti) e lamemoria procedurale (che contiene sequenze <strong>di</strong> azioni). Successive integrazioni <strong>di</strong> questimodelli, rafforzate anche da evidenze sperimentali, confermano il vivo interesse per questotipo <strong>di</strong> approccio e, in particolare, l’interesse <strong>di</strong> ambiti applicativi – come quello dellaprogettazione <strong>di</strong> interfacce per i programmi software – per gli stu<strong>di</strong> sulla memoria e sullerelative caratteristiche <strong>di</strong> funzionamento: dagli stu<strong>di</strong> sui tempi <strong>di</strong> acquisizione, <strong>di</strong> ritenzione,deca<strong>di</strong>mento (curva dell’oblio), saturazione e interferenza o sui fattori <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo.Il punto chiave dell’approccio computazionale simbolico, quello che ne determina a untempo la forza e la debolezza è, come anticipato, la definizione dei simboli. “Essi vengonoconcepiti come unità dotate <strong>di</strong> significato compiuto a livello macroscopico, cioè a livellodella nostra esperienza fenomenica e mentale” (Pessa, Penna, 2000, p. 13). Per questo lapreoccupazione principale “non è rivolta al significato dei simboli ma al funzionamento alivello macroscopico dei programmi <strong>di</strong> manipolazione dei simboli” (ibidem). Relativamenteai simboli, è stato osservato (Johnson-Laird, 1990) che alcuni sistemi simbolici formali <strong>di</strong>rappresentazione siano più efficaci <strong>di</strong> altri nello svolgere il loro compito in base alla loro24 Il salto logico <strong>di</strong> natura qualitativa operato dalla scienza “cognitiva computazionale” è criticato in ambito epistemologico,ma anche dal recente filone <strong>di</strong> ricerca denominato scienza “cognitiva neurale”. Gli autori legati a questo approccio, noto anchecome “connessionista” o “subsimbolico”, sono infatti maggiormente impegnati nello stu<strong>di</strong>o delle modalità in base alle quali ilcervello, a partire dalla <strong>di</strong>stribuzione spazio-temporale <strong>di</strong> un insieme <strong>di</strong> segnali elementari <strong>di</strong> origine neurale, possa giungere aduna attribuzione simbolica <strong>di</strong> alto livello (Pessa, Penna, 2000).
Strumenti e ambienti per la formazione in rete. Prospettive, limiti e potenzialità delle tecnologie 65maggiore pertinenza rispetto al contesto da rappresentare. In altre parole esistono dei segniche rappresentano qualcosa in un determinato dominio (significante), la cui interpretazione(significato) per la mente umana, richiede uno sforzo minore perché presenta unaconformazione analogica, ovvero prossima, a quanto rappresentato. Ad esempio il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong>un cavallo è più esplicito, e universale, che non la parola scritta “cavallo”. In ambitoinformatico sono in molti a ritenere che le interfacce grafiche, ovvero quelle basate su“icone”, ten<strong>di</strong>ne e pulsanti siano più semplici da usare <strong>di</strong> quelle che si basano su coman<strong>di</strong>scritti. Analogamente esistono modalità <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> rappresentare internamente, ovvero nellamente, le informazioni. Bruner (1967; Bruner et. Al., 1970) parla <strong>di</strong> rappresentazione attiva,iconica e simbolica per in<strong>di</strong>care modalità che vengono rese <strong>di</strong>sponibili in “sta<strong>di</strong>” <strong>di</strong>versidello sviluppo cognitivo del bambino, ma anche come modalità qualitativamente <strong>di</strong>stinte chein seguito, nell’adulto, coesistono per consentire mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi per entrare in contatto con larealtà esterna. Tipi <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>versi si prestano all’adozione dell’una o dell’altra modalità.Spiegare ad una persona che non l’ha mai fatto come si annoda una cravatta suggerisce l’uso<strong>di</strong> una modalità attiva, basata sull’esemplificazione pratica dei passaggi, delle singole azioni.Sarebbe poco efficiente ricorrere a delle rappresentazioni iconiche, ovvero a dei <strong>di</strong>segni, opeggio ad una descrizione scritta (simbolica). Diversamente per in<strong>di</strong>care che una determinataporta consente l’accesso al bagno delle signore è più opportuno ricorrere allarappresentazione iconica, ad esempio attraverso la stilizzazione <strong>di</strong> una figura femminile.L’orario dei treni, invece, non può che utilizzare un sistema simbolico astratto. Un altroesempio, preso dall’informatica, può aiutarci a capire come semiotiche <strong>di</strong>fferenti possanooffrire modalità <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> rappresentazione, senza che queste ne specifichino in assoluto unacome migliore <strong>di</strong> un’altra. Nel passare attraverso <strong>di</strong>verse generazioni <strong>di</strong> sistemi operativi,sono oggi <strong>di</strong>sponibili tre <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> interfacce (Levial<strong>di</strong>, 1999): simboliche (richiedonol’input <strong>di</strong> coman<strong>di</strong> espliciti, come ad esempio i coman<strong>di</strong> da prompt), atomiche (quelle cheoffrono la selezione tra opzioni <strong>di</strong>verse, ad esempio i menu), continue (quelle che prevedonoun’interazione visiva stretta attraverso l’uso <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> puntamento come penne ottiche,mouse, joystick, ecc.). Ma se nei primi computer era obbligatorio l’uso <strong>di</strong> coman<strong>di</strong> moltoprossimi al linguaggio macchina (interfacce del primo tipo), oggi con l’avvento delle“interfacce grafiche” (GUI, grafic user interface) ed in particolare <strong>degli</strong> ambienti “ad icone efinestre” che fanno prevalentemente uso <strong>di</strong> modalità del secondo e del terzo tipo, non si èabbandonato l’uso della prima modalità. Pensiamo ad un’operazione come salvare undocumento in Word: è possibile farlo facendo clic con il mouse sull’icona con l’immagine <strong>di</strong>un floppy (modalità continua), oppure posso scegliere da un menu a ten<strong>di</strong>na (atomica) o,infine, premere una combinazione <strong>di</strong> tasti (esempio: “maiuscolo+F12”) per ottenere lo stessorisultato (modalità simbolica). Il fatto che esistano possibilità <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong> eseguire le stessefunzioni consente a categorie <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> utenti <strong>di</strong> raggiungere nel proprio specifico epreferenziale modo lo stesso scopo, ma anche ad uno stessa persona – in situazioni <strong>di</strong>verse –<strong>di</strong> avvalersi delle “modalità” più opportune 25 .Il processo che porta all’attribuzione del valore <strong>di</strong> “simbolo” ad una segno (naturale oartificiale), si inserisce in un quadro evolutivo e <strong>di</strong> capacità biologica ed adattiva propriadell’uomo (Orefice, 2001). L’interpretazione <strong>di</strong> ogni segno nasconde elementi <strong>di</strong> complessitàe <strong>di</strong> ambiguità che sono dati dall’intreccio <strong>di</strong> fattori percettivi (quin<strong>di</strong> fisiologici), ma anchecognitivi e culturali. In semiotica, oltre ad una <strong>di</strong>mensione referenziale, quella che consentead un segno <strong>di</strong> rimandare all’oggetto rappresentato, vengono in<strong>di</strong>viduate una <strong>di</strong>mensionepragmatica ed una contestuale entrambe implicate nell’attribuzione <strong>di</strong> significati e valori inambiti situazionali o culturali <strong>di</strong>versi (Gensini, 2002). Le caratteristiche dei simboli e le25 Alcuni ricercatori, sempre partendo dagli stu<strong>di</strong> sulla cognizione umana, arrivano invece a conclusioni abbastanza <strong>di</strong>fferenti.Quella che tecnicamente viene chiamata monotonicità, ovvero la possibilità <strong>di</strong> raggiungere un obiettivo attraverso un solo tipo<strong>di</strong> azione, garantirebbe infatti l’acquisizione <strong>di</strong> comportamenti automatici utili per velocizzare, e soprattutto, per non <strong>di</strong>stogliereattenzione dall’obiettivo primario del compito (Raskin, 2003, p.75).
- Page 1 and 2:
TESIUMANISTICA- 3 -
- Page 3 and 4:
Giovanni BonaiutiStrumenti della re
- Page 5 and 6:
Strumenti della rete e processo for
- Page 7 and 8:
Strumenti della rete e processo for
- Page 9 and 10:
Strumenti della rete e processo for
- Page 11 and 12:
Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 13 and 14:
Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 15 and 16: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 17 and 18: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 19 and 20: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 21 and 22: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 23 and 24: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 25 and 26: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 27 and 28: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 29 and 30: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 31 and 32: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 34 and 35: 32Strumenti della rete e processo f
- Page 36 and 37: 34Strumenti della rete e processo f
- Page 39 and 40: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 41 and 42: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 43 and 44: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 45 and 46: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 47 and 48: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 49 and 50: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 51 and 52: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 53 and 54: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 55 and 56: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 57 and 58: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 59 and 60: Teorie, modelli e artefatti per la
- Page 61 and 62: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 63 and 64: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 65: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 69 and 70: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 71 and 72: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 73 and 74: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 75 and 76: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 77 and 78: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 79 and 80: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 81 and 82: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 83 and 84: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 85 and 86: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 87 and 88: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 89 and 90: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 91 and 92: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 93 and 94: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 95 and 96: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 97 and 98: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 99 and 100: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 101 and 102: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 103 and 104: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 105 and 106: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 107 and 108: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 109 and 110: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 111 and 112: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 113 and 114: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 115 and 116: Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 117 and 118:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 119 and 120:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 121 and 122:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 123 and 124:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 125 and 126:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 127 and 128:
Strumenti e ambienti per la formazi
- Page 129 and 130:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 131 and 132:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 133 and 134:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 135 and 136:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 137 and 138:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 139 and 140:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 141 and 142:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 143 and 144:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 145 and 146:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 147 and 148:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 149 and 150:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 151 and 152:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 153 and 154:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 155 and 156:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 157 and 158:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 159 and 160:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 161 and 162:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 163 and 164:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 165 and 166:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 167 and 168:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 169 and 170:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 171 and 172:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 173 and 174:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 175 and 176:
L’indagine empirica e le verifich
- Page 177 and 178:
Strumenti della rete e processo for
- Page 179 and 180:
Strumenti della rete e processo for
- Page 181 and 182:
Strumenti della rete e processo for
- Page 183 and 184:
Strumenti della rete e processo for
- Page 185 and 186:
Strumenti della rete e processo for
- Page 187 and 188:
Strumenti della rete e processo for
- Page 189 and 190:
Strumenti della rete e processo for
- Page 191 and 192:
Strumenti della rete e processo for
- Page 193 and 194:
Strumenti della rete e processo for
- Page 195 and 196:
Strumenti della rete e processo for
- Page 197 and 198:
Strumenti della rete e processo for
- Page 199 and 200:
Strumenti della rete e processo for
- Page 201 and 202:
Strumenti della rete e processo for
- Page 203 and 204:
Strumenti della rete e processo for
- Page 205 and 206:
Strumenti della rete e processo for
- Page 207 and 208:
Strumenti della rete e processo for
- Page 209:
RingraziamentiRingrazio nella perso