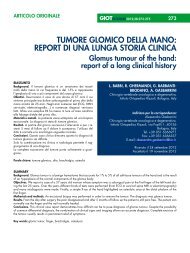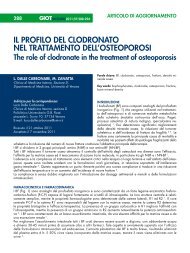Vol.XXXVII, Suppl. 1 - Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
Vol.XXXVII, Suppl. 1 - Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
Vol.XXXVII, Suppl. 1 - Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
s126<br />
processi <strong>di</strong> guarigione e <strong>di</strong> rigenerazione dei tessuti 7-9 .<br />
Questa conclusione ha portato a signifi cativi sforzi <strong>di</strong> ricerca<br />
esaminando <strong>di</strong>versi fattori <strong>di</strong> crescita e il loro ruolo<br />
nella riparazione dei tessuti 7 8 .<br />
I granuli alfa, sono il fulcro del processo riparativo indotto<br />
dalle piastrine: essi, infatti, contengono fattori <strong>di</strong> crescita<br />
in forma inattiva. I principali fattori <strong>di</strong> crescita contenuti in<br />
questi granuli sono il trasforming growth factor β (TGF-β),<br />
il fattore <strong>di</strong> crescita vascolare endoteliale (VEGF), il fattore<br />
<strong>di</strong> crescita derivato delle piastrine (PDGF), il fattore <strong>di</strong><br />
crescita epiteliale (EGF), l’insulin like growth factor (IGF-1)<br />
e l’hepatocite growth factor (HGF) 10-13 .<br />
Molti Autori ritengono che devono essere ancora eseguiti<br />
stu<strong>di</strong> per capire il meccanismo d’azione del PRFM nella<br />
ricostruzione dell’LCA come per gli altri tessuti 14 15 .<br />
L’evoluzione dell’innesto ten<strong>di</strong>neo all’RMN è stata largamente<br />
descritta come un iniziale segnale a bassa<br />
intensità che poi evolve nell’arco <strong>di</strong> un anno dopo<br />
l’intervento chirurgico, presentando la proliferazione<br />
sinoviale, la neovascolarizzazione ed infi ne la neolegamentizzazione.<br />
La completa risoluzione dei cambiamenti <strong>di</strong> segnale sono<br />
descritti all’incirca a 18-24 mesi dall’intervento 1 16 .<br />
oBiEttiVi<br />
Scopo del nostro stu<strong>di</strong>o è <strong>di</strong> valutare se, come ipotizzato<br />
in letteratura da vari Autori 5 14 15 , l’impiego del PRFM nel<br />
tunnel osseo dell’innesto possa portare ad un miglioramento<br />
dei risultati sia nel follow-up clinico che nella qualità<br />
del tessuto innestato.<br />
MEto<strong>di</strong><br />
Abbiamo eseguito una valutazione prospettica, randomizzata<br />
e a doppio cieco <strong>di</strong> 2 serie consecutive <strong>di</strong> pazienti,<br />
sottoposti a ricostruzione dell’LCA con innesto <strong>di</strong> STG<br />
nell’arco <strong>di</strong> 24 mesi (tra marzo 2008 e marzo 2010).<br />
Il campione totale (24 pazienti) aveva caratteristiche simili,<br />
stessa tecnica chirurgica, effettuata dagli stessi chirurghi,<br />
seguendo il medesimo protocollo riabilitativo.<br />
12 pazienti operati con meto<strong>di</strong>ca classica (Gruppo 2) e<br />
12 con l’aggiunta del PRFM (Gruppo 1).<br />
Abbiamo reclutato 22 pazienti <strong>di</strong> sesso maschile e 2 pazienti<br />
<strong>di</strong> sesso femminile.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione per lateralità del ginocchio era: 15 destri<br />
e 9 sinistri.<br />
I criteri <strong>di</strong> inclusione erano: età tra i 18 e 45 anni, rottura<br />
acuta primaria dell’LCA, intervento oltre i 60 giorni<br />
dal trauma, ginocchio controlaterale indenne da patologia<br />
traumatica o degenerativa e accettazione del paziente<br />
dell’intervento proposto con apposito consenso informato.<br />
I criteri <strong>di</strong> esclusione erano: uso <strong>di</strong> altri innesti, altre tecniche<br />
chirurgiche, lesioni multilegamentose, patologie infettive/infi<br />
ammatorie del ginocchio, condropatie superio-<br />
M. chiusaroLi Et aL.<br />
ri al primo grado <strong>di</strong> Outerbridge e precedenti interventi<br />
chirurgici sullo stesso ginocchio.<br />
Eventuali complicanze post-operatorie sono state registrate<br />
durante il follow-up.<br />
preparazione prfM<br />
Contemporaneamente alla procedura chirurgica veniva<br />
preparato il PRFM usando Cascade Me<strong>di</strong>cal Enterprises<br />
kit da 2 tubi (Cascade Me<strong>di</strong>cal Enterprises, Wayne, NJ)<br />
(Fig. 1).<br />
fig. 1. Centrifuga Cascade.<br />
Il sangue necessario è stato ottenuto da un prelievo venoso<br />
usando una siringa da 10 ml. Il sangue prelevato<br />
è stato posto in CPD (citrato fosfonato destrosio) in<br />
rapporto 1 ml/5 ml. La prima centrifugazione è stata<br />
fatta a 2.350 rpm per 6 minuti, separando il PRP dalle<br />
componenti cellulari bianche e rosse. Il supernatante<br />
è stato poi posizionato nel secondo tubo, contenente<br />
cloruro <strong>di</strong> calcio e centrifugato a 2.700 rpm per 15<br />
minuti. Questa tecnica è descritta dalla <strong>di</strong>tta produttrice.<br />
Il risultante PRFM è una matrice densa ed eventualmente<br />
suturabile.<br />
intervento chirurgico<br />
Tutti i casi analizzati sono stati operati dallo stesso chirurgo<br />
me<strong>di</strong>ante intervento <strong>di</strong> ricostruzione dell’LCA con<br />
l’utilizzo <strong>di</strong> innesto autologo <strong>di</strong> STG fi ssato nel tunnel femorale<br />
con sistema RIGIDFIX ® (DePuy) e nel tunnel tibiale<br />
con sistema Bio-INTRAFIX (DePuy).<br />
12 pazienti (Gruppo A) sono stati trattati con PRFM mentre<br />
altri 12 sono stati presi in considerazione come gruppo<br />
controllo (Gruppo B).