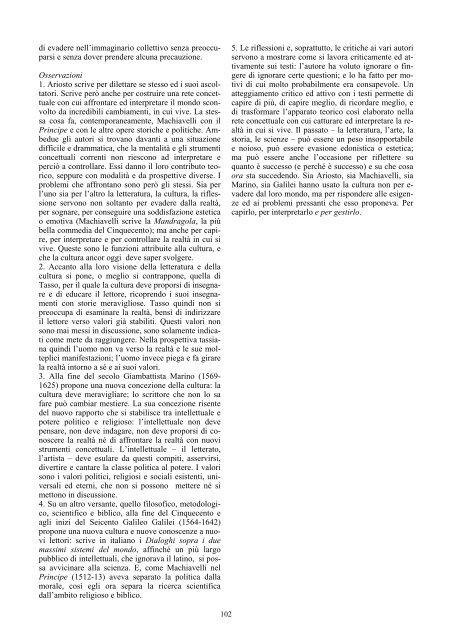pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>di</strong> evadere nell’immaginario collettivo senza preoccuparsi<br />
e senza dover prendere alcuna precauzione.<br />
Osservazioni<br />
1. Ariosto scrive per <strong>di</strong>lettare se stesso ed i suoi ascoltatori.<br />
Scrive però anche per costruire una rete concettuale<br />
con cui affrontare ed interpretare il mondo sconvolto<br />
da incre<strong>di</strong>bili cambiamenti, in cui vive. La stessa<br />
cosa fa, contemporaneamente, Machiavelli con il<br />
Principe e con le altre opere storiche e politiche. Ambedue<br />
gli autori si trovano davanti a una situazione<br />
<strong>di</strong>fficile e drammatica, che la mentalità e gli strumenti<br />
concettuali correnti non riescono ad interpretare e<br />
perciò a controllare. Essi danno il loro contributo teorico,<br />
seppure con modalità e da prospettive <strong>di</strong>verse. I<br />
problemi che affrontano sono però gli stessi. Sia per<br />
l’uno sia per l’altro la <strong>letteratura</strong>, la cultura, la riflessione<br />
servono non soltanto per evadere dalla realtà,<br />
per sognare, per conseguire una sod<strong>di</strong>sfazione estetica<br />
o emotiva (Machiavelli scrive la Mandragola, la più<br />
bella comme<strong>di</strong>a del Cinquecento); ma anche per capire,<br />
per interpretare e per controllare la realtà in cui si<br />
vive. Queste sono le funzioni attribuite alla cultura, e<br />
che la cultura ancor oggi deve saper svolgere.<br />
2. Accanto alla loro visione della <strong>letteratura</strong> e della<br />
cultura si pone, o meglio si contrappone, quella <strong>di</strong><br />
Tasso, per il quale la cultura deve proporsi <strong>di</strong> insegnare<br />
e <strong>di</strong> educare il lettore, ricoprendo i suoi insegnamenti<br />
con storie meravigliose. Tasso quin<strong>di</strong> non si<br />
preoccupa <strong>di</strong> esaminare la realtà, bensì <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare<br />
il lettore verso valori già stabiliti. Questi valori non<br />
sono mai messi in <strong>di</strong>scussione, sono solamente in<strong>di</strong>cati<br />
come mete da raggiungere. Nella prospettiva tassiana<br />
quin<strong>di</strong> l’uomo non va verso la realtà e le sue molteplici<br />
manifestazioni; l’uomo invece piega e fa girare<br />
la realtà intorno a sé e ai suoi valori.<br />
3. Alla fine del secolo Giambattista Marino (1569-<br />
1625) propone una nuova concezione della cultura: la<br />
cultura deve meravigliare; lo scrittore che non lo sa<br />
fare può cambiar mestiere. La sua concezione risente<br />
del nuovo rapporto che si stabilisce tra intellettuale e<br />
potere politico e religioso: l’intellettuale non deve<br />
pensare, non deve indagare, non deve proporsi <strong>di</strong> conoscere<br />
la realtà né <strong>di</strong> affrontare la realtà con nuovi<br />
strumenti concettuali. L’intellettuale – il letterato,<br />
l’artista – deve esulare da questi compiti, asservirsi,<br />
<strong>di</strong>vertire e cantare la classe politica al potere. I valori<br />
sono i valori politici, religiosi e sociali esistenti, universali<br />
ed eterni, che non si possono mettere né si<br />
mettono in <strong>di</strong>scussione.<br />
4. Su un altro versante, quello filosofico, metodologico,<br />
scientifico e biblico, alla fine del Cinquecento e<br />
agli inizi del Seicento Galileo Galilei (1564-1642)<br />
propone una nuova cultura e nuove conoscenze a nuovi<br />
lettori: scrive in italiano i Dialoghi sopra i due<br />
massimi sistemi del mondo, affinché un più largo<br />
pubblico <strong>di</strong> intellettuali, che ignorava il latino, si possa<br />
avvicinare alla scienza. E, come Machiavelli nel<br />
Principe (1512-13) aveva separato la politica dalla<br />
morale, così egli ora separa la ricerca scientifica<br />
dall’ambito religioso e biblico.<br />
102<br />
5. Le riflessioni e, soprattutto, le critiche ai vari autori<br />
servono a mostrare come si lavora criticamente ed attivamente<br />
sui testi: l’autore ha voluto ignorare o fingere<br />
<strong>di</strong> ignorare certe questioni; e lo ha fatto per motivi<br />
<strong>di</strong> cui molto probabilmente era consapevole. Un<br />
atteggiamento critico ed attivo con i testi permette <strong>di</strong><br />
capire <strong>di</strong> più, <strong>di</strong> capire meglio, <strong>di</strong> ricordare meglio, e<br />
<strong>di</strong> trasformare l’apparato teorico così elaborato nella<br />
rete concettuale con cui catturare ed interpretare la realtà<br />
in cui si vive. Il passato – la <strong>letteratura</strong>, l’arte, la<br />
storia, le scienze – può essere un peso insopportabile<br />
e noioso, può essere evasione edonistica o estetica;<br />
ma può essere anche l’occasione per riflettere su<br />
quanto è successo (e perché è successo) e su che cosa<br />
ora sta succedendo. Sia Ariosto, sia Machiavelli, sia<br />
Marino, sia Galilei hanno usato la cultura non per evadere<br />
dal loro mondo, ma per rispondere alle esigenze<br />
ed ai problemi pressanti che esso proponeva. Per<br />
capirlo, per interpretarlo e per gestirlo.