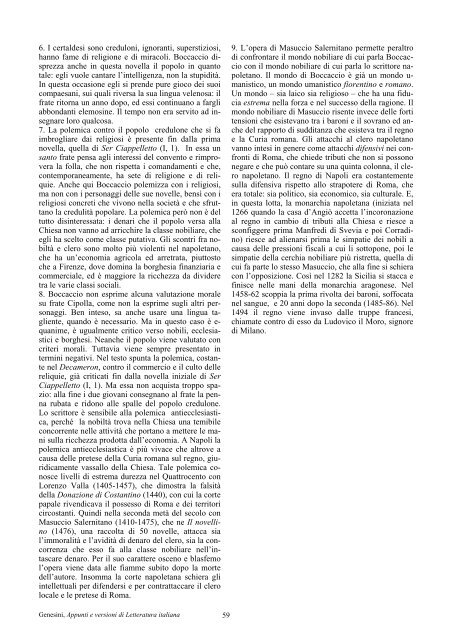pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
6. I certaldesi sono creduloni, ignoranti, superstiziosi,<br />
hanno fame <strong>di</strong> religione e <strong>di</strong> miracoli. Boccaccio <strong>di</strong>sprezza<br />
anche in questa novella il popolo in quanto<br />
tale: egli vuole cantare l’intelligenza, non la stupi<strong>di</strong>tà.<br />
In questa occasione egli si prende pure gioco dei suoi<br />
compaesani, sui quali riversa la sua lingua velenosa: il<br />
frate ritorna un anno dopo, ed essi continuano a fargli<br />
abbondanti elemosine. Il tempo non era servito ad insegnare<br />
loro qualcosa.<br />
7. La polemica contro il popolo credulone che si fa<br />
imbrogliare dai religiosi è presente fin dalla prima<br />
novella, quella <strong>di</strong> Ser Ciappelletto (I, 1). In essa un<br />
santo frate pensa agli interessi del convento e rimprovera<br />
la folla, che non rispetta i comandamenti e che,<br />
contemporaneamente, ha sete <strong>di</strong> religione e <strong>di</strong> reliquie.<br />
Anche qui Boccaccio polemizza con i religiosi,<br />
ma non con i personaggi delle sue novelle, bensì con i<br />
religiosi concreti che vivono nella società e che sfruttano<br />
la credulità popolare. La polemica però non è del<br />
tutto <strong>di</strong>sinteressata: i denari che il popolo versa alla<br />
Chiesa non vanno ad arricchire la classe nobiliare, che<br />
egli ha scelto come classe putativa. Gli scontri fra nobiltà<br />
e clero sono molto più violenti nel napoletano,<br />
che ha un’economia agricola ed arretrata, piuttosto<br />
che a Firenze, dove domina la borghesia finanziaria e<br />
commerciale, ed è maggiore la ricchezza da <strong>di</strong>videre<br />
tra le varie classi sociali.<br />
8. Boccaccio non esprime alcuna valutazione morale<br />
su frate Cipolla, come non la esprime sugli altri personaggi.<br />
Ben inteso, sa anche usare una lingua tagliente,<br />
quando è necessario. Ma in questo caso è equanime,<br />
è ugualmente critico verso nobili, ecclesiastici<br />
e borghesi. Neanche il popolo viene valutato con<br />
criteri morali. Tuttavia viene sempre presentato in<br />
termini negativi. Nel testo spunta la polemica, costante<br />
nel Decameron, contro il commercio e il culto delle<br />
reliquie, già criticati fin dalla novella iniziale <strong>di</strong> Ser<br />
Ciappelletto (I, 1). Ma essa non acquista troppo spazio:<br />
alla fine i due giovani consegnano al frate la penna<br />
rubata e ridono alle spalle del popolo credulone.<br />
Lo scrittore è sensibile alla polemica antiecclesiastica,<br />
perché la nobiltà trova nella Chiesa una temibile<br />
concorrente nelle attività che portano a mettere le mani<br />
sulla ricchezza prodotta dall’economia. A Napoli la<br />
polemica antiecclesiastica è più vivace che altrove a<br />
causa delle pretese della Curia romana sul regno, giuri<strong>di</strong>camente<br />
vassallo della Chiesa. Tale polemica conosce<br />
livelli <strong>di</strong> estrema durezza nel Quattrocento con<br />
Lorenzo Valla (1405-1457), che <strong>di</strong>mostra la falsità<br />
della Donazione <strong>di</strong> Costantino (1440), con cui la corte<br />
papale riven<strong>di</strong>cava il possesso <strong>di</strong> Roma e dei territori<br />
circostanti. Quin<strong>di</strong> nella seconda metà del secolo con<br />
Masuccio Salernitano (1410-1475), che ne Il novellino<br />
(1476), una raccolta <strong>di</strong> 50 novelle, attacca sia<br />
l’immoralità e l’avi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> denaro del clero, sia la concorrenza<br />
che esso fa alla classe nobiliare nell’intascare<br />
denaro. Per il suo carattere osceno e blasfemo<br />
l’opera viene data alle fiamme subito dopo la morte<br />
dell’autore. Insomma la corte napoletana schiera gli<br />
intellettuali per <strong>di</strong>fendersi e per contrattaccare il clero<br />
locale e le pretese <strong>di</strong> Roma.<br />
Genesini, Appunti e <strong>versioni</strong> <strong>di</strong> Letteratura <strong>italiana</strong> 59<br />
9. L’opera <strong>di</strong> Masuccio Salernitano permette peraltro<br />
<strong>di</strong> confrontare il mondo nobiliare <strong>di</strong> cui parla Boccaccio<br />
con il mondo nobiliare <strong>di</strong> cui parla lo scrittore napoletano.<br />
Il mondo <strong>di</strong> Boccaccio è già un mondo umanistico,<br />
un mondo umanistico fiorentino e romano.<br />
Un mondo – sia laico sia religioso – che ha una fiducia<br />
estrema nella forza e nel successo della ragione. Il<br />
mondo nobiliare <strong>di</strong> Masuccio risente invece delle forti<br />
tensioni che esistevano tra i baroni e il sovrano ed anche<br />
del rapporto <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>tanza che esisteva tra il regno<br />
e la Curia romana. Gli attacchi al clero napoletano<br />
vanno intesi in genere come attacchi <strong>di</strong>fensivi nei confronti<br />
<strong>di</strong> Roma, che chiede tributi che non si possono<br />
negare e che può contare su una quinta colonna, il clero<br />
napoletano. Il regno <strong>di</strong> Napoli era costantemente<br />
sulla <strong>di</strong>fensiva rispetto allo strapotere <strong>di</strong> Roma, che<br />
era totale: sia politico, sia economico, sia culturale. E,<br />
in questa lotta, la monarchia napoletana (iniziata nel<br />
1266 quando la casa d’Angiò accetta l’incoronazione<br />
al regno in cambio <strong>di</strong> tributi alla Chiesa e riesce a<br />
sconfiggere prima Manfre<strong>di</strong> <strong>di</strong> Svevia e poi Corra<strong>di</strong>no)<br />
riesce ad alienarsi prima le simpatie dei nobili a<br />
causa delle pressioni fiscali a cui li sottopone, poi le<br />
simpatie della cerchia nobiliare più ristretta, quella <strong>di</strong><br />
cui fa parte lo stesso Masuccio, che alla fine si schiera<br />
con l’opposizione. Così nel 1282 la Sicilia si stacca e<br />
finisce nelle mani della monarchia aragonese. Nel<br />
1458-62 scoppia la prima rivolta dei baroni, soffocata<br />
nel sangue, e 20 anni dopo la seconda (1485-86). Nel<br />
1494 il regno viene invaso dalle truppe francesi,<br />
chiamate contro <strong>di</strong> esso da Ludovico il Moro, signore<br />
<strong>di</strong> Milano.