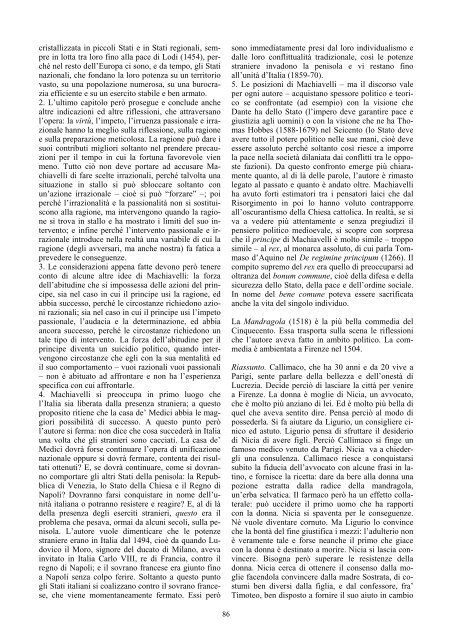pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
cristallizzata in piccoli Stati e in Stati regionali, sempre<br />
in lotta tra loro fino alla pace <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong> (1454), perché<br />
nel resto dell’Europa ci sono, e da tempo, gli Stati<br />
nazionali, che fondano la loro potenza su un territorio<br />
vasto, su una popolazione numerosa, su una burocrazia<br />
efficiente e su un esercito stabile e ben armato.<br />
2. L’ultimo capitolo però prosegue e conclude anche<br />
altre in<strong>di</strong>cazioni ed altre riflessioni, che attraversano<br />
l’opera: la virtù, l’impeto, l’irruenza passionale e irrazionale<br />
hanno la meglio sulla riflessione, sulla ragione<br />
e sulla preparazione meticolosa. La ragione può dare i<br />
suoi contributi migliori soltanto nel prendere precauzioni<br />
per il tempo in cui la fortuna favorevole vien<br />
meno. Tutto ciò non deve portare ad accusare Machiavelli<br />
<strong>di</strong> fare scelte irrazionali, perché talvolta una<br />
situazione in stallo si può sbloccare soltanto con<br />
un’azione irrazionale – cioè si può “forzare” –; poi<br />
perché l’irrazionalità e la passionalità non si sostituiscono<br />
alla ragione, ma intervengono quando la ragione<br />
si trova in stallo e ha mostrato i limiti del suo intervento;<br />
e infine perché l’intervento passionale e irrazionale<br />
introduce nella realtà una variabile <strong>di</strong> cui la<br />
ragione (degli avversari, ma anche nostra) fa fatica a<br />
prevedere le conseguenze.<br />
3. Le considerazioni appena fatte devono però tenere<br />
conto <strong>di</strong> alcune altre idee <strong>di</strong> Machiavelli: la forza<br />
dell’abitu<strong>di</strong>ne che si impossessa delle azioni del principe,<br />
sia nel caso in cui il principe usi la ragione, ed<br />
abbia successo, perché le circostanze richiedono azioni<br />
razionali; sia nel caso in cui il principe usi l’impeto<br />
passionale, l’audacia e la determinazione, ed abbia<br />
ancora successo, perché le circostanze richiedono un<br />
tale tipo <strong>di</strong> intervento. La forza dell’abitu<strong>di</strong>ne per il<br />
principe <strong>di</strong>venta un suici<strong>di</strong>o politico, quando intervengono<br />
circostanze che egli con la sua mentalità ed<br />
il suo comportamento – vuoi razionali vuoi passionali<br />
– non è abituato ad affrontare e non ha l’esperienza<br />
specifica con cui affrontarle.<br />
4. Machiavelli si preoccupa in primo luogo che<br />
l’Italia sia liberata dalla presenza straniera; a questo<br />
proposito ritiene che la casa de’ Me<strong>di</strong>ci abbia le maggiori<br />
possibilità <strong>di</strong> successo. A questo punto però<br />
l’autore si ferma: non <strong>di</strong>ce che cosa succederà in Italia<br />
una volta che gli stranieri sono cacciati. La casa de’<br />
Me<strong>di</strong>ci dovrà forse continuare l’opera <strong>di</strong> unificazione<br />
nazionale oppure si dovrà fermare, contenta dei risultati<br />
ottenuti? E, se dovrà continuare, come si dovranno<br />
comportare gli altri Stati della penisola: la Repubblica<br />
<strong>di</strong> Venezia, lo Stato della Chiesa e il Regno <strong>di</strong><br />
Napoli? Dovranno farsi conquistare in nome dell’unità<br />
<strong>italiana</strong> o potranno resistere e reagire? E, al <strong>di</strong> là<br />
della presenza degli eserciti stranieri, questo era il<br />
problema che pesava, ormai da alcuni secoli, sulla penisola.<br />
L’autore vuole <strong>di</strong>menticare che le potenze<br />
straniere erano in Italia dal 1494, cioè da quando Ludovico<br />
il Moro, signore del ducato <strong>di</strong> Milano, aveva<br />
invitato in Italia Carlo VIII, re <strong>di</strong> Francia, contro il<br />
regno <strong>di</strong> Napoli; e il sovrano francese era giunto fino<br />
a Napoli senza colpo ferire. Soltanto a questo punto<br />
gli Stati italiani si coalizzano contro il sovrano francese,<br />
che viene momentaneamente fermato. Essi però<br />
86<br />
sono imme<strong>di</strong>atamente presi dal loro in<strong>di</strong>vidualismo e<br />
dalle loro conflittualità tra<strong>di</strong>zionale, così le potenze<br />
straniere invadono la penisola e vi restano fino<br />
all’unità d’Italia (1859-70).<br />
5. Le posizioni <strong>di</strong> Machiavelli – ma il <strong>di</strong>scorso vale<br />
per ogni autore – acquistano spessore politico e teorico<br />
se confrontate (ad esempio) con la visione che<br />
Dante ha dello Stato (l’impero deve garantire pace e<br />
giustizia agli uomini) o con la visione che ne ha Thomas<br />
Hobbes (1588-1679) nel Seicento (lo Stato deve<br />
avere tutto il potere politico nelle sue mani, cioè deve<br />
essere assoluto perché soltanto così riesce a imporre<br />
la pace nella società <strong>di</strong>laniata dai conflitti tra le opposte<br />
fazioni). Da questo confronto emerge più chiaramente<br />
quanto, al <strong>di</strong> là delle parole, l’autore è rimasto<br />
legato al passato e quanto è andato oltre. Machiavelli<br />
ha avuto forti estimatori tra i pensatori laici che dal<br />
Risorgimento in poi lo hanno voluto contrapporre<br />
all’oscurantismo della Chiesa cattolica. In realtà, se si<br />
va a vedere più attentamente e senza pregiu<strong>di</strong>zi il<br />
pensiero politico me<strong>di</strong>oevale, si scopre con sorpresa<br />
che il principe <strong>di</strong> Machiavelli è molto simile – troppo<br />
simile – al rex, al monarca assoluto, <strong>di</strong> cui parla Tommaso<br />
d’Aquino nel De regimine principum (1266). Il<br />
compito supremo del rex era quello <strong>di</strong> preoccuparsi ad<br />
oltranza del bonum commune, cioè della <strong>di</strong>fesa e della<br />
sicurezza dello Stato, della pace e dell’or<strong>di</strong>ne sociale.<br />
In nome del bene comune poteva essere sacrificata<br />
anche la vita del singolo in<strong>di</strong>viduo.<br />
La Mandragola (1518) è la più bella comme<strong>di</strong>a del<br />
Cinquecento. Essa trasporta sulla scena le riflessioni<br />
che l’autore aveva fatto in ambito politico. La comme<strong>di</strong>a<br />
è ambientata a Firenze nel 1504.<br />
Riassunto. Callimaco, che ha 30 anni e da 20 vive a<br />
Parigi, sente parlare della bellezza e dell’onestà <strong>di</strong><br />
Lucrezia. Decide perciò <strong>di</strong> lasciare la città per venire<br />
a Firenze. La donna è moglie <strong>di</strong> Nicia, un avvocato,<br />
che è molto più anziano <strong>di</strong> lei. Ed è molto più bella <strong>di</strong><br />
quel che aveva sentito <strong>di</strong>re. Pensa perciò al modo <strong>di</strong><br />
possederla. Si fa aiutare da Ligurio, un consigliere cinico<br />
ed astuto. Ligurio pensa <strong>di</strong> sfruttare il desiderio<br />
<strong>di</strong> Nicia <strong>di</strong> avere figli. Perciò Callimaco si finge un<br />
famoso me<strong>di</strong>co venuto da Parigi. Nicia va a chiedergli<br />
una consulenza. Callimaco riesce a conquistarsi<br />
subito la fiducia dell’avvocato con alcune frasi in latino,<br />
e fornisce la ricetta: dare da bere alla donna una<br />
pozione estratta dalla ra<strong>di</strong>ce della mandragola,<br />
un’erba selvatica. Il farmaco però ha un effetto collaterale:<br />
può uccidere il primo uomo che ha rapporti<br />
con la donna. Nicia si spaventa per le conseguenze.<br />
Né vuole <strong>di</strong>ventare cornuto. Ma Ligurio lo convince<br />
che la bontà del fine giustifica i mezzi: l’adulterio non<br />
è veramente tale e forse neanche il primo che giace<br />
con la donna è destinato a morire. Nicia si lascia convincere.<br />
Bisogna però superare le resistenze della<br />
donna. Nicia cerca <strong>di</strong> ottenere il consenso dalla moglie<br />
facendola convincere dalla madre Sostrata, <strong>di</strong> costumi<br />
ben <strong>di</strong>versi dalla figlia, e dal confessore, fra’<br />
Timoteo, ben <strong>di</strong>sposto a fornire il suo aiuto in cambio