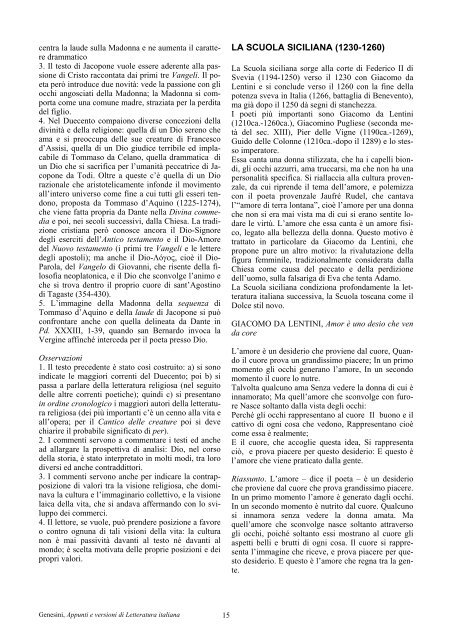pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
centra la laude sulla Madonna e ne aumenta il carattere<br />
drammatico<br />
3. Il testo <strong>di</strong> Jacopone vuole essere aderente alla passione<br />
<strong>di</strong> Cristo raccontata dai primi tre Vangeli. Il poeta<br />
però introduce due novità: vede la passione con gli<br />
occhi angosciati della Madonna; la Madonna si comporta<br />
come una comune madre, straziata per la per<strong>di</strong>ta<br />
del figlio.<br />
4. Nel Duecento compaiono <strong>di</strong>verse concezioni della<br />
<strong>di</strong>vinità e della religione: quella <strong>di</strong> un Dio sereno che<br />
ama e si preoccupa delle sue creature <strong>di</strong> Francesco<br />
d’Assisi, quella <strong>di</strong> un Dio giu<strong>di</strong>ce terribile ed implacabile<br />
<strong>di</strong> Tommaso da Celano, quella drammatica <strong>di</strong><br />
un Dio che si sacrifica per l’umanità peccatrice <strong>di</strong> Jacopone<br />
da To<strong>di</strong>. Oltre a queste c’è quella <strong>di</strong> un Dio<br />
razionale che aristotelicamente infonde il movimento<br />
all’intero universo come fine a cui tutti gli esseri tendono,<br />
proposta da Tommaso d’Aquino (1225-1274),<br />
che viene fatta propria da Dante nella Divina comme<strong>di</strong>a<br />
e poi, nei secoli successivi, dalla Chiesa. La tra<strong>di</strong>zione<br />
cristiana però conosce ancora il Dio-Signore<br />
degli eserciti dell’Antico testamento e il Dio-Amore<br />
del Nuovo testamento (i primi tre Vangeli e le lettere<br />
degli apostoli); ma anche il Dio-ó, cioè il Dio-<br />
Parola, del Vangelo <strong>di</strong> Giovanni, che risente della filosofia<br />
neoplatonica, e il Dio che sconvolge l’animo e<br />
che si trova dentro il proprio cuore <strong>di</strong> sant’Agostino<br />
<strong>di</strong> Tagaste (354-430).<br />
5. L’immagine della Madonna della sequenza <strong>di</strong><br />
Tommaso d’Aquino e della laude <strong>di</strong> Jacopone si può<br />
confrontare anche con quella delineata da Dante in<br />
Pd. XXXIII, 1-39, quando san Bernardo invoca la<br />
Vergine affinché interceda per il poeta presso Dio.<br />
Osservazioni<br />
1. Il testo precedente è stato così costruito: a) si sono<br />
in<strong>di</strong>cate le maggiori correnti del Duecento; poi b) si<br />
passa a parlare della <strong>letteratura</strong> religiosa (nel seguito<br />
delle altre correnti poetiche); quin<strong>di</strong> c) si presentano<br />
in or<strong>di</strong>ne cronologico i maggiori autori della <strong>letteratura</strong><br />
religiosa (dei più importanti c’è un cenno alla vita e<br />
all’opera; per il Cantico delle creature poi si deve<br />
chiarire il probabile significato <strong>di</strong> per).<br />
2. I commenti servono a commentare i testi ed anche<br />
ad allargare la prospettiva <strong>di</strong> analisi: Dio, nel corso<br />
della storia, è stato interpretato in molti mo<strong>di</strong>, tra loro<br />
<strong>di</strong>versi ed anche contrad<strong>di</strong>ttori.<br />
3. I commenti servono anche per in<strong>di</strong>care la contrapposizione<br />
<strong>di</strong> valori tra la visione religiosa, che dominava<br />
la cultura e l’immaginario collettivo, e la visione<br />
laica della vita, che si andava affermando con lo sviluppo<br />
dei commerci.<br />
4. Il lettore, se vuole, può prendere posizione a favore<br />
o contro ognuna <strong>di</strong> tali visioni della vita: la cultura<br />
non è mai passività davanti al testo né davanti al<br />
mondo; è scelta motivata delle proprie posizioni e dei<br />
propri valori.<br />
Genesini, Appunti e <strong>versioni</strong> <strong>di</strong> Letteratura <strong>italiana</strong> 15<br />
LA SCUOLA SICILIANA (1230-1260)<br />
La Scuola siciliana sorge alla corte <strong>di</strong> Federico II <strong>di</strong><br />
Svevia (1194-1250) verso il 1230 con Giacomo da<br />
Lentini e si conclude verso il 1260 con la fine della<br />
potenza sveva in Italia (1266, battaglia <strong>di</strong> Benevento),<br />
ma già dopo il 1250 dà segni <strong>di</strong> stanchezza.<br />
I poeti più importanti sono Giacomo da Lentini<br />
(1210ca.-1260ca.), Giacomino Pugliese (seconda metà<br />
del sec. XIII), Pier delle Vigne (1190ca.-1269),<br />
Guido delle Colonne (1210ca.-dopo il 1289) e lo stesso<br />
imperatore.<br />
Essa canta una donna stilizzata, che ha i capelli bion<strong>di</strong>,<br />
gli occhi azzurri, ama truccarsi, ma che non ha una<br />
personalità specifica. Si riallaccia alla cultura provenzale,<br />
da cui riprende il tema dell’amore, e polemizza<br />
con il poeta provenzale Jaufré Rudel, che cantava<br />
l’“amore <strong>di</strong> terra lontana”, cioè l’amore per una donna<br />
che non si era mai vista ma <strong>di</strong> cui si erano sentite lodare<br />
le virtù. L’amore che essa canta è un amore fisico,<br />
legato alla bellezza della donna. Questo motivo è<br />
trattato in particolare da Giacomo da Lentini, che<br />
propone pure un altro motivo: la rivalutazione della<br />
figura femminile, tra<strong>di</strong>zionalmente considerata dalla<br />
Chiesa come causa del peccato e della per<strong>di</strong>zione<br />
dell’uomo, sulla falsariga <strong>di</strong> Eva che tenta Adamo.<br />
La Scuola siciliana con<strong>di</strong>ziona profondamente la <strong>letteratura</strong><br />
<strong>italiana</strong> successiva, la Scuola toscana come il<br />
Dolce stil novo.<br />
GIACOMO DA LENTINI, Amor è uno desio che ven<br />
da core<br />
L’amore è un desiderio che proviene dal cuore, Quando<br />
il cuore prova un gran<strong>di</strong>ssimo piacere; In un primo<br />
momento gli occhi generano l’amore, In un secondo<br />
momento il cuore lo nutre.<br />
Talvolta qualcuno ama Senza vedere la donna <strong>di</strong> cui è<br />
innamorato; Ma quell’amore che sconvolge con furore<br />
Nasce soltanto dalla vista degli occhi:<br />
Perché gli occhi rappresentano al cuore Il buono e il<br />
cattivo <strong>di</strong> ogni cosa che vedono, Rappresentano cioè<br />
come essa è realmente;<br />
E il cuore, che accoglie questa idea, Si rappresenta<br />
ciò, e prova piacere per questo desiderio: E questo è<br />
l’amore che viene praticato dalla gente.<br />
Riassunto. L’amore – <strong>di</strong>ce il poeta – è un desiderio<br />
che proviene dal cuore che prova gran<strong>di</strong>ssimo piacere.<br />
In un primo momento l’amore è generato dagli occhi.<br />
In un secondo momento è nutrito dal cuore. Qualcuno<br />
si innamora senza vedere la donna amata. Ma<br />
quell’amore che sconvolge nasce soltanto attraverso<br />
gli occhi, poiché soltanto essi mostrano al cuore gli<br />
aspetti belli e brutti <strong>di</strong> ogni cosa. Il cuore si rappresenta<br />
l’immagine che riceve, e prova piacere per questo<br />
desiderio. E questo è l’amore che regna tra la gente.