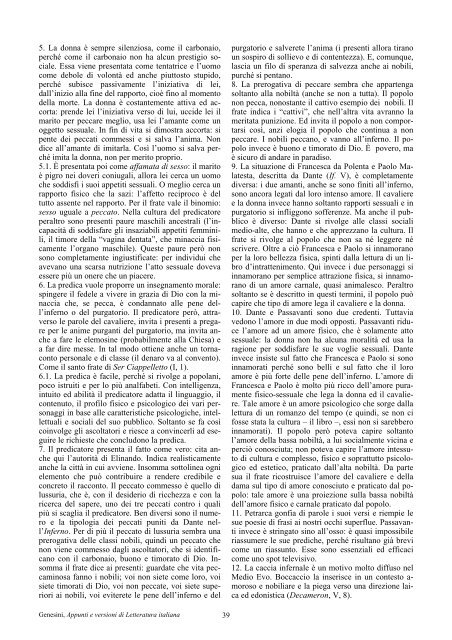pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5. La donna è sempre silenziosa, come il carbonaio,<br />
perché come il carbonaio non ha alcun prestigio sociale.<br />
Essa viene presentata come tentatrice e l’uomo<br />
come debole <strong>di</strong> volontà ed anche piuttosto stupido,<br />
perché subisce passivamente l’iniziativa <strong>di</strong> lei,<br />
dall’inizio alla fine del rapporto, cioè fino al momento<br />
della morte. La donna è costantemente attiva ed accorta:<br />
prende lei l’iniziativa verso <strong>di</strong> lui, uccide lei il<br />
marito per peccare meglio, usa lei l’amante come un<br />
oggetto sessuale. In fin <strong>di</strong> vita si <strong>di</strong>mostra accorta: si<br />
pente dei peccati commessi e si salva l’anima. Non<br />
<strong>di</strong>ce all’amante <strong>di</strong> imitarla. Così l’uomo si salva perché<br />
imita la donna, non per merito proprio.<br />
5.1. È presentata poi come affamata <strong>di</strong> sesso: il marito<br />
è pigro nei doveri coniugali, allora lei cerca un uomo<br />
che sod<strong>di</strong>sfi i suoi appetiti sessuali. O meglio cerca un<br />
rapporto fisico che la sazi: l’affetto reciproco è del<br />
tutto assente nel rapporto. Per il frate vale il binomio:<br />
sesso uguale a peccato. Nella cultura del pre<strong>di</strong>catore<br />
peraltro sono presenti paure maschili ancestrali (l’incapacità<br />
<strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare gli insaziabili appetiti femminili,<br />
il timore della “vagina dentata”, che minaccia fisicamente<br />
l’organo maschile). Queste paure però non<br />
sono completamente ingiustificate: per in<strong>di</strong>vidui che<br />
avevano una scarsa nutrizione l’atto sessuale doveva<br />
essere più un onere che un piacere.<br />
6. La pre<strong>di</strong>ca vuole proporre un insegnamento morale:<br />
spingere il fedele a vivere in grazia <strong>di</strong> Dio con la minaccia<br />
che, se pecca, è condannato alle pene dell’inferno<br />
o del purgatorio. Il pre<strong>di</strong>catore però, attraverso<br />
le parole del cavaliere, invita i presenti a pregare<br />
per le anime purganti del purgatorio, ma invita anche<br />
a fare le elemosine (probabilmente alla Chiesa) e<br />
a far <strong>di</strong>re messe. In tal modo ottiene anche un tornaconto<br />
personale e <strong>di</strong> classe (il denaro va al convento).<br />
Come il santo frate <strong>di</strong> Ser Ciappelletto (I, 1).<br />
6.1. La pre<strong>di</strong>ca è facile, perché si rivolge a popolani,<br />
poco istruiti e per lo più analfabeti. Con intelligenza,<br />
intuito ed abilità il pre<strong>di</strong>catore adatta il linguaggio, il<br />
contenuto, il profilo fisico e psicologico dei vari personaggi<br />
in base alle caratteristiche psicologiche, intellettuali<br />
e sociali del suo pubblico. Soltanto se fa così<br />
coinvolge gli ascoltatori e riesce a convincerli ad eseguire<br />
le richieste che concludono la pre<strong>di</strong>ca.<br />
7. Il pre<strong>di</strong>catore presenta il fatto come vero: cita anche<br />
qui l’autorità <strong>di</strong> Elinando. In<strong>di</strong>ca realisticamente<br />
anche la città in cui avviene. Insomma sottolinea ogni<br />
elemento che può contribuire a rendere cre<strong>di</strong>bile e<br />
concreto il racconto. Il peccato commesso è quello <strong>di</strong><br />
lussuria, che è, con il desiderio <strong>di</strong> ricchezza e con la<br />
ricerca del sapere, uno dei tre peccati contro i quali<br />
più si scaglia il pre<strong>di</strong>catore. Ben <strong>di</strong>versi sono il numero<br />
e la tipologia dei peccati puniti da Dante nell’Inferno.<br />
Per <strong>di</strong> più il peccato <strong>di</strong> lussuria sembra una<br />
prerogativa delle classi nobili, quin<strong>di</strong> un peccato che<br />
non viene commesso dagli ascoltatori, che si identificano<br />
con il carbonaio, buono e timorato <strong>di</strong> Dio. Insomma<br />
il frate <strong>di</strong>ce ai presenti: guardate che vita peccaminosa<br />
fanno i nobili; voi non siete come loro, voi<br />
siete timorati <strong>di</strong> Dio, voi non peccate, voi siete superiori<br />
ai nobili, voi eviterete le pene dell’inferno e del<br />
Genesini, Appunti e <strong>versioni</strong> <strong>di</strong> Letteratura <strong>italiana</strong> 39<br />
purgatorio e salverete l’anima (i presenti allora tirano<br />
un sospiro <strong>di</strong> sollievo e <strong>di</strong> contentezza). E, comunque,<br />
lascia un filo <strong>di</strong> speranza <strong>di</strong> salvezza anche ai nobili,<br />
purché si pentano.<br />
8. La prerogativa <strong>di</strong> peccare sembra che appartenga<br />
soltanto alla nobiltà (anche se non a tutta). Il popolo<br />
non pecca, nonostante il cattivo esempio dei nobili. Il<br />
frate in<strong>di</strong>ca i “cattivi”, che nell’altra vita avranno la<br />
meritata punizione. Ed invita il popolo a non comportarsi<br />
così, anzi elogia il popolo che continua a non<br />
peccare. I nobili peccano, e vanno all’inferno. Il popolo<br />
invece è buono e timorato <strong>di</strong> Dio. È povero, ma<br />
è sicuro <strong>di</strong> andare in para<strong>di</strong>so.<br />
9. La situazione <strong>di</strong> Francesca da Polenta e Paolo Malatesta,<br />
descritta da Dante (If. V), è completamente<br />
<strong>di</strong>versa: i due amanti, anche se sono finiti all’inferno,<br />
sono ancora legati dal loro intenso amore. Il cavaliere<br />
e la donna invece hanno soltanto rapporti sessuali e in<br />
purgatorio si infliggono sofferenze. Ma anche il pubblico<br />
è <strong>di</strong>verso: Dante si rivolge alle classi sociali<br />
me<strong>di</strong>o-alte, che hanno e che apprezzano la cultura. Il<br />
frate si rivolge al popolo che non sa né leggere né<br />
scrivere. Oltre a ciò Francesca e Paolo si innamorano<br />
per la loro bellezza fisica, spinti dalla lettura <strong>di</strong> un libro<br />
d’intrattenimento. Qui invece i due personaggi si<br />
innamorano per semplice attrazione fisica, si innamorano<br />
<strong>di</strong> un amore carnale, quasi animalesco. Peraltro<br />
soltanto se è descritto in questi termini, il popolo può<br />
capire che tipo <strong>di</strong> amore lega il cavaliere e la donna.<br />
10. Dante e Passavanti sono due credenti. Tuttavia<br />
vedono l’amore in due mo<strong>di</strong> opposti. Passavanti riduce<br />
l’amore ad un amore fisico, che è solamente atto<br />
sessuale: la donna non ha alcuna moralità ed usa la<br />
ragione per sod<strong>di</strong>sfare le sue voglie sessuali. Dante<br />
invece insiste sul fatto che Francesca e Paolo si sono<br />
innamorati perché sono belli e sul fatto che il loro<br />
amore è più forte delle pene dell’inferno. L’amore <strong>di</strong><br />
Francesca e Paolo è molto più ricco dell’amore puramente<br />
fisico-sessuale che lega la donna ed il cavaliere.<br />
Tale amore è un amore psicologico che sorge dalla<br />
lettura <strong>di</strong> un romanzo del tempo (e quin<strong>di</strong>, se non ci<br />
fosse stata la cultura – il libro –, essi non si sarebbero<br />
innamorati). Il popolo però poteva capire soltanto<br />
l’amore della bassa nobiltà, a lui socialmente vicina e<br />
perciò conosciuta; non poteva capire l’amore intessuto<br />
<strong>di</strong> cultura e complesso, fisico e soprattutto psicologico<br />
ed estetico, praticato dall’alta nobiltà. Da parte<br />
sua il frate ricostruisce l’amore del cavaliere e della<br />
dama sul tipo <strong>di</strong> amore conosciuto e praticato dal popolo:<br />
tale amore è una proiezione sulla bassa nobiltà<br />
dell’amore fisico e carnale praticato dal popolo.<br />
11. Petrarca gonfia <strong>di</strong> parole i suoi versi e riempie le<br />
sue poesie <strong>di</strong> frasi ai nostri occhi superflue. Passavanti<br />
invece è stringato sino all’osso: è quasi impossibile<br />
riassumere le sue pre<strong>di</strong>che, perché risultano già brevi<br />
come un riassunto. Esse sono essenziali ed efficaci<br />
come uno spot televisivo.<br />
12. La caccia infernale è un motivo molto <strong>di</strong>ffuso nel<br />
Me<strong>di</strong>o Evo. Boccaccio la inserisce in un contesto amoroso<br />
e nobiliare e la piega verso una <strong>di</strong>rezione laica<br />
ed edonistica (Decameron, V, 8).