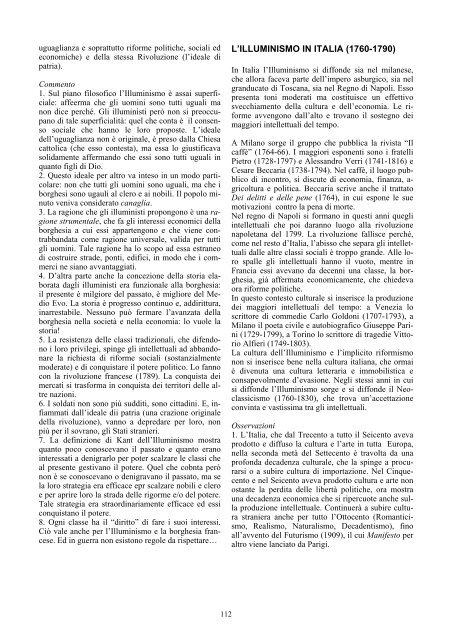pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
uguaglianza e soprattutto riforme politiche, sociali ed<br />
economiche) e della stessa Rivoluzione (l’ideale <strong>di</strong><br />
patria).<br />
Commento<br />
1. Sul piano filosofico l’Illuminismo è assai superficiale:<br />
affeerma che gli uomini sono tutti uguali ma<br />
non <strong>di</strong>ce perché. Gli illuministi però non si preoccupano<br />
<strong>di</strong> tale superficialità: quel che conta è il consenso<br />
sociale che hanno le loro proposte. L’ideale<br />
dell’uguaglianza non è originale, è preso dalla Chiesa<br />
cattolica (che esso contesta), ma essa lo giustificava<br />
solidamente affermando che essi sono tutti uguali in<br />
quanto figli <strong>di</strong> Dio.<br />
2. Questo ideale per altro va inteso in un modo particolare:<br />
non che tutti gli uomini sono uguali, ma che i<br />
borghesi sono ugauli al clero e ai nobili. Il popolo minuto<br />
veniva considerato canaglia.<br />
3. La ragione che gli illuministi propongono è una ragione<br />
strumentale, che fa gli interessi economici della<br />
borghesia a cui essi appartengono e che viene contrabbandata<br />
come ragione universale, valida per tutti<br />
gli uomini. Tale ragione ha lo scopo ad essa estraneo<br />
<strong>di</strong> costruire strade, ponti, e<strong>di</strong>fici, in modo che i commerci<br />
ne siano avvantaggiati.<br />
4. D’altra parte anche la concezione della storia elaborata<br />
dagli illuministi era funzionale alla borghesia:<br />
il presente è milgiore del passato, è migliore del Me<strong>di</strong>o<br />
Evo. La storia è progresso continuo e, ad<strong>di</strong>rittura,<br />
inarrestabile. Nessuno può fermare l’avanzata della<br />
borghesia nella società e nella economia: lo vuole la<br />
storia!<br />
5. La resistenza delle classi tra<strong>di</strong>zionali, che <strong>di</strong>fendono<br />
i loro privilegi, spinge gli intellettuali ad abbandonare<br />
la richiesta <strong>di</strong> riforme sociali (sostanzialmente<br />
moderate) e <strong>di</strong> conquistare il potere politico. Lo fanno<br />
con la rivoluzione francese (1789). La conquista dei<br />
mercati si trasforma in conquista dei territori delle altre<br />
nazioni.<br />
6. I soldati non sono più sud<strong>di</strong>ti, sono citta<strong>di</strong>ni. E, infiammati<br />
dall’ideale <strong>di</strong>i patria (una crazione originale<br />
della rivoluzione), vanno a depredare per loro, non<br />
più per il sovrano, gli Stati stranieri.<br />
7. La definizione <strong>di</strong> Kant dell’Illuminismo mostra<br />
quanto poco conoscevano il passato e quanto erano<br />
interessati a denigrarlo per poter scalzare le classi che<br />
al presente gestivano il potere. Quel che cobnta però<br />
non è se conoscevano o denigravano il passato, ma se<br />
la loro strategia era efficace epr scalzare nobili e clero<br />
e per aprire loro la strada delle rigorme e/o del potere.<br />
Tale strategia era straor<strong>di</strong>nariamente efficace ed essi<br />
conquistano il potere.<br />
8. Ogni classe ha il “<strong>di</strong>ritto” <strong>di</strong> fare i suoi interessi.<br />
Ciò vale anche per l’Illuminismo e la borghesia francese.<br />
Ed in guerra non esistono regole da rispettare…<br />
112<br />
L’ILLUMINISMO IN ITALIA (1760-1790)<br />
In Italia l’Illuminismo si <strong>di</strong>ffonde sia nel milanese,<br />
che allora faceva parte dell’impero asburgico, sia nel<br />
granducato <strong>di</strong> Toscana, sia nel Regno <strong>di</strong> Napoli. Esso<br />
presenta toni moderati ma costituisce un effettivo<br />
svecchiamento della cultura e dell’economia. Le riforme<br />
avvengono dall’alto e trovano il sostegno dei<br />
maggiori intellettuali del tempo.<br />
A Milano sorge il gruppo che pubblica la rivista “Il<br />
caffè” (1764-66). I maggiori esponenti sono i fratelli<br />
Pietro (1728-1797) e Alessandro Verri (1741-1816) e<br />
Cesare Beccaria (1738-1794). Nel caffè, il luogo pubblico<br />
<strong>di</strong> incontro, si <strong>di</strong>scute <strong>di</strong> economia, finanza, agricoltura<br />
e politica. Beccaria scrive anche il trattato<br />
Dei delitti e delle pene (1764), in cui espone le sue<br />
motivazioni contro la pena <strong>di</strong> morte.<br />
Nel regno <strong>di</strong> Napoli si formano in questi anni quegli<br />
intellettuali che poi daranno luogo alla rivoluzione<br />
napoletana del 1799. La rivoluzione fallisce perché,<br />
come nel resto d’Italia, l’abisso che separa gli intellettuali<br />
dalle altre classi sociali è troppo grande. Alle loro<br />
spalle gli intellettuali hanno il vuoto, mentre in<br />
Francia essi avevano da decenni una classe, la borghesia,<br />
già affermata economicamente, che chiedeva<br />
ora riforme politiche.<br />
In questo contesto culturale si inserisce la produzione<br />
dei maggiori intellettuali del tempo: a Venezia lo<br />
scrittore <strong>di</strong> comme<strong>di</strong>e Carlo Goldoni (1707-1793), a<br />
Milano il poeta civile e autobiografico Giuseppe Parini<br />
(1729-1799), a Torino lo scrittore <strong>di</strong> trage<strong>di</strong>e Vittorio<br />
Alfieri (1749-1803).<br />
La cultura dell’Illuminismo e l’implicito riformismo<br />
non si inserisce bene nella cultura <strong>italiana</strong>, che ormai<br />
è <strong>di</strong>venuta una cultura letteraria e immobilistica e<br />
consapevolmente d’evasione. Negli stessi anni in cui<br />
si <strong>di</strong>ffonde l’Illuminismo sorge e si <strong>di</strong>ffonde il Neoclassicismo<br />
(1760-1830), che trova un’accettazione<br />
convinta e vastissima tra gli intellettuali.<br />
Osservazioni<br />
1. L’Italia, che dal Trecento a tutto il Seicento aveva<br />
prodotto e <strong>di</strong>ffuso la cultura e l’arte in tutta Europa,<br />
nella seconda metà del Settecento è travolta da una<br />
profonda decadenza culturale, che la spinge a procurarsi<br />
o a subire cultura <strong>di</strong> importazione. Nel Cinquecento<br />
e nel Seicento aveva prodotto cultura e arte non<br />
ostante la per<strong>di</strong>ta delle libertà politiche, ora mostra<br />
una decadenza economica che si ripercuote anche sulla<br />
produzione intellettuale. Continuerà a subire cultura<br />
straniera anche per tutto l’Ottocento (Romanticismo,<br />
Realismo, Naturalismo, Decadentismo), fino<br />
all’avvento del Futurismo (1909), il cui Manifesto per<br />
altro viene lanciato da Parigi.