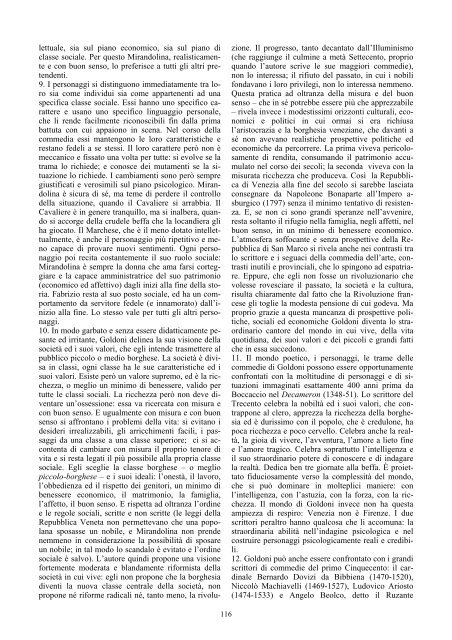pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
pietro genesini appunti e versioni di letteratura italiana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
lettuale, sia sul piano economico, sia sul piano <strong>di</strong><br />
classe sociale. Per questo Mirandolina, realisticamente<br />
e con buon senso, lo preferisce a tutti gli altri pretendenti.<br />
9. I personaggi si <strong>di</strong>stinguono imme<strong>di</strong>atamente tra loro<br />
sia come in<strong>di</strong>vidui sia come appartenenti ad una<br />
specifica classe sociale. Essi hanno uno specifico carattere<br />
e usano uno specifico linguaggio personale,<br />
che li rende facilmente riconoscibili fin dalla prima<br />
battuta con cui appaiono in scena. Nel corso della<br />
comme<strong>di</strong>a essi mantengono le loro caratteristiche e<br />
restano fedeli a se stessi. Il loro carattere però non è<br />
meccanico e fissato una volta per tutte: si evolve se la<br />
trama lo richiede; e conosce dei mutamenti se la situazione<br />
lo richiede. I cambiamenti sono però sempre<br />
giustificati e verosimili sul piano psicologico. Mirandolina<br />
è sicura <strong>di</strong> sé, ma teme <strong>di</strong> perdere il controllo<br />
della situazione, quando il Cavaliere si arrabbia. Il<br />
Cavaliere è in genere tranquillo, ma si inalbera, quando<br />
si accorge della crudele beffa che la locan<strong>di</strong>era gli<br />
ha giocato. Il Marchese, che è il meno dotato intellettualmente,<br />
è anche il personaggio più ripetitivo e meno<br />
capace <strong>di</strong> provare nuovi sentimenti. Ogni personaggio<br />
poi recita costantemente il suo ruolo sociale:<br />
Mirandolina è sempre la donna che ama farsi corteggiare<br />
e la capace amministratrice del suo patrimonio<br />
(economico ed affettivo) dagli inizi alla fine della storia.<br />
Fabrizio resta al suo posto sociale, ed ha un comportamento<br />
da servitore fedele (e innamorato) dall’inizio<br />
alla fine. Lo stesso vale per tutti gli altri personaggi.<br />
10. In modo garbato e senza essere <strong>di</strong>datticamente pesante<br />
ed irritante, Goldoni delinea la sua visione della<br />
società ed i suoi valori, che egli intende trasmettere al<br />
pubblico piccolo o me<strong>di</strong>o borghese. La società è <strong>di</strong>visa<br />
in classi, ogni classe ha le sue caratteristiche ed i<br />
suoi valori. Esiste però un valore supremo, ed è la ricchezza,<br />
o meglio un minimo <strong>di</strong> benessere, valido per<br />
tutte le classi sociali. La ricchezza però non deve <strong>di</strong>ventare<br />
un’ossessione: essa va ricercata con misura e<br />
con buon senso. E ugualmente con misura e con buon<br />
senso si affrontano i problemi della vita: si evitano i<br />
desideri irrealizzabili, gli arricchimenti facili, i passaggi<br />
da una classe a una classe superiore; ci si accontenta<br />
<strong>di</strong> cambiare con misura il proprio tenore <strong>di</strong><br />
vita e si resta legati il più possibile alla propria classe<br />
sociale. Egli sceglie la classe borghese – o meglio<br />
piccolo-borghese – e i suoi ideali: l’onestà, il lavoro,<br />
l’obbe<strong>di</strong>enza ed il rispetto dei genitori, un minimo <strong>di</strong><br />
benessere economico, il matrimonio, la famiglia,<br />
l’affetto, il buon senso. E rispetta ad oltranza l’or<strong>di</strong>ne<br />
e le regole sociali, scritte e non scritte (le leggi della<br />
Repubblica Veneta non permettevano che una popolana<br />
sposasse un nobile, e Mirandolina non prende<br />
nemmeno in considerazione la possibilità <strong>di</strong> sposare<br />
un nobile; in tal modo lo scandalo è evitato e l’or<strong>di</strong>ne<br />
sociale è salvo). L’autore quin<strong>di</strong> propone una visione<br />
fortemente moderata e blandamente riformista della<br />
società in cui vive: egli non propone che la borghesia<br />
<strong>di</strong>venti la nuova classe centrale della società, non<br />
propone né riforme ra<strong>di</strong>cali né, tanto meno, la rivolu-<br />
116<br />
zione. Il progresso, tanto decantato dall’Illuminismo<br />
(che raggiunge il culmine a metà Settecento, proprio<br />
quando l’autore scrive le sue maggiori comme<strong>di</strong>e),<br />
non lo interessa; il rifiuto del passato, in cui i nobili<br />
fondavano i loro privilegi, non lo interessa nemmeno.<br />
Questa pratica ad oltranza della misura e del buon<br />
senso – che in sé potrebbe essere più che apprezzabile<br />
– rivela invece i modestissimi orizzonti culturali, economici<br />
e politici in cui ormai si era richiusa<br />
l’aristocrazia e la borghesia veneziane, che davanti a<br />
sé non avevano realistiche prospettive politiche ed<br />
economiche da percorrere. La prima viveva pericolosamente<br />
<strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta, consumando il patrimonio accumulato<br />
nel corso dei secoli; la seconda viveva con la<br />
misurata ricchezza che produceva. Così la Repubblica<br />
<strong>di</strong> Venezia alla fine del secolo si sarebbe lasciata<br />
consegnare da Napoleone Bonaparte all’Impero asburgico<br />
(1797) senza il minimo tentativo <strong>di</strong> resistenza.<br />
E, se non ci sono gran<strong>di</strong> speranze nell’avvenire,<br />
resta soltanto il rifugio nella famiglia, negli affetti, nel<br />
buon senso, in un minimo <strong>di</strong> benessere economico.<br />
L’atmosfera soffocante e senza prospettive della Repubblica<br />
<strong>di</strong> San Marco si rivela anche nei contrasti tra<br />
lo scrittore e i seguaci della comme<strong>di</strong>a dell’arte, contrasti<br />
inutili e provinciali, che lo spingono ad espatriare.<br />
Eppure, che egli non fosse un rivoluzionario che<br />
volesse rovesciare il passato, la società e la cultura,<br />
risulta chiaramente dal fatto che la Rivoluzione francese<br />
gli toglie la modesta pensione <strong>di</strong> cui godeva. Ma<br />
proprio grazie a questa mancanza <strong>di</strong> prospettive politiche,<br />
sociali ed economiche Goldoni <strong>di</strong>venta lo straor<strong>di</strong>nario<br />
cantore del mondo in cui vive, della vita<br />
quoti<strong>di</strong>ana, dei suoi valori e dei piccoli e gran<strong>di</strong> fatti<br />
che in essa succedono.<br />
11. Il mondo poetico, i personaggi, le trame delle<br />
comme<strong>di</strong>e <strong>di</strong> Goldoni possono essere opportunamente<br />
confrontati con la moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> personaggi e <strong>di</strong> situazioni<br />
immaginati esattamente 400 anni prima da<br />
Boccaccio nel Decameron (1348-51). Lo scrittore del<br />
Trecento celebra la nobiltà ed i suoi valori, che contrappone<br />
al clero, apprezza la ricchezza della borghesia<br />
ed è durissimo con il popolo, che è credulone, ha<br />
poca ricchezza e poco cervello. Celebra anche la realtà,<br />
la gioia <strong>di</strong> vivere, l’avventura, l’amore a lieto fine<br />
e l’amore tragico. Celebra soprattutto l’intelligenza e<br />
il suo straor<strong>di</strong>nario potere <strong>di</strong> conoscere e <strong>di</strong> indagare<br />
la realtà. De<strong>di</strong>ca ben tre giornate alla beffa. È proiettato<br />
fiduciosamente verso la complessità del mondo,<br />
che si può dominare in molteplici maniere: con<br />
l’intelligenza, con l’astuzia, con la forza, con la ricchezza.<br />
Il mondo <strong>di</strong> Goldoni invece non ha questa<br />
ampiezza <strong>di</strong> respiro: Venezia non è Firenze. I due<br />
scrittori peraltro hanno qualcosa che li accomuna: la<br />
straor<strong>di</strong>naria abilità nell’indagine psicologica e nel<br />
costruire personaggi psicologicamente reali e cre<strong>di</strong>bili.<br />
12. Goldoni può anche essere confrontato con i gran<strong>di</strong><br />
scrittori <strong>di</strong> comme<strong>di</strong>e del primo Cinquecento: il car<strong>di</strong>nale<br />
Bernardo Dovizi da Bibbiena (1470-1520),<br />
Niccolò Machiavelli (1469-1527), Ludovico Ariosto<br />
(1474-1533) e Angelo Beolco, detto il Ruzante