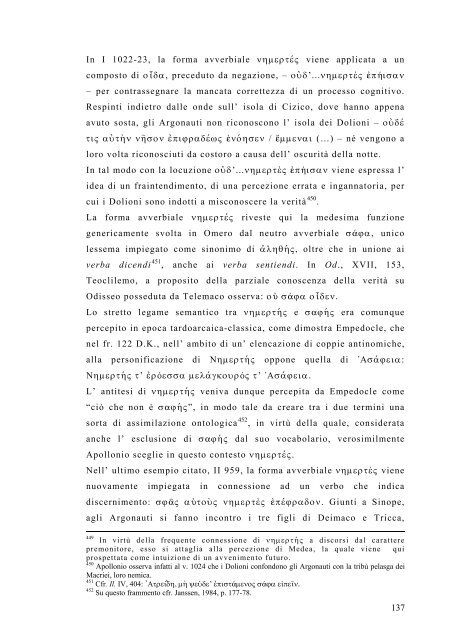Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
In I 1022-23, la forma avverbiale nhmertéj viene applicata a un<br />
composto <strong>di</strong> o%ida, preceduto da negazione, – o÷d’...nhmertèj p»isan<br />
– per contrassegnare la mancata correttezza <strong>di</strong> un processo cognitivo.<br />
Respinti in<strong>di</strong>etro dalle onde sull’ isola <strong>di</strong> Cizico, dove hanno appena<br />
avuto sosta, gli Argonauti non riconoscono l’ isola dei Dolioni – o÷dé<br />
tij a÷tÕn nÖson æpifradéwj nóhsen / œmmenai (…) – né vengono a<br />
loro volta riconosciuti da costoro a causa dell’ oscurità della notte.<br />
In tal modo con la locuzione o÷d’...nhmertèj p»isan viene espressa l’<br />
idea <strong>di</strong> un frainten<strong>di</strong>mento, <strong>di</strong> una percezione errata e ingannatoria, per<br />
cui i Dolioni sono indotti a misconoscere la verità 450 .<br />
La forma avverbiale nhmertéj riveste qui la medesima funzione<br />
genericamente svolta in Omero dal neutro avverbiale s£fa, unico<br />
lessema impiegato come sinonimo <strong>di</strong> ÞlhqÔj, oltre che in unione ai<br />
verba <strong>di</strong>cen<strong>di</strong> 451 , anche ai verba sentien<strong>di</strong>. In Od., XVII, 153,<br />
Teoclilemo, a proposito della parziale conoscenza della verità su<br />
O<strong>di</strong>sseo posseduta da Telemaco osserva: oÙ s£fa o%iden.<br />
Lo stretto legame semantico tra nhmertÔj e safÔj era comunque<br />
percepito in epoca tardoarcaica-classica, come <strong>di</strong>mostra Empedocle, che<br />
nel fr. 122 D.K., nell’ ambito <strong>di</strong> un’ elencazione <strong>di</strong> coppie antinomiche,<br />
alla personificazione <strong>di</strong> NhmertÔj oppone quella <strong>di</strong> 'Asáfeia:<br />
NhmertÔj t’ ærÒessa melágkourÒj t’ 'Asáfeia.<br />
L’ antitesi <strong>di</strong> nhmertÔj veniva dunque percepita da Empedocle come<br />
“ciò che non è safÔj”, in modo tale da creare tra i due termini una<br />
sorta <strong>di</strong> assimilazione ontologica 452 , in virtù della quale, considerata<br />
anche l’ esclusione <strong>di</strong> safÔj dal suo vocabolario, verosimilmente<br />
Apollonio sceglie in questo contesto nhmertéj.<br />
Nell’ ultimo esempio citato, II 959, la forma avverbiale nhmertèj viene<br />
nuovamente impiegata in connessione ad un verbo che in<strong>di</strong>ca<br />
<strong>di</strong>scernimento: sf©j aÙtoùj nhmertèj péfradon. Giunti a Sinope,<br />
agli Argonauti si fanno incontro i tre figli <strong>di</strong> Deimaco e Tricca,<br />
449<br />
In virtù della frequente connessione <strong>di</strong> nhmertÔj a <strong>di</strong>scorsi dal carattere<br />
premonitore, esso si attaglia alla percezione <strong>di</strong> Medea, la quale viene qui<br />
prospettata come intuizione <strong>di</strong> un avvenimento futuro.<br />
450<br />
Apollonio osserva infatti al v. 1024 che i Dolioni confondono gli Argonauti con la tribù pelasga dei<br />
Macriei, loro nemica.<br />
451<br />
Cfr. Il. IV, 404: ŒAtre@idh, mÕ yeúde’ æpist£menoj s£fa e„peîn.<br />
452<br />
Su questo frammento cfr. Janssen, 1984, p. 177-78.<br />
137