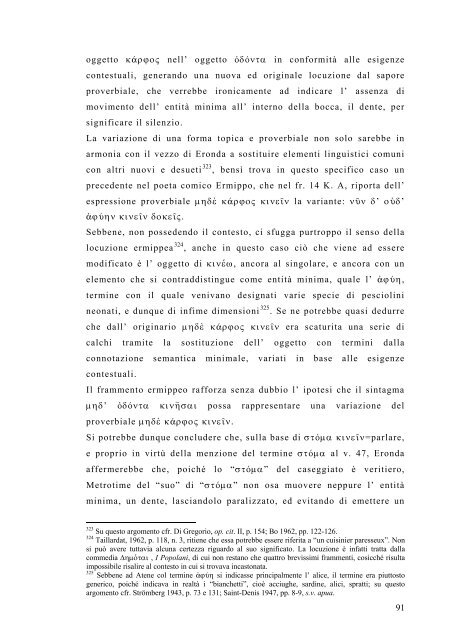Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
oggetto k£rfoj nell’ oggetto ÑdÒnta in conformità alle esigenze<br />
contestuali, generando una nuova ed originale locuzione dal sapore<br />
proverbiale, che verrebbe ironicamente ad in<strong>di</strong>care l’ assenza <strong>di</strong><br />
movimento dell’ entità minima all’ interno della bocca, il dente, per<br />
significare il silenzio.<br />
La variazione <strong>di</strong> una forma topica e proverbiale non solo sarebbe in<br />
armonia con il vezzo <strong>di</strong> Eronda a sostituire elementi linguistici comuni<br />
con altri nuovi e desueti 323 , bensì trova in questo specifico caso un<br />
precedente nel poeta comico Ermippo, che nel fr. 14 K. A, riporta dell’<br />
espressione proverbiale mhdè k£rfoj kine‹n la variante: nàn d’ oÙd’<br />
¢fÚhn kine‹n doke‹j.<br />
Sebbene, non possedendo il contesto, ci sfugga purtroppo il senso della<br />
locuzione ermippea 324 , anche in questo caso ciò che viene ad essere<br />
mo<strong>di</strong>ficato è l’ oggetto <strong>di</strong> kinéw, ancora al singolare, e ancora con un<br />
elemento che si contrad<strong>di</strong>stingue come entità minima, quale l’ ¢fÚh,<br />
termine con il quale venivano designati varie specie <strong>di</strong> pesciolini<br />
neonati, e dunque <strong>di</strong> infime <strong>di</strong>mensioni 325 . Se ne potrebbe quasi dedurre<br />
che dall’ originario mhdè k£rfoj kine‹n era scaturita una serie <strong>di</strong><br />
calchi tramite la sostituzione dell’ oggetto con termini dalla<br />
connotazione<br />
contestuali.<br />
semantica minimale, variati in base alle esigenze<br />
Il frammento ermippeo rafforza senza dubbio l’ ipotesi che il sintagma<br />
mhd’ ÑdÒnta kinÖsai possa rappresentare una variazione del<br />
proverbiale mhdè k£rfoj kine‹n.<br />
Si potrebbe dunque concludere che, sulla base <strong>di</strong> stÒma kine‹n=parlare,<br />
e proprio in virtù della menzione del termine stÒma al v. 47, Eronda<br />
affermerebbe che, poiché lo “stÒma” del caseggiato è veritiero,<br />
Metrotime del “suo” <strong>di</strong> “stÒma” non osa muovere neppure l’ entità<br />
minima, un dente, lasciandolo paralizzato, ed evitando <strong>di</strong> emettere un<br />
323<br />
Su questo argomento cfr. Di Gregorio, op. cit. II, p. 154; Bo 1962, pp. 122-126.<br />
324<br />
Taillardat, 1962, p. 118, n. 3, ritiene che essa potrebbe essere riferita a “un cuisinier paresseux”. Non<br />
si può avere tuttavia alcuna certezza riguardo al suo significato. La locuzione è infatti tratta dalla<br />
comme<strong>di</strong>a Dhmótai , I Popolani, <strong>di</strong> cui non restano che quattro brevissimi frammenti, cosicché risulta<br />
impossibile risalire al contesto in cui si trovava incastonata.<br />
325<br />
Sebbene ad Atene col termine ¢fÚh si in<strong>di</strong>casse principalmente l’ alice, il termine era piuttosto<br />
generico, poiché in<strong>di</strong>cava in realtà i “bianchetti”, cioè acciughe, sar<strong>di</strong>ne, alici, spratti; su questo<br />
argomento cfr. Strömberg 1943, p. 73 e 131; Saint-Denis 1947, pp. 8-9, s.v. apua.<br />
91