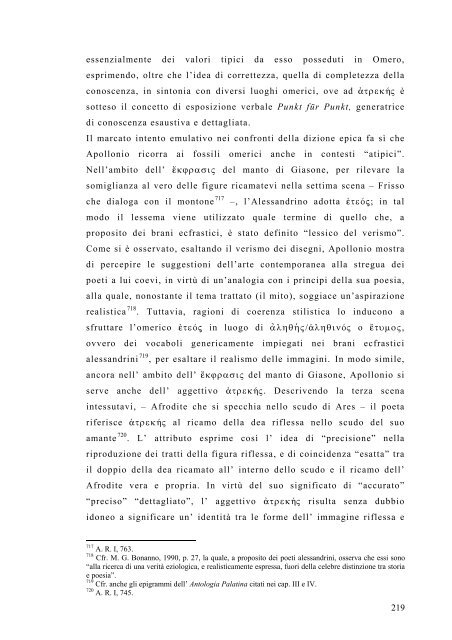Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
essenzialmente dei valori tipici da esso posseduti in Omero,<br />
esprimendo, oltre che l’idea <strong>di</strong> correttezza, quella <strong>di</strong> completezza della<br />
conoscenza, in sintonia con <strong>di</strong>versi luoghi omerici, ove ad ¢trek»j è<br />
sotteso il concetto <strong>di</strong> esposizione verbale Punkt für Punkt, generatrice<br />
<strong>di</strong> conoscenza esaustiva e dettagliata.<br />
Il marcato intento emulativo nei confronti della <strong>di</strong>zione epica fa sì che<br />
Apollonio ricorra ai fossili omerici anche in contesti “atipici”.<br />
Nell’ambito dell’ œkfrasij del manto <strong>di</strong> Giasone, per rilevare la<br />
somiglianza al vero delle figure ricamatevi nella settima scena – Frisso<br />
che <strong>di</strong>aloga con il montone 717 –, l’Alessandrino adotta teÒj; in tal<br />
modo il lessema viene utilizzato quale termine <strong>di</strong> quello che, a<br />
proposito dei brani ecfrastici, è stato definito “lessico del verismo”.<br />
Come si è osservato, esaltando il verismo dei <strong>di</strong>segni, Apollonio mostra<br />
<strong>di</strong> percepire le suggestioni dell’arte contemporanea alla stregua dei<br />
poeti a lui coevi, in virtù <strong>di</strong> un’analogia con i principi della sua poesia,<br />
alla quale, nonostante il tema trattato (il mito), soggiace un’aspirazione<br />
realistica 718 . Tuttavia, ragioni <strong>di</strong> coerenza stilistica lo inducono a<br />
sfruttare l’omerico teÒj in luogo <strong>di</strong> ÞlhqÔj/¢lhqinÒj o œtumoj,<br />
ovvero dei vocaboli genericamente impiegati nei brani ecfrastici<br />
alessandrini 719 , per esaltare il realismo delle immagini. In modo simile,<br />
ancora nell’ ambito dell’ œkfrasij del manto <strong>di</strong> Giasone, Apollonio si<br />
serve anche dell’ aggettivo ¢trek»j. Descrivendo la terza scena<br />
intessutavi, – Afro<strong>di</strong>te che si specchia nello scudo <strong>di</strong> Ares – il poeta<br />
riferisce ¢trek»j al ricamo della dea riflessa nello scudo del suo<br />
amante 720 . L’ attributo esprime così l’ idea <strong>di</strong> “precisione” nella<br />
riproduzione dei tratti della figura riflessa, e <strong>di</strong> coincidenza “esatta” tra<br />
il doppio della dea ricamato all’ interno dello scudo e il ricamo dell’<br />
Afro<strong>di</strong>te vera e propria. In virtù del suo significato <strong>di</strong> “accurato”<br />
“preciso” “dettagliato”, l’ aggettivo ¢trek»j risulta senza dubbio<br />
idoneo a significare un’ identità tra le forme dell’ immagine riflessa e<br />
717<br />
A. R. I, 763.<br />
718<br />
Cfr. M. G. Bonanno, 1990, p. 27, la quale, a proposito dei poeti alessandrini, osserva che essi sono<br />
“alla ricerca <strong>di</strong> una verità eziologica, e realisticamente espressa, fuori della celebre <strong>di</strong>stinzione tra storia<br />
e poesia”.<br />
719<br />
Cfr. anche gli epigrammi dell’ Antologia Palatina citati nei cap. III e IV.<br />
720<br />
A. R. I, 745.<br />
219