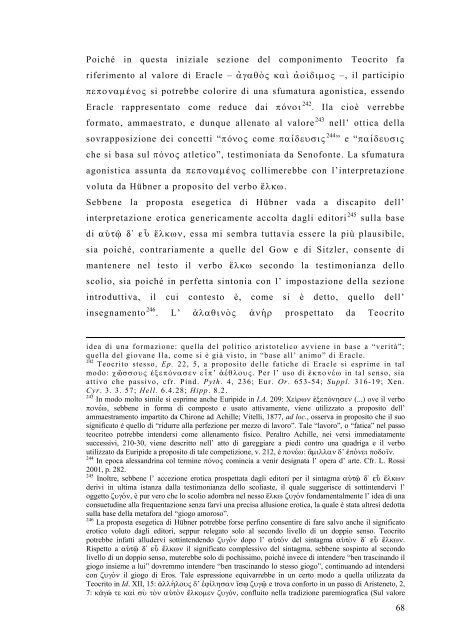Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Poiché in questa iniziale sezione del componimento Teocrito fa<br />
riferimento al valore <strong>di</strong> Eracle – Þgaqòj kaì Þo…<strong>di</strong>moj –, il participio<br />
peponamšnoj si potrebbe colorire <strong>di</strong> una sfumatura agonistica, essendo<br />
Eracle rappresentato come reduce dai pÒnoi 242 . Ila cioè verrebbe<br />
formato, ammaestrato, e dunque allenato al valore 243 nell’ ottica della<br />
sovrapposizione dei concetti “pÒnoj come paídeusij 244 ” e “paídeusij<br />
che si basa sul pÒnoj atletico”, testimoniata da Senofonte. La sfumatura<br />
agonistica assunta da peponamšnoj collimerebbe con l’interpretazione<br />
voluta da Hübner a proposito del verbo ›lkw.<br />
Sebbene la proposta esegetica <strong>di</strong> Hübner vada a <strong>di</strong>scapito dell’<br />
interpretazione erotica genericamente accolta dagli e<strong>di</strong>tori 245 sulla base<br />
<strong>di</strong> aÙtù d' e%u ›lkwn, essa mi sembra tuttavia essere la più plausibile,<br />
sia poiché, contrariamente a quelle del Gow e <strong>di</strong> Sitzler, consente <strong>di</strong><br />
mantenere nel testo il verbo ›lkw secondo la testimonianza dello<br />
scolio, sia poiché in perfetta sintonia con l’ impostazione della sezione<br />
introduttiva, il cui contesto è, come si è detto, quello dell’<br />
insegnamento 246 . L’ ¢laqinòj ¢nÔr prospettato da Teocrito<br />
idea <strong>di</strong> una formazione: quella del politico aristotelico avviene in base a “verità”;<br />
quella del giovane Ila, come si è già visto, in “base all’ animo” <strong>di</strong> Eracle.<br />
242<br />
Teocrito stesso, Ep. 22, 5, a proposito delle fatiche <strong>di</strong> Eracle si esprime in tal<br />
modo: céssouj xepÒnasen e%ip’ ¢éqlouj. Per l’ uso <strong>di</strong> kponéw in tal senso, sia<br />
attivo che passivo, cfr. Pind. Pyth. 4, 236; Eur. Or. 653-54; Suppl. 316-19; Xen.<br />
Cyr. 3. 3. 57; Hell. 6.4.28; Hipp. 8.2.<br />
243<br />
In modo molto simile si esprime anche Euripide in I.A. 209: Ce…rwn xepÒnhsen (...) ove il verbo<br />
ponéw, sebbene in forma <strong>di</strong> composto e usato attivamente, viene utilizzato a proposito dell’<br />
ammaestramento impartito da Chirone ad Achille; Vitelli, 1877, ad loc., osserva in proposito che il suo<br />
significato è quello <strong>di</strong> “ridurre alla perfezione per mezzo <strong>di</strong> lavoro”. Tale “lavoro”, o “fatica” nel passo<br />
teocriteo potrebbe intendersi come allenamento fisico. Peraltro Achille, nei versi imme<strong>di</strong>atamente<br />
successivi, 210-30, viene descritto nell’ atto <strong>di</strong> gareggiare a pie<strong>di</strong> contro una quadriga e il verbo<br />
utilizzato da Euripide a proposito <strong>di</strong> tale competizione, v. 212, è ponéw: ¤millan d’ pónei podoîn.<br />
244<br />
In epoca alessandrina col termine pÒnoj comincia a venir designata l’ opera d’ arte. Cfr. L. Rossi<br />
2001, p. 282.<br />
245<br />
Inoltre, sebbene l’ accezione erotica prospettata dagli e<strong>di</strong>tori per il sintagma aÙtù d' e%u ›lkwn<br />
derivi in ultima istanza dalla testimonianza dello scoliaste, il quale suggerisce <strong>di</strong> sottintendervi l’<br />
oggetto zugón, è pur vero che lo scolio adombra nel nesso ›lkw zugón fondamentalmente l’ idea <strong>di</strong> una<br />
consuetu<strong>di</strong>ne alla frequentazione senza farvi una precisa allusione erotica, la quale è stata altresì dedotta<br />
sulla base della metafora del “giogo amoroso”.<br />
246<br />
La proposta esegetica <strong>di</strong> Hübner potrebbe forse perfino consentire <strong>di</strong> fare salvo anche il significato<br />
erotico voluto dagli e<strong>di</strong>tori, seppur relegato solo al secondo livello <strong>di</strong> un doppio senso. Teocrito<br />
potrebbe infatti alludervi sottintendendo zugón dopo l’ aØtón del sintagma aØtòn d' e%u ›lkwn.<br />
Rispetto a aÙtù d' e%u ›lkwn il significato complessivo del sintagma, sebbene sospinto al secondo<br />
livello <strong>di</strong> un doppio senso, muterebbe solo <strong>di</strong> pochissimo, poiché invece <strong>di</strong> intendere “ben trascinando il<br />
giogo insieme a lui” dovremmo intendere “ben trascinando lo stesso giogo”, continuando ad intendersi<br />
con zugón il giogo <strong>di</strong> Eros. Tale espressione equivarrebbe in un certo modo a quella utilizzata da<br />
Teocrito in Id. XII, 15: ¢llÔlouj d’ æfílhsan ‡sJ zugù e trova conforto in un passo <strong>di</strong> Aristeneto, 2,<br />
7: k¢gè te kaì sù tòn aÙtòn ›lkomen zugÒn, confluito nella tra<strong>di</strong>zione paremiografica (Sul valore<br />
68