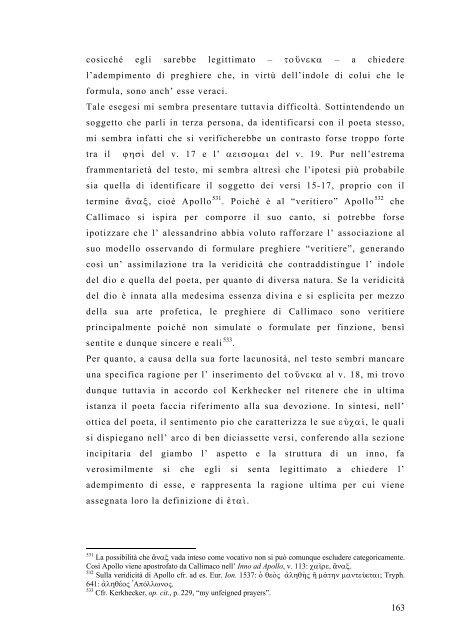Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
cosicché egli sarebbe legittimato – toÜneka – a chiedere<br />
l’adempimento <strong>di</strong> preghiere che, in virtù dell’indole <strong>di</strong> colui che le<br />
formula, sono anch’ esse veraci.<br />
Tale esegesi mi sembra presentare tuttavia <strong>di</strong>fficoltà. Sottintendendo un<br />
soggetto che parli in terza persona, da identificarsi con il poeta stesso,<br />
mi sembra infatti che si verificherebbe un contrasto forse troppo forte<br />
tra il fhsì del v. 17 e l’ aeisomai del v. 19. Pur nell’estrema<br />
frammentarietà del testo, mi sembra altresì che l’ipotesi più probabile<br />
sia quella <strong>di</strong> identificare il soggetto dei versi 15-17, proprio con il<br />
termine ¥nax, cioè Apollo 531 . Poiché è al “veritiero” Apollo 532 che<br />
Callimaco si ispira per comporre il suo canto, si potrebbe forse<br />
ipotizzare che l’ alessandrino abbia voluto rafforzare l’ associazione al<br />
suo modello osservando <strong>di</strong> formulare preghiere “veritiere”, generando<br />
così un’ assimilazione tra la veri<strong>di</strong>cità che contrad<strong>di</strong>stingue l’ indole<br />
del <strong>di</strong>o e quella del poeta, per quanto <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa natura. Se la veri<strong>di</strong>cità<br />
del <strong>di</strong>o è innata alla medesima essenza <strong>di</strong>vina e si esplicita per mezzo<br />
della sua arte profetica, le preghiere <strong>di</strong> Callimaco sono veritiere<br />
principalmente poiché non simulate o formulate per finzione, bensì<br />
sentite e dunque sincere e reali 533 .<br />
Per quanto, a causa della sua forte lacunosità, nel testo sembri mancare<br />
una specifica ragione per l’ inserimento del toÜneka al v. 18, mi trovo<br />
dunque tuttavia in accordo col Kerkhecker nel ritenere che in ultima<br />
istanza il poeta faccia riferimento alla sua devozione. In sintesi, nell’<br />
ottica del poeta, il sentimento pio che caratterizza le sue eÙca…, le quali<br />
si <strong>di</strong>spiegano nell’ arco <strong>di</strong> ben <strong>di</strong>ciassette versi, conferendo alla sezione<br />
incipitaria del giambo l’ aspetto e la struttura <strong>di</strong> un inno, fa<br />
verosimilmente sì che egli si senta legittimato a chiedere l’<br />
adempimento <strong>di</strong> esse, e rappresenta la ragione ultima per cui viene<br />
assegnata loro la definizione <strong>di</strong> taì.<br />
531<br />
La possibilità che ¥nax vada inteso come vocativo non si può comunque escludere categoricamente.<br />
Così Apollo viene apostrofato da Callimaco nell’ Inno ad Apollo, v. 113: caîre, ¥nax.<br />
532<br />
Sulla veri<strong>di</strong>cità <strong>di</strong> Apollo cfr. ad es. Eur. Ion. 1537: ñ qeòς ÞlhqÕj À m£thn manteÚetai; Tryph.<br />
641: Þlhqéoj ƒApÒllwnoς.<br />
533<br />
Cfr. Kerkhecker, op. cit., p. 229, “my unfeigned prayers”.<br />
163