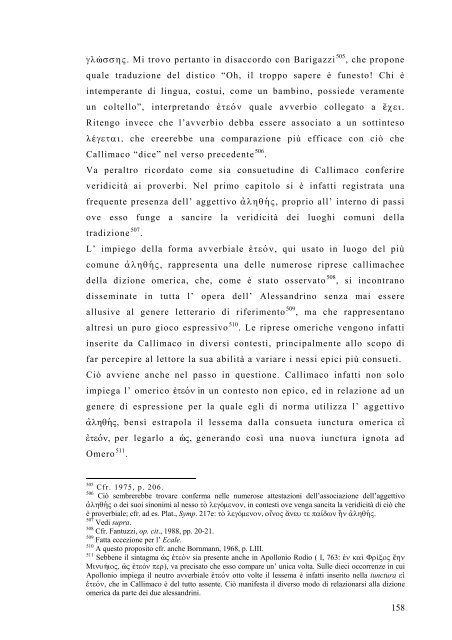Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
glèsshj. Mi trovo pertanto in <strong>di</strong>saccordo con Barigazzi 505 , che propone<br />
quale traduzione del <strong>di</strong>stico “Oh, il troppo sapere è funesto! Chi è<br />
intemperante <strong>di</strong> lingua, costui, come un bambino, possiede veramente<br />
un coltello”, interpretando teón quale avverbio collegato a œcei.<br />
Ritengo invece che l’avverbio debba essere associato a un sottinteso<br />
lšgetai, che creerebbe una comparazione più efficace con ciò che<br />
Callimaco “<strong>di</strong>ce” nel verso precedente 506 .<br />
Va peraltro ricordato come sia consuetu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> Callimaco conferire<br />
veri<strong>di</strong>cità ai proverbi. Nel primo capitolo si è infatti registrata una<br />
frequente presenza dell’ aggettivo ÞlhqÔj, proprio all’ interno <strong>di</strong> passi<br />
ove esso funge a sancire la veri<strong>di</strong>cità dei luoghi comuni della<br />
tra<strong>di</strong>zione 507 .<br />
L’ impiego della forma avverbiale teón, qui usato in luogo del più<br />
comune ÞlhqÔj, rappresenta una delle numerose riprese callimachee<br />
della <strong>di</strong>zione omerica, che, come è stato osservato 508 , si incontrano<br />
<strong>di</strong>sseminate in tutta l’ opera dell’ Alessandrino senza mai essere<br />
allusive al genere letterario <strong>di</strong> riferimento 509 , ma che rappresentano<br />
altresì un puro gioco espressivo 510 . Le riprese omeriche vengono infatti<br />
inserite da Callimaco in <strong>di</strong>versi contesti, principalmente allo scopo <strong>di</strong><br />
far percepire al lettore la sua abilità a variare i nessi epici più consueti.<br />
Ciò avviene anche nel passo in questione. Callimaco infatti non solo<br />
impiega l’ omerico teón in un contesto non epico, ed in relazione ad un<br />
genere <strong>di</strong> espressione per la quale egli <strong>di</strong> norma utilizza l’ aggettivo<br />
ÞlhqÔj, bensì estrapola il lessema dalla consueta iunctura omerica eê<br />
æteón, per legarlo a æj, generando così una nuova iunctura ignota ad<br />
Omero 511 .<br />
505<br />
Cfr. 1975, p. 206.<br />
506<br />
Ciò sembrerebbe trovare conferma nelle numerose attestazioni dell’associazione dell’aggettivo<br />
ÞlhqÔj o dei suoi sinonimi al nesso tò legÒmenon, in contesti ove venga sancita la veri<strong>di</strong>cità <strong>di</strong> ciò che<br />
è proverbiale; cfr. ad es. Plat., Symp. 217e: tò legÒmenon, o%inoj ¥neu te paídwn %hn ÞlhqÔj.<br />
507<br />
Ve<strong>di</strong> supra.<br />
508<br />
Cfr. Fantuzzi, op. cit., 1988, pp. 20-21.<br />
509<br />
Fatta eccezione per l’ Ecale.<br />
510<br />
A questo proposito cfr. anche Bornmann, 1968, p. LIII.<br />
511<br />
Sebbene il sintagma æj teòn sia presente anche in Apollonio Ro<strong>di</strong>o ( I, 763: n kaì Fr…xoj œhn<br />
Minu»ioj, æj teÒn per), va precisato che esso compare un’ unica volta. Sulle <strong>di</strong>eci occorrenze in cui<br />
Apollonio impiega il neutro avverbiale teón otto volte il lessema è infatti inserito nella iunctura eê<br />
æteón, che in Callimaco è del tutto assente. Ciò manifesta il <strong>di</strong>verso modo <strong>di</strong> relazionarsi alla <strong>di</strong>zione<br />
omerica da parte dei due alessandrini.<br />
158