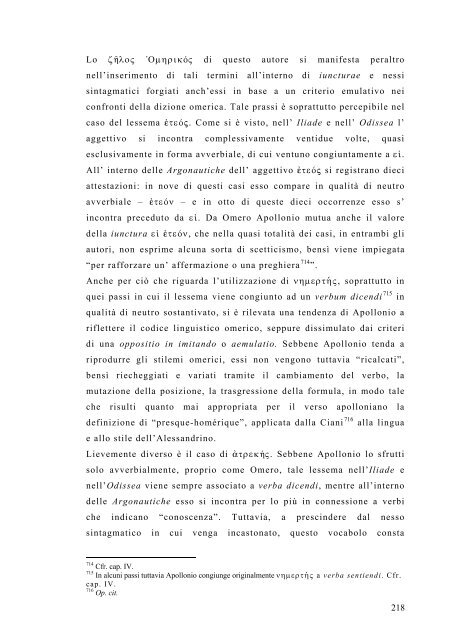Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Lo zÁloj `OmhrikÒj <strong>di</strong> questo autore si manifesta peraltro<br />
nell’inserimento <strong>di</strong> tali termini all’interno <strong>di</strong> iuncturae e nessi<br />
sintagmatici forgiati anch’essi in base a un criterio emulativo nei<br />
confronti della <strong>di</strong>zione omerica. Tale prassi è soprattutto percepibile nel<br />
caso del lessema teÒj. Come si è visto, nell’ Iliade e nell’ O<strong>di</strong>ssea l’<br />
aggettivo si incontra complessivamente ventidue volte, quasi<br />
esclusivamente in forma avverbiale, <strong>di</strong> cui ventuno congiuntamente a e„.<br />
All’ interno delle Argonautiche dell’ aggettivo teÒj si registrano <strong>di</strong>eci<br />
attestazioni: in nove <strong>di</strong> questi casi esso compare in qualità <strong>di</strong> neutro<br />
avverbiale – teÒn – e in otto <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>eci occorrenze esso s’<br />
incontra preceduto da e„. Da Omero Apollonio mutua anche il valore<br />
della iunctura e„ teÒn, che nella quasi totalità dei casi, in entrambi gli<br />
autori, non esprime alcuna sorta <strong>di</strong> scetticismo, bensì viene impiegata<br />
“per rafforzare un’ affermazione o una preghiera 714 ”.<br />
Anche per ciò che riguarda l’utilizzazione <strong>di</strong> nhmertÔj, soprattutto in<br />
quei passi in cui il lessema viene congiunto ad un verbum <strong>di</strong>cen<strong>di</strong> 715 in<br />
qualità <strong>di</strong> neutro sostantivato, si è rilevata una tendenza <strong>di</strong> Apollonio a<br />
riflettere il co<strong>di</strong>ce linguistico omerico, seppure <strong>di</strong>ssimulato dai criteri<br />
<strong>di</strong> una oppositio in imitando o aemulatio. Sebbene Apollonio tenda a<br />
riprodurre gli stilemi omerici, essi non vengono tuttavia “ricalcati”,<br />
bensì riecheggiati e variati tramite il cambiamento del verbo, la<br />
mutazione della posizione, la trasgressione della formula, in modo tale<br />
che risulti quanto mai appropriata per il verso apolloniano la<br />
definizione <strong>di</strong> “presque-homérique”, applicata dalla Ciani 716 alla lingua<br />
e allo stile dell’Alessandrino.<br />
Lievemente <strong>di</strong>verso è il caso <strong>di</strong> ¢trek»j. Sebbene Apollonio lo sfrutti<br />
solo avverbialmente, proprio come Omero, tale lessema nell’Iliade e<br />
nell’O<strong>di</strong>ssea viene sempre associato a verba <strong>di</strong>cen<strong>di</strong>, mentre all’interno<br />
delle Argonautiche esso si incontra per lo più in connessione a verbi<br />
che in<strong>di</strong>cano “conoscenza”. Tuttavia, a prescindere dal nesso<br />
sintagmatico in cui venga incastonato, questo vocabolo consta<br />
714<br />
Cfr. cap. IV.<br />
715<br />
In alcuni passi tuttavia Apollonio congiunge originalmente nhmertÔj a verba sentien<strong>di</strong>. Cfr.<br />
cap. IV.<br />
716<br />
Op. cit.<br />
218