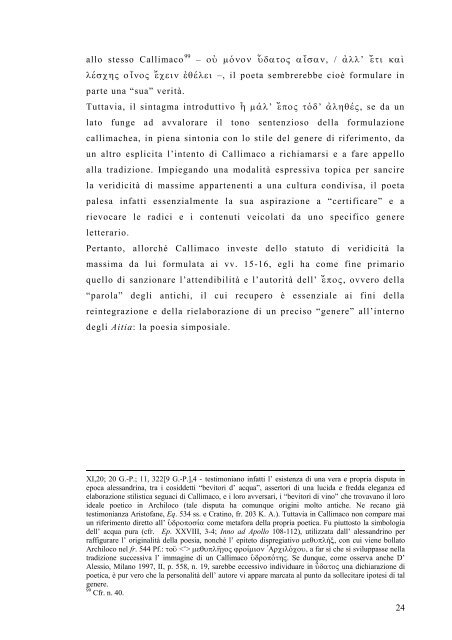Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
allo stesso Callimaco 99 – o÷ mónon !udatoj a%isan, / Þll’ #eti kaì<br />
léschj o%inoj #ecein æqélei –, il poeta sembrerebbe cioè formulare in<br />
parte una “sua” verità.<br />
Tuttavia, il sintagma introduttivo %h mál’ #epoj tód’ Þlhqéj, se da un<br />
lato funge ad avvalorare il tono sentenzioso della formulazione<br />
callimachea, in piena sintonia con lo stile del genere <strong>di</strong> riferimento, da<br />
un altro esplicita l’intento <strong>di</strong> Callimaco a richiamarsi e a fare appello<br />
alla tra<strong>di</strong>zione. Impiegando una modalità espressiva topica per sancire<br />
la veri<strong>di</strong>cità <strong>di</strong> massime appartenenti a una cultura con<strong>di</strong>visa, il poeta<br />
palesa infatti essenzialmente la sua aspirazione a “certificare” e a<br />
rievocare le ra<strong>di</strong>ci e i contenuti veicolati da uno specifico genere<br />
letterario.<br />
Pertanto, allorché Callimaco investe dello statuto <strong>di</strong> veri<strong>di</strong>cità la<br />
massima da lui formulata ai vv. 15-16, egli ha come fine primario<br />
quello <strong>di</strong> sanzionare l’atten<strong>di</strong>bilità e l’autorità dell’ #epoj, ovvero della<br />
“parola” <strong>degli</strong> antichi, il cui recupero è essenziale ai fini della<br />
reintegrazione e della rielaborazione <strong>di</strong> un preciso “genere” all’interno<br />
<strong>degli</strong> Aitia: la poesia simposiale.<br />
XI,20; 20 G.-P.; 11, 322[9 G.-P.],4 - testimoniano infatti l’ esistenza <strong>di</strong> una vera e propria <strong>di</strong>sputa in<br />
epoca alessandrina, tra i cosiddetti “bevitori d’ acqua”, assertori <strong>di</strong> una lucida e fredda eleganza ed<br />
elaborazione stilistica seguaci <strong>di</strong> Callimaco, e i loro avversari, i “bevitori <strong>di</strong> vino” che trovavano il loro<br />
ideale poetico in Archiloco (tale <strong>di</strong>sputa ha comunque origini molto antiche. Ne recano già<br />
testimonianza Aristofane, Eq. 534 ss. e Cratino, fr. 203 K. A.). Tuttavia in Callimaco non compare mai<br />
un riferimento <strong>di</strong>retto all’ ødroposía come metafora della propria poetica. Fu piuttosto la simbologia<br />
dell’ acqua pura (cfr. Ep. XXVIII, 3-4; Inno ad Apollo 108-112), utilizzata dall’ alessandrino per<br />
raffigurare l’ originalità della poesia, nonché l’ epiteto <strong>di</strong>spregiativo mequplήx, con cui viene bollato<br />
Archiloco nel fr. 544 Pf.: toû mequplÖgoj froímion ƒArcilócou, a far sì che si sviluppasse nella<br />
tra<strong>di</strong>zione successiva l’ immagine <strong>di</strong> un Callimaco ødropóthj. Se dunque, come osserva anche D’<br />
Alessio, Milano 1997, II, p. 558, n. 19, sarebbe eccessivo in<strong>di</strong>viduare in !udatoj una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />
poetica, è pur vero che la personalità dell’ autore vi appare marcata al punto da sollecitare ipotesi <strong>di</strong> tal<br />
genere.<br />
99<br />
Cfr. n. 40.<br />
24