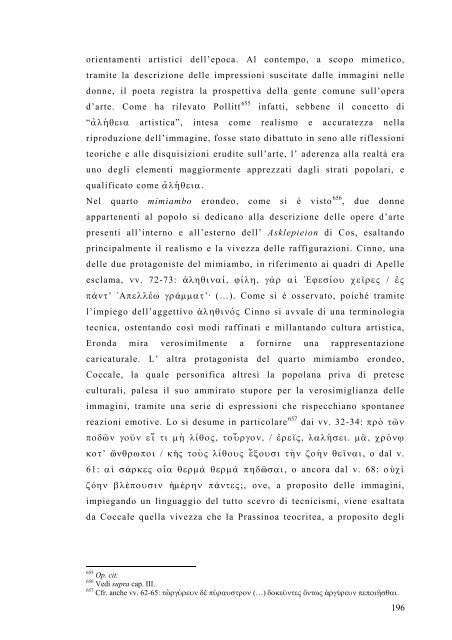Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
orientamenti artistici dell’epoca. Al contempo, a scopo mimetico,<br />
tramite la descrizione delle impressioni suscitate dalle immagini nelle<br />
donne, il poeta registra la prospettiva della gente comune sull’opera<br />
d’arte. Come ha rilevato Pollitt 655 infatti, sebbene il concetto <strong>di</strong><br />
“ÞlÔqeia artistica”, intesa come realismo e accuratezza nella<br />
riproduzione dell’immagine, fosse stato <strong>di</strong>battuto in seno alle riflessioni<br />
teoriche e alle <strong>di</strong>squisizioni eru<strong>di</strong>te sull’arte, l’ aderenza alla realtà era<br />
uno <strong>degli</strong> elementi maggiormente apprezzati dagli strati popolari, e<br />
qualificato come ÞlÔqeia.<br />
Nel quarto mimiambo erondeo, come si è visto 656 , due donne<br />
appartenenti al popolo si de<strong>di</strong>cano alla descrizione delle opere d’arte<br />
presenti all’interno e all’esterno dell’ Asklepieion <strong>di</strong> Cos, esaltando<br />
principalmente il realismo e la vivezza delle raffigurazioni. Cinno, una<br />
delle due protagoniste del mimiambo, in riferimento ai quadri <strong>di</strong> Apelle<br />
esclama, vv. 72-73: ¢lhqinaí, fílh, gàr aƒ 'Efesíou ceîrej / æj<br />
p£nt’ 'Apelléw gr£mmat’: (…). Come si è osservato, poiché tramite<br />
l’impiego dell’aggettivo ¢lhqinój Cinno si avvale <strong>di</strong> una terminologia<br />
tecnica, ostentando così mo<strong>di</strong> raffinati e millantando cultura artistica,<br />
Eronda mira verosimilmente a fornirne una rappresentazione<br />
caricaturale. L’ altra protagonista del quarto mimiambo erondeo,<br />
Coccale, la quale personifica altresì la popolana priva <strong>di</strong> pretese<br />
culturali, palesa il suo ammirato stupore per la verosimiglianza delle<br />
immagini, tramite una serie <strong>di</strong> espressioni che rispecchiano spontanee<br />
reazioni emotive. Lo si desume in particolare 657 dai vv. 32-34: prò tÏn<br />
podÏn goûn e#i ti mÕ líqoj, to#urgon, / æreîj, lalÔsei. mâ, crón_<br />
kot’ ênqrwpoi / kºj toùj líqouj !exousi tÕn zoÕn qeînai, o dal v.<br />
61: aƒ s£rkej oŒa qermà qermà phdîsai, o ancora dal v. 68: oÙcì<br />
zÒhn blšpousin ¹mšrhn p£ntej;, ove, a proposito delle immagini,<br />
impiegando un linguaggio del tutto scevro <strong>di</strong> tecnicismi, viene esaltata<br />
da Coccale quella vivezza che la Prassinoa teocritea, a proposito <strong>degli</strong><br />
655<br />
Op. cit.<br />
656<br />
Ve<strong>di</strong> supra cap. III.<br />
657<br />
Cfr. anche vv. 62-65: tËrgúreun dè púraustron (…) dokeûntej Ôntwj ¢rgÚreun pepoiÖsqai.<br />
196