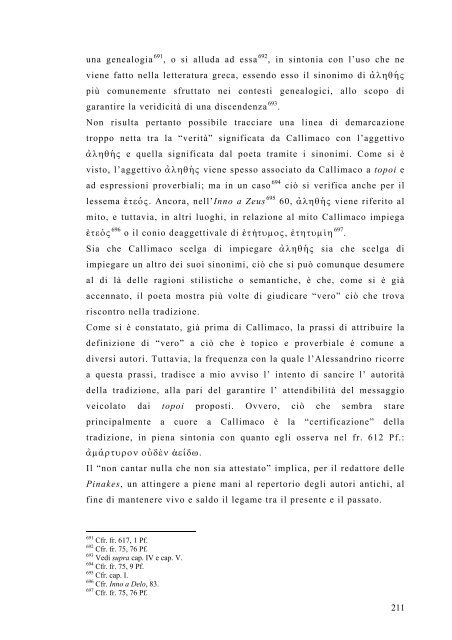Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
una genealogia 691 , o si alluda ad essa 692 , in sintonia con l’uso che ne<br />
viene fatto nella letteratura greca, essendo esso il sinonimo <strong>di</strong> ÞlhqÔj<br />
più comunemente sfruttato nei contesti genealogici, allo scopo <strong>di</strong><br />
garantire la veri<strong>di</strong>cità <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scendenza 693 .<br />
Non risulta pertanto possibile tracciare una linea <strong>di</strong> demarcazione<br />
troppo netta tra la “verità” significata da Callimaco con l’aggettivo<br />
ÞlhqÔj e quella significata dal poeta tramite i sinonimi. Come si è<br />
visto, l’aggettivo ÞlhqÔj viene spesso associato da Callimaco a topoi e<br />
ad espressioni proverbiali; ma in un caso 694 ciò si verifica anche per il<br />
lessema teój. Ancora, nell’Inno a Zeus 695 60, ÞlhqÔj viene riferito al<br />
mito, e tuttavia, in altri luoghi, in relazione al mito Callimaco impiega<br />
teój 696 o il conio deaggettivale <strong>di</strong> t»tumoj, thtum…h 697 .<br />
Sia che Callimaco scelga <strong>di</strong> impiegare ÞlhqÔj sia che scelga <strong>di</strong><br />
impiegare un altro dei suoi sinonimi, ciò che si può comunque desumere<br />
al <strong>di</strong> là delle ragioni stilistiche o semantiche, è che, come si è già<br />
accennato, il poeta mostra più volte <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care “vero” ciò che trova<br />
riscontro nella tra<strong>di</strong>zione.<br />
Come si è constatato, già prima <strong>di</strong> Callimaco, la prassi <strong>di</strong> attribuire la<br />
definizione <strong>di</strong> “vero” a ciò che è topico e proverbiale è comune a<br />
<strong>di</strong>versi autori. Tuttavia, la frequenza con la quale l’Alessandrino ricorre<br />
a questa prassi, tra<strong>di</strong>sce a mio avviso l’ intento <strong>di</strong> sancire l’ autorità<br />
della tra<strong>di</strong>zione, alla pari del garantire l’ atten<strong>di</strong>bilità del messaggio<br />
veicolato dai topoi proposti. Ovvero, ciò che sembra stare<br />
principalmente a cuore a Callimaco è la “certificazione” della<br />
tra<strong>di</strong>zione, in piena sintonia con quanto egli osserva nel fr. 612 Pf.:<br />
Þmárturon o÷dèn ¢eídw.<br />
Il “non cantar nulla che non sia attestato” implica, per il redattore delle<br />
Pinakes, un attingere a piene mani al repertorio <strong>degli</strong> autori antichi, al<br />
fine <strong>di</strong> mantenere vivo e saldo il legame tra il presente e il passato.<br />
691 Cfr. fr. 617, 1 Pf.<br />
692 Cfr. fr. 75, 76 Pf.<br />
693 Ve<strong>di</strong> supra cap. IV e cap. V.<br />
694 Cfr. fr. 75, 9 Pf.<br />
695 Cfr. cap. I.<br />
696 Cfr. Inno a Delo, 83.<br />
697 Cfr. fr. 75, 76 Pf.<br />
211