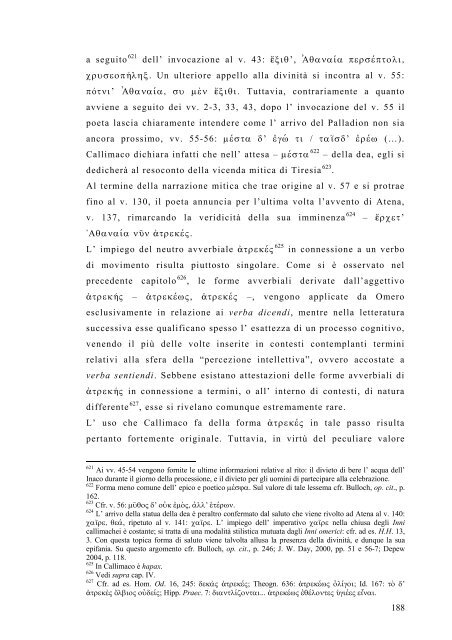Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
a seguito 621 dell’ invocazione al v. 43: œxiq’, ;Aqanaía perséptoli,<br />
cruseop»lhx. Un ulteriore appello alla <strong>di</strong>vinità si incontra al v. 55:<br />
pÒtni’ ;Aqanaía, su mèn œxiqi. Tuttavia, contrariamente a quanto<br />
avviene a seguito dei vv. 2-3, 33, 43, dopo l’ invocazione del v. 55 il<br />
poeta lascia chiaramente intendere come l’ arrivo del Palla<strong>di</strong>on non sia<br />
ancora prossimo, vv. 55-56: mésta d’ ægÍ ti / taîsd’ æréw (…).<br />
Callimaco <strong>di</strong>chiara infatti che nell’ attesa – mésta 622 – della dea, egli si<br />
de<strong>di</strong>cherà al resoconto della vicenda mitica <strong>di</strong> Tiresia 623 .<br />
Al termine della narrazione mitica che trae origine al v. 57 e si protrae<br />
fino al v. 130, il poeta annuncia per l’ultima volta l’avvento <strong>di</strong> Atena,<br />
v. 137, rimarcando la veri<strong>di</strong>cità della sua imminenza 624 – œrcet’<br />
'Aqanaía nàn ¢trekéj.<br />
L’ impiego del neutro avverbiale ¢trekéj 625 in connessione a un verbo<br />
<strong>di</strong> movimento risulta piuttosto singolare. Come si è osservato nel<br />
precedente capitolo 626 , le forme avverbiali derivate dall’aggettivo<br />
¢trek»j – ¢trekéwj, ¢trekéj –, vengono applicate da Omero<br />
esclusivamente in relazione ai verba <strong>di</strong>cen<strong>di</strong>, mentre nella letteratura<br />
successiva esse qualificano spesso l’ esattezza <strong>di</strong> un processo cognitivo,<br />
venendo il più delle volte inserite in contesti contemplanti termini<br />
relativi alla sfera della “percezione intellettiva”, ovvero accostate a<br />
verba sentien<strong>di</strong>. Sebbene esistano attestazioni delle forme avverbiali <strong>di</strong><br />
¢trek»j in connessione a termini, o all’ interno <strong>di</strong> contesti, <strong>di</strong> natura<br />
<strong>di</strong>fferente 627 , esse si rivelano comunque estremamente rare.<br />
L’ uso che Callimaco fa della forma ¢trekéj in tale passo risulta<br />
pertanto fortemente originale. Tuttavia, in virtù del peculiare valore<br />
621 Ai vv. 45-54 vengono fornite le ultime informazioni relative al rito: il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> bere l’ acqua dell’<br />
Inaco durante il giorno della processione, e il <strong>di</strong>vieto per gli uomini <strong>di</strong> partecipare alla celebrazione.<br />
622 Forma meno comune dell’ epico e poetico mésfa. Sul valore <strong>di</strong> tale lessema cfr. Bulloch, op. cit., p.<br />
162.<br />
623 Cfr. v. 56: mûqoj d’ o÷k æmòj, Þll’ çtérwn.<br />
624 L’ arrivo della statua della dea è peraltro confermato dal saluto che viene rivolto ad Atena al v. 140:<br />
caîre, qeá, ripetuto al v. 141: caîre. L’ impiego dell’ imperativo caîre nella chiusa <strong>degli</strong> Inni<br />
callimachei è costante; si tratta <strong>di</strong> una modalità stilistica mutuata dagli Inni omerici: cfr. ad es. H.H. 13,<br />
3. Con questa topica forma <strong>di</strong> saluto viene talvolta allusa la presenza della <strong>di</strong>vinità, e dunque la sua<br />
epifania. Su questo argomento cfr. Bulloch, op. cit., p. 246; J. W. Day, 2000, pp. 51 e 56-7; Depew<br />
2004, p. 118.<br />
625 In Callimaco è hapax.<br />
626 Ve<strong>di</strong> supra cap. IV.<br />
627 Cfr. ad es. Hom. Od. 16, 245: dekàj ¢trekéj; Theogn. 636: ¢trekéwj ðlígoi; Id. 167: tò d’<br />
¢trekèj Ôlbioj o÷deíj; Hipp. Praec. 7: <strong>di</strong>antlízontai... ¢trekéwj æqélontej Øgiéej e%inai.<br />
188