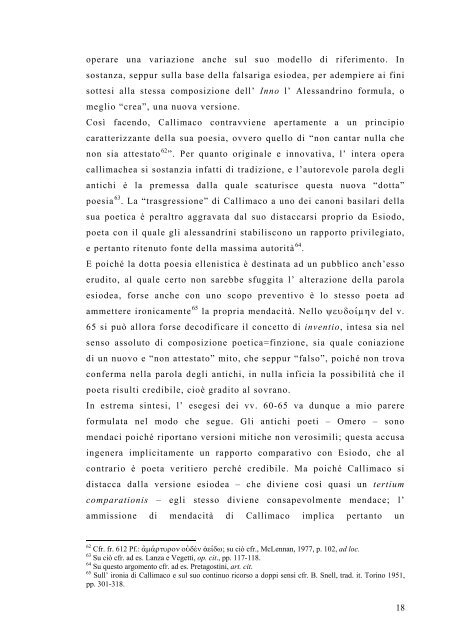Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
operare una variazione anche sul suo modello <strong>di</strong> riferimento. In<br />
sostanza, seppur sulla base della falsariga esiodea, per adempiere ai fini<br />
sottesi alla stessa composizione dell’ Inno l’ Alessandrino formula, o<br />
meglio “crea”, una nuova versione.<br />
Così facendo, Callimaco contravviene apertamente a un principio<br />
caratterizzante della sua poesia, ovvero quello <strong>di</strong> “non cantar nulla che<br />
non sia attestato 62 ”. Per quanto originale e innovativa, l’ intera opera<br />
callimachea si sostanzia infatti <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zione, e l’autorevole parola <strong>degli</strong><br />
antichi è la premessa dalla quale scaturisce questa nuova “dotta”<br />
poesia 63 . La “trasgressione” <strong>di</strong> Callimaco a uno dei canoni basilari della<br />
sua poetica è peraltro aggravata dal suo <strong>di</strong>staccarsi proprio da Esiodo,<br />
poeta con il quale gli alessandrini stabiliscono un rapporto privilegiato,<br />
e pertanto ritenuto fonte della massima autorità 64 .<br />
E poiché la dotta poesia ellenistica è destinata ad un pubblico anch’esso<br />
eru<strong>di</strong>to, al quale certo non sarebbe sfuggita l’ alterazione della parola<br />
esiodea, forse anche con uno scopo preventivo è lo stesso poeta ad<br />
ammettere ironicamente 65 la propria mendacità. Nello yeudoímhn del v.<br />
65 si può allora forse deco<strong>di</strong>ficare il concetto <strong>di</strong> inventio, intesa sia nel<br />
senso assoluto <strong>di</strong> composizione poetica=finzione, sia quale coniazione<br />
<strong>di</strong> un nuovo e “non attestato” mito, che seppur “falso”, poiché non trova<br />
conferma nella parola <strong>degli</strong> antichi, in nulla inficia la possibilità che il<br />
poeta risulti cre<strong>di</strong>bile, cioè gra<strong>di</strong>to al sovrano.<br />
In estrema sintesi, l’ esegesi dei vv. 60-65 va dunque a mio parere<br />
formulata nel modo che segue. Gli antichi poeti – Omero – sono<br />
mendaci poiché riportano versioni mitiche non verosimili; questa accusa<br />
ingenera implicitamente un rapporto comparativo con Esiodo, che al<br />
contrario è poeta veritiero perché cre<strong>di</strong>bile. Ma poiché Callimaco si<br />
<strong>di</strong>stacca dalla versione esiodea – che <strong>di</strong>viene così quasi un tertium<br />
comparationis – egli stesso <strong>di</strong>viene consapevolmente mendace; l’<br />
ammissione <strong>di</strong> mendacità <strong>di</strong> Callimaco implica pertanto un<br />
62<br />
Cfr. fr. 612 Pf.: Þmárturon o÷dèn ¢eídw; su ciò cfr., McLennan, 1977, p. 102, ad loc.<br />
63<br />
Su ciò cfr. ad es. Lanza e Vegetti, op. cit., pp. 117-118.<br />
64<br />
Su questo argomento cfr. ad es. Pretagostini, art. cit.<br />
65<br />
Sull’ ironia <strong>di</strong> Callimaco e sul suo continuo ricorso a doppi sensi cfr. B. Snell, trad. it. <strong>Tor</strong>ino 1951,<br />
pp. 301-318.<br />
18