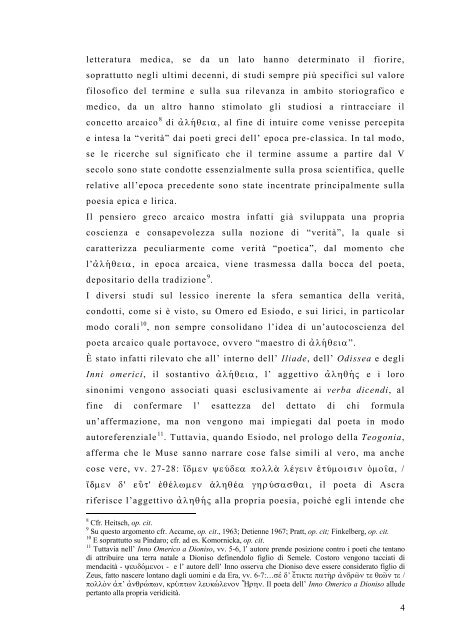Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
letteratura me<strong>di</strong>ca, se da un lato hanno determinato il fiorire,<br />
soprattutto negli ultimi decenni, <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> sempre più specifici sul valore<br />
filosofico del termine e sulla sua rilevanza in ambito storiografico e<br />
me<strong>di</strong>co, da un altro hanno stimolato gli stu<strong>di</strong>osi a rintracciare il<br />
concetto arcaico 8 <strong>di</strong> ÞlÔqeia, al fine <strong>di</strong> intuire come venisse percepita<br />
e intesa la “verità” dai poeti greci dell’ epoca pre-classica. In tal modo,<br />
se le ricerche sul significato che il termine assume a partire dal V<br />
secolo sono state condotte essenzialmente sulla prosa scientifica, quelle<br />
relative all’epoca precedente sono state incentrate principalmente sulla<br />
poesia epica e lirica.<br />
Il pensiero greco arcaico mostra infatti già sviluppata una propria<br />
coscienza e consapevolezza sulla nozione <strong>di</strong> “verità”, la quale si<br />
caratterizza peculiarmente come verità “poetica”, dal momento che<br />
l’ÞlÔqeia, in epoca arcaica, viene trasmessa dalla bocca del poeta,<br />
depositario della tra<strong>di</strong>zione 9 .<br />
I <strong>di</strong>versi stu<strong>di</strong> sul lessico inerente la sfera semantica della verità,<br />
condotti, come si è visto, su Omero ed Esiodo, e sui lirici, in particolar<br />
modo corali 10 , non sempre consolidano l’idea <strong>di</strong> un’autocoscienza del<br />
poeta arcaico quale portavoce, ovvero “maestro <strong>di</strong> ÞlÔqeia”.<br />
È stato infatti rilevato che all’ interno dell’ Iliade, dell’ O<strong>di</strong>ssea e <strong>degli</strong><br />
Inni omerici, il sostantivo ÞlÔqeia, l’ aggettivo ÞlhqÔj e i loro<br />
sinonimi vengono associati quasi esclusivamente ai verba <strong>di</strong>cen<strong>di</strong>, al<br />
fine <strong>di</strong> confermare l’ esattezza del dettato <strong>di</strong> chi formula<br />
un’affermazione, ma non vengono mai impiegati dal poeta in modo<br />
autoreferenziale 11 . Tuttavia, quando Esiodo, nel prologo della Teogonia,<br />
afferma che le Muse sanno narrare cose false simili al vero, ma anche<br />
cose vere, vv. 27-28: ‡dmen yeÚdea poll¦ lšgein tÚmoisin Ðmo‹a, /<br />
‡dmen d' eât' qšlwmen ¢lhqša ghrÚsasqai, il poeta <strong>di</strong> Ascra<br />
riferisce l’aggettivo ÞlhqÔj alla propria poesia, poiché egli intende che<br />
8<br />
Cfr. Heitsch, op. cit.<br />
9<br />
Su questo argomento cfr. Accame, op. cit., 1963; Detienne 1967; Pratt, op. cit; Finkelberg, op. cit.<br />
10<br />
E soprattutto su Pindaro; cfr. ad es. Komornicka, op. cit.<br />
11<br />
Tuttavia nell’ Inno Omerico a Dioniso, vv. 5-6, l’ autore prende posizione contro i poeti che tentano<br />
<strong>di</strong> attribuire una terra natale a Dioniso definendolo figlio <strong>di</strong> Semele. Costoro vengono tacciati <strong>di</strong><br />
mendacità - yeudómenoi - e l’ autore dell’ Inno osserva che Dioniso deve essere considerato figlio <strong>di</strong><br />
Zeus, fatto nascere lontano dagli uomini e da Era, vv. 6-7:…sé d’ #etikte patÕr ÞndrÏn te qeÏn te /<br />
pollòn Þp’ ÞnqrÍpwn, krúptwn leukÍlenon ! Hrhn. Il poeta dell’ Inno Omerico a Dioniso allude<br />
pertanto alla propria veri<strong>di</strong>cità.<br />
4