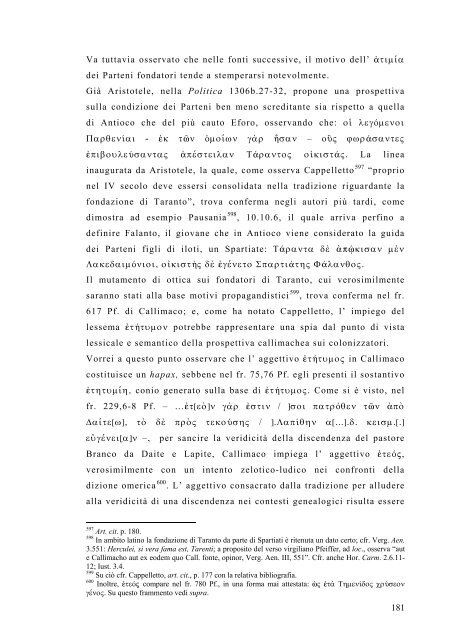Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Va tuttavia osservato che nelle fonti successive, il motivo dell’ ¢timía<br />
dei Parteni fondatori tende a stemperarsi notevolmente.<br />
Già Aristotele, nella Politica 1306b.27-32, propone una prospettiva<br />
sulla con<strong>di</strong>zione dei Parteni ben meno scre<strong>di</strong>tante sia rispetto a quella<br />
<strong>di</strong> Antioco che del più cauto Eforo, osservando che: oë legÒmenoi<br />
Parqen…ai - k tîn Ðmoíwn gàr Ãsan – oÞj fwr£santej<br />
pibouleÚsantaj ¢pésteilan T£rantoj o„kist£j. La linea<br />
inaugurata da Aristotele, la quale, come osserva Cappelletto 597 “proprio<br />
nel IV secolo deve essersi consolidata nella tra<strong>di</strong>zione riguardante la<br />
fondazione <strong>di</strong> Taranto”, trova conferma negli autori più tar<strong>di</strong>, come<br />
<strong>di</strong>mostra ad esempio Pausania 598 , 10.10.6, il quale arriva perfino a<br />
definire Falanto, il giovane che in Antioco viene considerato la guida<br />
dei Parteni figli <strong>di</strong> iloti, un Spartiate: T£ranta dè ¢pókisan mèn<br />
LakedaimÒnioi, o„kist¾j dè géneto Sparti£thj F£lanqoj.<br />
Il mutamento <strong>di</strong> ottica sui fondatori <strong>di</strong> Taranto, cui verosimilmente<br />
saranno stati alla base motivi propagan<strong>di</strong>stici 599 , trova conferma nel fr.<br />
617 Pf. <strong>di</strong> Callimaco; e, come ha notato Cappelletto, l’ impiego del<br />
lessema t»tumon potrebbe rappresentare una spia dal punto <strong>di</strong> vista<br />
lessicale e semantico della prospettiva callimachea sui colonizzatori.<br />
Vorrei a questo punto osservare che l’ aggettivo t»tumoj in Callimaco<br />
costituisce un hapax, sebbene nel fr. 75,76 Pf. egli presenti il sostantivo<br />
thtumíh, conio generato sulla base <strong>di</strong> t»tumoj. Come si è visto, nel<br />
fr. 229,6-8 Pf. – …t[eò]n gàr stin / ]soi patrÒqen tîn ¢pò<br />
Daíte[w], tò dè pròj tekoÚshj / ].Lap…qhn a[...].d. keism.[.]<br />
e÷génei[a]n –, per sancire la veri<strong>di</strong>cità della <strong>di</strong>scendenza del pastore<br />
Branco da Daite e Lapite, Callimaco impiega l’ aggettivo teÒj,<br />
verosimilmente con un intento zelotico-lu<strong>di</strong>co nei confronti della<br />
<strong>di</strong>zione omerica 600 . L’ aggettivo consacrato dalla tra<strong>di</strong>zione per alludere<br />
alla veri<strong>di</strong>cità <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scendenza nei contesti genealogici risulta essere<br />
597 Art. cit. p. 180.<br />
598 In ambito latino la fondazione <strong>di</strong> Taranto da parte <strong>di</strong> Spartiati è ritenuta un dato certo; cfr. Verg. Aen.<br />
3.551: Herculei, si vera fama est, Tarenti; a proposito del verso virgiliano Pfeiffer, ad loc., osserva “aut<br />
e Callimacho aut ex eodem quo Call. fonte, opinor, Verg. Aen. III, 551”. Cfr. anche Hor. Carm. 2.6.11-<br />
12; Iust. 3.4.<br />
599 Su ciò cfr. Cappelletto, art. cit., p. 177 con la relativa bibliografia.<br />
600 Inoltre, teÒj compare nel fr. 780 Pf., in una forma mai attestata: æj tà Thmen…doj crÚseon<br />
génoj. Su questo frammento ve<strong>di</strong> supra.<br />
181