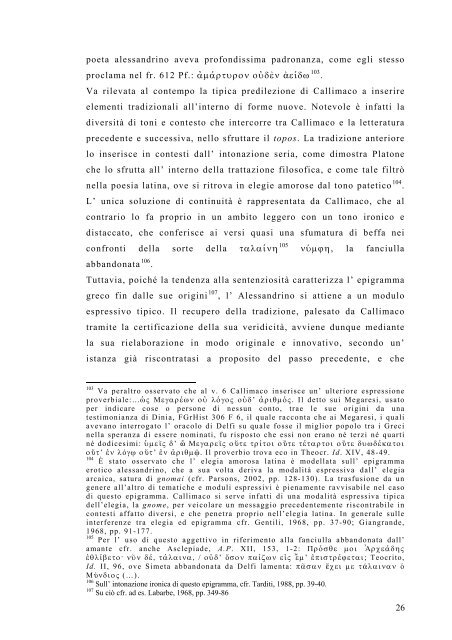Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Visualizza/apri - ART - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
poeta alessandrino aveva profon<strong>di</strong>ssima padronanza, come egli stesso<br />
proclama nel fr. 612 Pf.: Þmárturon o÷dèn ¢eídw 103 .<br />
Va rilevata al contempo la tipica pre<strong>di</strong>lezione <strong>di</strong> Callimaco a inserire<br />
elementi tra<strong>di</strong>zionali all’interno <strong>di</strong> forme nuove. Notevole è infatti la<br />
<strong>di</strong>versità <strong>di</strong> toni e contesto che intercorre tra Callimaco e la letteratura<br />
precedente e successiva, nello sfruttare il topos. La tra<strong>di</strong>zione anteriore<br />
lo inserisce in contesti dall’ intonazione seria, come <strong>di</strong>mostra Platone<br />
che lo sfrutta all’ interno della trattazione filosofica, e come tale filtrò<br />
nella poesia latina, ove si ritrova in elegie amorose dal tono patetico 104 .<br />
L’ unica soluzione <strong>di</strong> continuità è rappresentata da Callimaco, che al<br />
contrario lo fa proprio in un ambito leggero con un tono ironico e<br />
<strong>di</strong>staccato, che conferisce ai versi quasi una sfumatura <strong>di</strong> beffa nei<br />
confronti della sorte della talaính 105 númfh, la fanciulla<br />
abbandonata 106 .<br />
Tuttavia, poiché la tendenza alla sentenziosità caratterizza l’ epigramma<br />
greco fin dalle sue origini 107 , l’ Alessandrino si attiene a un modulo<br />
espressivo tipico. Il recupero della tra<strong>di</strong>zione, palesato da Callimaco<br />
tramite la certificazione della sua veri<strong>di</strong>cità, avviene dunque me<strong>di</strong>ante<br />
la sua rielaborazione in modo originale e innovativo, secondo un’<br />
istanza già riscontratasi a proposito del passo precedente, e che<br />
103 Va peraltro osservato che al v. 6 Callimaco inserisce un’ ulteriore espressione<br />
proverbiale:…Ìj Megaréwn o÷ lógoj o÷d’ Þriqmój. Il detto sui Megaresi, usato<br />
per in<strong>di</strong>care cose o persone <strong>di</strong> nessun conto, trae le sue origini da una<br />
testimonianza <strong>di</strong> Dinia, FGrHist 306 F 6, il quale racconta che ai Megaresi, i quali<br />
avevano interrogato l’ oracolo <strong>di</strong> Delfi su quale fosse il miglior popolo tra i Greci<br />
nella speranza <strong>di</strong> essere nominati, fu risposto che essi non erano né terzi né quarti<br />
né do<strong>di</strong>cesimi: ømeîj d’ ð Megareîj oÜte trítoi oÜte tétartoi oÜte duwdékatoi<br />
oÜt’ æn lÒg_ oÜt’ æn Þriqmù. Il proverbio trova eco in Theocr. Id. XIV, 48-49.<br />
104 È stato osservato che l’ elegia amorosa latina è modellata sull’ epigramma<br />
erotico alessandrino, che a sua volta deriva la modalità espressiva dall’ elegia<br />
arcaica, satura <strong>di</strong> gnomai (cfr. Parsons, 2002, pp. 128-130). La trasfusione da un<br />
genere all’altro <strong>di</strong> tematiche e moduli espressivi è pienamente ravvisabile nel caso<br />
<strong>di</strong> questo epigramma. Callimaco si serve infatti <strong>di</strong> una modalità espressiva tipica<br />
dell’elegia, la gnome, per veicolare un messaggio precedentemente riscontrabile in<br />
contesti affatto <strong>di</strong>versi, e che penetra proprio nell’elegia latina. In generale sulle<br />
interferenze tra elegia ed epigramma cfr. Gentili, 1968, pp. 37-90; Giangrande,<br />
1968, pp. 91-177.<br />
105 Per l’ uso <strong>di</strong> questo aggettivo in riferimento alla fanciulla abbandonata dall’<br />
amante cfr. anche Asclepiade, A.P. XII, 153, 1-2: Prósqe moi ;Arceádhj<br />
æqlíbeto< nûn dé, tálaina, / o÷d’ Óson paízwn eêj #em’ æpistréfetai; Teocrito,<br />
Id. II, 96, ove Simeta abbandonata da Delfi lamenta: pâsan œcei me t£lainan Ð<br />
MÚn<strong>di</strong>oς (…).<br />
106 Sull’ intonazione ironica <strong>di</strong> questo epigramma, cfr. Tar<strong>di</strong>ti, 1988, pp. 39-40.<br />
107 Su ciò cfr. ad es. Labarbe, 1968, pp. 349-86<br />
26