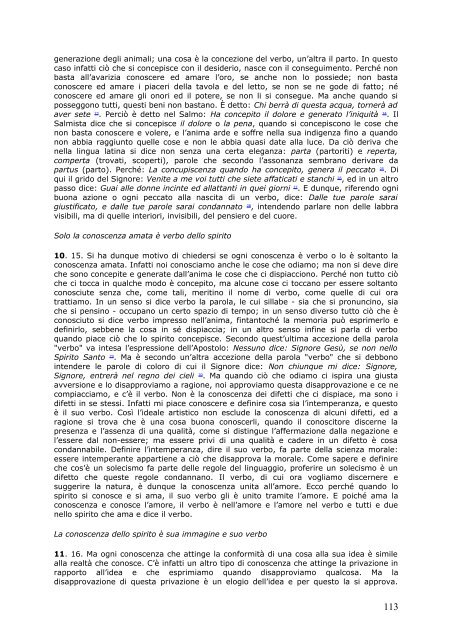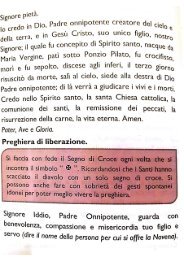Sant'Agostino "De Trinitade"
Il De Trinitate (Sulla Trinità) è un trattato in quindici libri di Agostino d'Ippona, considerato il suo capolavoro dogmatico. Infatti l'opera a quel tempo chiuse per sempre tutte le speculazioni e le incertezze che riguardavano la Trinità ovvero Dio stesso.
Il De Trinitate (Sulla Trinità) è un trattato in quindici libri di Agostino d'Ippona, considerato il suo capolavoro dogmatico. Infatti l'opera a quel tempo chiuse per sempre tutte le speculazioni e le incertezze che riguardavano la Trinità ovvero Dio stesso.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
generazione degli animali; una cosa è la concezione del verbo, un’altra il parto. In questo<br />
caso infatti ciò che si concepisce con il desiderio, nasce con il conseguimento. Perché non<br />
basta all’avarizia conoscere ed amare l’oro, se anche non lo possiede; non basta<br />
conoscere ed amare i piaceri della tavola e del letto, se non se ne gode di fatto; né<br />
conoscere ed amare gli onori ed il potere, se non li si consegue. Ma anche quando si<br />
posseggono tutti, questi beni non bastano. È detto: Chi berrà di questa acqua, tornerà ad<br />
aver sete 23 . Perciò è detto nel Salmo: Ha concepito il dolore e generato l’iniquità 24 . Il<br />
Salmista dice che si concepisce il dolore o la pena, quando si concepiscono le cose che<br />
non basta conoscere e volere, e l’anima arde e soffre nella sua indigenza fino a quando<br />
non abbia raggiunto quelle cose e non le abbia quasi date alla luce. Da ciò deriva che<br />
nella lingua latina si dice non senza una certa eleganza: parta (partoriti) e reperta,<br />
comperta (trovati, scoperti), parole che secondo l’assonanza sembrano derivare da<br />
partus (parto). Perché: La concupiscenza quando ha concepito, genera il peccato 25 . Di<br />
qui il grido del Signore: Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi 26 , ed in un altro<br />
passo dice: Guai alle donne incinte ed allattanti in quei giorni 27 . E dunque, riferendo ogni<br />
buona azione o ogni peccato alla nascita di un verbo, dice: Dalle tue parole sarai<br />
giustificato, e dalle tue parole sarai condannato 28 , intendendo parlare non delle labbra<br />
visibili, ma di quelle interiori, invisibili, del pensiero e del cuore.<br />
Solo la conoscenza amata è verbo dello spirito<br />
10. 15. Si ha dunque motivo di chiedersi se ogni conoscenza è verbo o lo è soltanto la<br />
conoscenza amata. Infatti noi conosciamo anche le cose che odiamo; ma non si deve dire<br />
che sono concepite e generate dall’anima le cose che ci dispiacciono. Perché non tutto ciò<br />
che ci tocca in qualche modo è concepito, ma alcune cose ci toccano per essere soltanto<br />
conosciute senza che, come tali, meritino il nome di verbo, come quelle di cui ora<br />
trattiamo. In un senso si dice verbo la parola, le cui sillabe - sia che si pronuncino, sia<br />
che si pensino - occupano un certo spazio di tempo; in un senso diverso tutto ciò che è<br />
conosciuto si dice verbo impresso nell’anima, fintantoché la memoria può esprimerlo e<br />
definirlo, sebbene la cosa in sé dispiaccia; in un altro senso infine si parla di verbo<br />
quando piace ciò che lo spirito concepisce. Secondo quest’ultima accezione della parola<br />
"verbo" va intesa l’espressione dell’Apostolo: Nessuno dice: Signore Gesù, se non nello<br />
Spirito Santo 29 . Ma è secondo un’altra accezione della parola "verbo" che si debbono<br />
intendere le parole di coloro di cui il Signore dice: Non chiunque mi dice: Signore,<br />
Signore, entrerà nel regno dei cieli 30 . Ma quando ciò che odiamo ci ispira una giusta<br />
avversione e lo disapproviamo a ragione, noi approviamo questa disapprovazione e ce ne<br />
compiacciamo, e c’è il verbo. Non è la conoscenza dei difetti che ci dispiace, ma sono i<br />
difetti in se stessi. Infatti mi piace conoscere e definire cosa sia l’intemperanza, e questo<br />
è il suo verbo. Così l’ideale artistico non esclude la conoscenza di alcuni difetti, ed a<br />
ragione si trova che è una cosa buona conoscerli, quando il conoscitore discerne la<br />
presenza e l’assenza di una qualità, come si distingue l’affermazione dalla negazione e<br />
l’essere dal non-essere; ma essere privi di una qualità e cadere in un difetto è cosa<br />
condannabile. <strong>De</strong>finire l’intemperanza, dire il suo verbo, fa parte della scienza morale:<br />
essere intemperante appartiene a ciò che disapprova la morale. Come sapere e definire<br />
che cos’è un solecismo fa parte delle regole del linguaggio, proferire un solecismo è un<br />
difetto che queste regole condannano. Il verbo, di cui ora vogliamo discernere e<br />
suggerire la natura, è dunque la conoscenza unita all’amore. Ecco perché quando lo<br />
spirito si conosce e si ama, il suo verbo gli è unito tramite l’amore. E poiché ama la<br />
conoscenza e conosce l’amore, il verbo è nell’amore e l’amore nel verbo e tutti e due<br />
nello spirito che ama e dice il verbo.<br />
La conoscenza dello spirito è sua immagine e suo verbo<br />
11. 16. Ma ogni conoscenza che attinge la conformità di una cosa alla sua idea è simile<br />
alla realtà che conosce. C’è infatti un altro tipo di conoscenza che attinge la privazione in<br />
rapporto all’idea e che esprimiamo quando disapproviamo qualcosa. Ma la<br />
disapprovazione di questa privazione è un elogio dell’idea e per questo la si approva.<br />
113