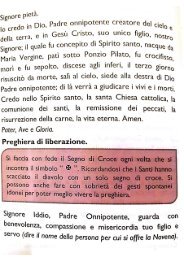Sant'Agostino "De Trinitade"
Il De Trinitate (Sulla Trinità) è un trattato in quindici libri di Agostino d'Ippona, considerato il suo capolavoro dogmatico. Infatti l'opera a quel tempo chiuse per sempre tutte le speculazioni e le incertezze che riguardavano la Trinità ovvero Dio stesso.
Il De Trinitate (Sulla Trinità) è un trattato in quindici libri di Agostino d'Ippona, considerato il suo capolavoro dogmatico. Infatti l'opera a quel tempo chiuse per sempre tutte le speculazioni e le incertezze che riguardavano la Trinità ovvero Dio stesso.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
desiderio di vedere, sia che possa farlo, sia che non lo possa. Dunque questi tre<br />
elementi: il corpo che è veduto, la visione stessa, l’attenzione che unisce l’uno all’altra,<br />
sono manifestamente distinti, non soltanto per le loro proprietà rispettive, ma anche per<br />
la differenza di natura.<br />
L’oggetto visibile imprime negli occhi la sua immagine<br />
2. 3. In questo processo, sebbene il senso non provenga dal corpo veduto, ma dal corpo<br />
del soggetto dotato di sensazione e di vita - il corpo con il quale l’anima, in una maniera<br />
che le è propria, è in una misteriosa consonanza -, tuttavia è il corpo veduto che genera<br />
la visione, cioè è esso che informa il senso, cosicché non c’è più soltanto il senso, che<br />
anche nell’oscurità può restare intatto, finché gli occhi rimangono incolumi, ma c’è anche<br />
il senso informato, che si chiama visione. Dunque la visione è generata dall’oggetto<br />
visibile ma non da esso solo: occorre che ci sia anche uno che vede. Perciò la visione è<br />
generata dall’oggetto visibile e dal soggetto che vede; al soggetto che vede<br />
appartengono il senso della vista e l’attenzione con cui guarda e vede, mentre<br />
l’informazione del senso, che è chiamata visione, è impressa soltanto dal corpo veduto,<br />
cioè, da un oggetto visibile; se si toglie questa non rimane alcuna forma, che era<br />
inerente al senso mentre era presente l’oggetto veduto, ma rimane il senso che esisteva<br />
anche prima che percepisse cosa alcuna. Così l’acqua conserva il vestigio di un corpo<br />
fintantoché le è presente il corpo che pone in essa la sua impronta, ma se lo si toglie,<br />
non vi rimane traccia, sebbene rimanga l’acqua, che esisteva anche prima che ricevesse<br />
la forma di quel corpo. Perciò non possiamo dire che l’oggetto visibile generi il senso:<br />
genera tuttavia la forma che è come una sua somiglianza e che si produce nel senso<br />
quando, con la vista, percepiamo qualcosa. Ma non è lo stesso senso che ci permette di<br />
distinguere la forma del corpo che vediamo e la forma da essa prodotta nel senso del<br />
soggetto che vede, perché è così intima la loro unione, che non lascia luogo ad alcuna<br />
distinzione. È invece attraverso la ragione che possiamo concludere che la sensazione<br />
sarebbe del tutto impossibile se non si producesse nel nostro senso una certa similitudine<br />
del corpo percepito. Infatti, quando si applica alla cera un sigillo, non si può dire che non<br />
vi si produca alcuna immagine, per il motivo che essa non si può discernere, se non dopo<br />
la separazione. Ma perché la cera, una volta separata dal sigillo, conserva un’impronta<br />
visibile, ci persuadiamo facilmente che esisteva già nella cera l’impronta impressa dal<br />
sigillo, anche prima che esso ne fosse separato. Ma se applichiamo un sigillo ad un<br />
elemento liquido, una volta che lo si è tolto, non vi resta alcuna immagine; nondimeno la<br />
ragione non dovrebbe non comprendere che la forma del sigillo, da esso impressa,<br />
esisteva nel liquido, prima che si togliesse l’anello. Questa forma si deve distinguere da<br />
quella che è nell’anello; essa ne è il prodotto, essa che non esisterà più una volta tolto<br />
l’anello, benché rimanga nell’anello la forma che ha prodotto l’altra. Così del senso della<br />
vista non si può dire che non possiede l’immagine del corpo veduto, fintantoché lo<br />
percepisce, per il fatto che una volta che si toglie il corpo, l’immagine non resta. Con<br />
questo paragone si può, sebbene con molta difficoltà, convincere gli spiriti più tardi che si<br />
forma nel nostro senso un’immagine dell’oggetto visibile, quando lo vediamo, e che<br />
questa forma è la visione.<br />
Il fatto è spiegato con un esempio<br />
2. 4. Ma coloro che, per caso, hanno fatto l’esperienza che ricorderò, non proveranno<br />
tanta fatica in questa ricerca. Molto spesso, quando, per un certo tempo, abbiamo tenuto<br />
gli occhi fissi su qualche luce e poi li chiudiamo, crediamo di vedere passare davanti al<br />
nostro sguardo dei colori brillanti e vari che si succedono gli uni agli altri e che, sempre<br />
meno risplendenti, finiscono con lo scomparire del tutto. Bisogna ben comprendere che<br />
essi sono come tenue vestigio di quella forma impressa nel senso, al momento in cui il<br />
corpo luminoso si offriva alla vista e che a poco a poco, quasi gradualmente, variando,<br />
scompare. Se noi, per caso, contemplavamo le inferriate delle finestre di uno stabile,<br />
esse ci sono apparse spesso con determinati colori; è chiaro che questa affezione si era<br />
impressa nel nostro senso per opera dell’oggetto che contemplavamo. Essa esisteva<br />
127