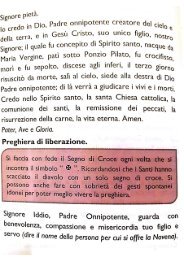Sant'Agostino "De Trinitade"
Il De Trinitate (Sulla Trinità) è un trattato in quindici libri di Agostino d'Ippona, considerato il suo capolavoro dogmatico. Infatti l'opera a quel tempo chiuse per sempre tutte le speculazioni e le incertezze che riguardavano la Trinità ovvero Dio stesso.
Il De Trinitate (Sulla Trinità) è un trattato in quindici libri di Agostino d'Ippona, considerato il suo capolavoro dogmatico. Infatti l'opera a quel tempo chiuse per sempre tutte le speculazioni e le incertezze che riguardavano la Trinità ovvero Dio stesso.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
7. 12. È ora più difficile discernere bene se la volontà che unisce la visione alla memoria<br />
non abbia con qualcuna delle due un rapporto di paternità e di filiazione. Ciò che rende<br />
difficile questa distinzione è la parità e l’eguaglianza di natura e di sostanza. Infatti qui<br />
non accade come nella conoscenza di un oggetto esterno, dove è facile distinguere il<br />
senso informato e il corpo sensibile e la volontà dall’uno e dall’altro, a motivo della<br />
differenza di natura che oppone tra loro tutti questi tre elementi, come abbiamo<br />
sufficientemente spiegato prima. Sebbene la trinità, di cui ora si tratta, sia stata<br />
introdotta dall’esterno nell’anima, tuttavia si attua nell’interno e nessuno dei suoi<br />
elementi è estraneo alla natura dell’anima stessa. In qual maniera dunque si può<br />
dimostrare che la volontà non è quasi genitrice, neppure quasi prole, né dell’immagine<br />
corporea contenuta nella memoria, né di quella che quando ricordiamo ne è<br />
l’espressione, dato che la volontà nell’atto di pensare unisce l’una all’altra in modo tale<br />
che appaia un qualcosa di singolare ed unico, i cui elementi non si possono discernere se<br />
non con la ragione? E bisogna rilevare anzitutto che non potrebbe esistere la volontà di<br />
ricordare, se non conservassimo nelle profondità più riposte della memoria tutta o in<br />
parte la cosa che vogliamo ricordare. Infatti quando ci siamo dimenticati in modo totale<br />
ed assoluto di una cosa, non ha origine nemmeno la volontà di ricordarla, perché di<br />
qualsiasi cosa che vogliamo ricordare, ci ricordiamo già che essa esiste o esisteva nella<br />
nostra memoria. Per esempio, se voglio ricordare che cosa abbia mangiato ieri sera a<br />
cena, mi ricordo già che ho cenato, o se questo ricordo mi sfugge ancora, mi ricordo<br />
almeno qualche circostanza relativa all’ora di cena; non foss’altro, almeno, mi ricordo il<br />
giorno di ieri, la parte del giorno in cui si ha l’abitudine di cenare, e che cosa sia cenare.<br />
Perché se non mi ricordassi niente di simile, non potrei voler ricordare che cosa abbia<br />
mangiato ieri a cena. Da queste cose si può comprendere che la volontà di ricordare<br />
procede dalle immagini contenute nella memoria, alle quali vengono ad aggiungersi<br />
quelle che ne sono l’espressione nella visione che produce l’evocazione del ricordo, cioè<br />
essa procede dall’unione tra la cosa che ricordiamo e la visione che ne scaturisce nello<br />
sguardo del pensiero, quando evochiamo il ricordo. La stessa volontà che unisce questi<br />
due elementi ne esige un terzo, che è, in qualche modo, vicino e prossimo a colui che<br />
ricorda. Vi sono dunque tante trinità di questo genere, quanti sono gli atti di ricordare,<br />
perché è impossibile alcun ricordo se non ci sono questi tre elementi: ciò che è latente<br />
nella memoria anche prima che lo si pensi, ciò che si produce nel pensiero quando lo si<br />
guarda, e la volontà che unisce l’uno all’altro e che, terzo termine, aggiungentesi agli altri<br />
due, fa dell’insieme un tutto compiuto. A meno che non si voglia vedere qui una sola<br />
trinità generica, così da chiamare una unità generica tutte le forme corporee latenti nella<br />
memoria, e poi un’altra unità la visione generale dell’anima che tali cose ricorda e pensa,<br />
all’unione delle quali due unità si aggiunge la volontà unificante, come terzo elemento, in<br />
modo che da questi tre termini si formi un tutto unico.<br />
Memoria ed immaginazione<br />
8. Ma poiché l’occhio dell’anima non può abbracciare con un solo sguardo tutto insieme<br />
ciò che la memoria ritiene, si alternano di volta in volta, cedendo il posto e succedendosi<br />
le trinità degli atti di pensiero, e così ha origine questa trinità innumerevolmente<br />
numerosa: non infinita tuttavia, se non si supera il numero delle cose racchiuse nella<br />
memoria. Infatti, a partire dal momento in cui ciascuno ha cominciato a sentire i corpi<br />
grazie all’uno o all’altro dei sensi corporei, anche se potesse aggiungervi tutto ciò che ha<br />
dimenticato, il numero dei ricordi sarebbe fisso e determinato, ancorché innumerevole.<br />
Noi infatti chiamiamo innumerevoli non solo le cose infinite, ma anche le quantità finite<br />
che superano la nostra capacità di contare.<br />
8. 13. A partire da queste riflessioni si può rilevare in maniera un po’ più chiara che una<br />
cosa è ciò che è tenuto occulto nella memoria, altra cosa ciò che se ne esprime nel<br />
pensiero dell’uomo che ricorda, sebbene, quando si verifica la loro unione, sembrino<br />
costituire una cosa unica ed identica, perché non possiamo ricordarci delle forme<br />
corporee, se non in base al numero, all’intensità e al modo delle nostre sensazioni; infatti<br />
è a partire dal senso corporeo che l’anima si impregna di queste forme incidendole nella<br />
133