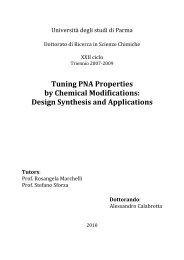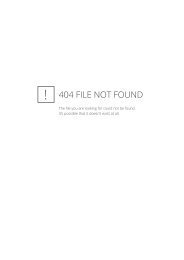Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ora i tegoli battagliati ora la pagina secca,<br />
ascoltavo morire la parola d’un poeta o mutarsi<br />
in altra, non per noi più, voce. Gli oppressi<br />
sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli<br />
parlano nei telefoni, l’odio è cortese, io stesso<br />
credo di non sapere più di chi è la colpa.<br />
[…]<br />
(Traducendo Brecht, in <strong>Una</strong> volta per sempre)<br />
A differenza di Brecht, <strong>che</strong> scriveva in un’Europa sottomessa al nazismo e alla guerra,<br />
per Fortini la parola poetica non è un progetto realizzabile, perché storicamente e<br />
ideologicamente la colpa non è più concepibile come un elemento esterno, ma ha<br />
assediato e preso possesso dell’io. 25 Se il temporale <strong>che</strong> si abbatte sui tetti rappresenta la<br />
forza viva della natura, la «pagina secca» fa pensare all’aridità di un deserto <strong>che</strong> si è<br />
trasferito all’interno del poeta e <strong>che</strong> alberga nelle sue parole, <strong>che</strong> non si fanno più voce:<br />
i «versi di cemento e di vetro» sono la metafora della doppia natura della poesia, <strong>che</strong><br />
rappresenta la durezza e l’asprezza, ma an<strong>che</strong> la fragilità della parola <strong>che</strong> prende le<br />
distanze dagli «oppressori tranquilli». L’antitesi non agisce solo tra presente e futuro,<br />
ma è parte del presente stesso e della parola: al centro sta l’immagine di<br />
disappropriazione <strong>che</strong> invade la <strong>lingua</strong>, per cui si ascolta «morire / la parola d’un poeta<br />
o mutarsi / in altra, non per noi più, voce» (<strong>che</strong> anticipa la «<strong>lingua</strong> non più sua» di<br />
Molto chiare si vedono le cose, in Composita solvantur). La crisi della parola diventa<br />
emblema di una soggettività lacerata e precaria, <strong>che</strong> sembra smarrire la coscienza di sé,<br />
dichiarando il proprio disorientamento («credo di non sapere più di chi è la colpa»).<br />
Alla visione della società <strong>che</strong> emergeva da Foglio di via, in cui «gli uomini gli<br />
apparivano divisi in vittime e carnefici, oppressori e oppressi, ricchi e poveri: non in<br />
classi», 26 si sostituisce una prospettiva più complessa e carica di tensioni. Dopo gli<br />
ideali condivisi della Resistenza, quando un progetto collettivo sembrava possibile, ora<br />
Fortini si trova a vivere in una società statica, <strong>che</strong> al cambiamento ha preferito la<br />
ripetizione di gesti meccanici, e dove la contrapposizione di classe e la lotta politica<br />
sono state soffocate dal totalitarismo soft dei consumi. Tuttavia egli non si piega<br />
all’«odio cortese» degli oppressori, e rivolge la sua critica contro coloro <strong>che</strong> «credono di<br />
non sapere», <strong>che</strong> credono di non avere responsabilità, <strong>che</strong> si accontentano e sono<br />
25 Si potrebbero ricordare a questo proposito gli ultimi due versi di In una casa vuota di Vittorio Sereni: «Oggi si<br />
è – e si è comunque male, / parte del male tu stesso tornino o no sole e prato coperti». Per l’analisi tematica di questo<br />
componimento si rimanda al capitolo successivo.<br />
26 Franco Fortini, Prefazione 1967 a Foglio di via in <strong>Una</strong> volta per sempre. Poesie 1938-1973, cit., p. 359.<br />
109