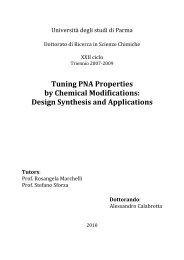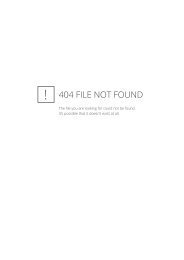Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Addio fanciullo, entra nel buio ancora.<br />
E questa è la mia strada, buio sul fiume.<br />
Fin <strong>che</strong> il mondo vorrà. Ma il nostro lume<br />
segreto si riaccende, ad ora ad ora.<br />
(Sandro Penna, Addio fanciullo, entra nel buio ancora, in Stranezze)<br />
Nel primo verso di questa poesia l’avverbio «ancora» dice un presente <strong>che</strong> ritorna, come<br />
pure, alla fine, il verbo «riaccende»: il buio e il lume sono destinati a ripetersi «Fin <strong>che</strong><br />
il mondo vorrà». Eros tende il tempo e allontana la morte, generando un desiderio<br />
inesausto, sempre rinnovabile e sempre rivolto a quei fanciulli eterni adolescenti nei<br />
quali non v’è traccia d’evoluzione. 48 In Caproni, invece, la morte conferisce dimensione<br />
al tempo, è coscienza del suo trascorrere, del passaggio dal poco al nulla. Questo<br />
sentimento si rafforza nel contrasto con la percezione del passato: di fronte ai<br />
trasalimenti dell’essere il tempo non è più ripetibilità, ma rottura. Si pensi ad esempio<br />
all’incipit di Ad Olga Franzoni (in Ballo a Fontanigorda): «Questo <strong>che</strong> in madreperla /<br />
di lacrime nei tuoi morenti / occhi si chiuse chiaro / paese». Qui il «si chiuse» porta a<br />
pensare <strong>che</strong> la morte abbia storicizzato l’evento, sottraendolo quindi alla finzione<br />
poetica e collocandolo nell’elegia, nel pianto. Il passato remoto, del resto, è il tempo<br />
degli eventi considerati fuori della loro durata e definitivamente conclusi. Per via di<br />
negazione si arriva ad affermare il valore relativo dell’attualità del ricordo, mettendo<br />
quindi in crisi il valore assoluto del presente. In questo Caproni vitale e sensuale c’è già<br />
Penna, si diceva, ma nello stesso tempo egli è oltre Penna. Questi sembra porre la<br />
trasgressione più a livello tematico <strong>che</strong> linguistico, e continuando a riflettere sul<br />
desiderio rimane prigioniero della sua ossessione. Penna è «poeta esclusivo d’amore»<br />
(Stranezze), an<strong>che</strong> se di un amore <strong>che</strong> è croce e delizia: «a tale monotematismo» scrive<br />
Mengaldo, «corrisponde puntualmente la perfetta unitarietà del <strong>lingua</strong>ggio, […] certo<br />
l’esempio di monolinguismo lirico più rigoroso e assoluto del nostro Novecento». 49<br />
Caproni, invece, riflettendo sulla storia, acquista coscienza dello sviluppo diacronico del<br />
<strong>lingua</strong>ggio, ossia della sua evoluzione come elemento critico e trasgressivo. Il<br />
<strong>lingua</strong>ggio, come luogo del sapere e del mostrasi della vita nel testo poetico, viene<br />
48 Ivi, p. 13: «Volendo di passaggio accennare a dei moventi psicologici è chiaro <strong>che</strong> la patente omosessualità di<br />
Penna e la sua fissazione allo stato anale determinano una non coscienza del tempo. Ormai è nozione comune <strong>che</strong><br />
l’Es sia atemporale e si spiega come per il poeta il desiderio dell’incontro sessuale nella sua concretezza […] sia il<br />
centro attorno a cui ruota tutta una vita. Non esiste e non può esistere nessuna evoluzione per la spinta pulsionale».<br />
49 Pier Vincenzo Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, Milano, Mondadori, 1978, p. 736.<br />
54