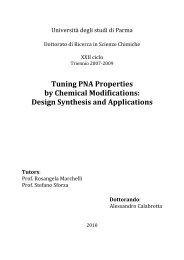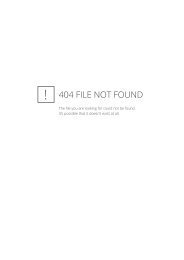Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Poesia significa in primo luogo libertà. Libertà e disobbedienza di fronte<br />
ad ogni forma di sopraffazione o di annullamento della persona: di fronte ad<br />
ogni forma di irregimentazione o, peggio, di massificazione. La società in cui<br />
viviamo minaccia con sempre maggior pesantezza i più elementari diritti del<br />
singolo: minaccia la distruzione totale del privato (della persona), per ridurre<br />
gli individui a una somma di «consumatori», ai quali – nell’imperante<br />
mercificazione an<strong>che</strong> di quelle <strong>che</strong> una volta venivano chiamate le<br />
aspirazioni spirituali – si vorrebbe imporre bisogni artificialmente creati per<br />
alimentare una macchina economica <strong>che</strong> trae a sé tutto il profitto, a pieno<br />
scapito d’ogni scelta interiore. Il poeta è il più deciso oppositore, per sua<br />
propria natura, di tale sistema. È il più strenuo difensore della singolarità,<br />
rifiutando d’istinto ogni parola d’ordine. E per questo il sistema lo avversa,<br />
sia ignorandolo o fingendo d’ignorarlo, sia cercando di minimizzarne la<br />
figura con l’arma della sufficienza e dell’ironia. 18<br />
Il <strong>lingua</strong>ggio poetico deve, quindi, rispondere a un’esigenza etica ancor prima <strong>che</strong><br />
estetica. Il fine di tale <strong>lingua</strong>ggio è la rappresentazione di un mondo interiore ed<br />
esteriore, una fisicità della parola da opporre alla barbarie dei tempi. La concretezza<br />
leggera e luminosa di Penna, fatta di fanciulli, mare, scogli, stazioni e orinatoi (veri e<br />
propri emblemi di un’anima), quella di Caproni, sensuale e allo stesso tempo cruda e<br />
aspra, una fisica dei sensi 19 con cui si vorrebbe modellare l’ontologia e la psicologia del<br />
mondo, 20 la frontiera rappresentata dalla Luino della giovinezza di Sereni, così come la<br />
spazialità notturna, sospesa tra finito e infinito del primo Fortini, già proteso verso il<br />
futuro, fanno emergere una dimensione metaforica, il correlativo oggettivo di una<br />
situazione interiore, <strong>che</strong> presto lascia l’aura autobiografica, per diventare condizione<br />
collettiva e condivisa: 21<br />
Mi risveglio dal sonno, è una notte d’inverno,<br />
lontani sono i sogni, il libro è caduto,<br />
non vengono rumori sul vento della città.<br />
Guarda, mi dico, non è vero <strong>che</strong> siamo d’inverno,<br />
<strong>che</strong> sono morti gli amici e orrida cosa è vivere:<br />
vedrai domani alla prima luce ci desteremo<br />
18<br />
Giorgio Caproni, Sulla poesia, in La scatola nera, cit., p. 38. Caproni parla di «rovine invisibili», così come<br />
Pasolini di «macerie di valori»: «[…] non ci troviamo tra macerie, sia pur strazianti, di case e monumenti, ma tra<br />
“macerie di valori”: “valori” umanistici e, quel <strong>che</strong> più importa, popolari» (Pier Paolo Pasolini, Lettere luterane,<br />
Torino, Einaudi, 1976, p. 83).<br />
19<br />
Cfr. Andrea Cortellessa, La fisica del senso. Saggi e interventi su poeti italiani dal 1940 a oggi, Roma, Fazi,<br />
2006.<br />
20<br />
Cfr. Fabio Moliterni, Poesia e pensiero nell’opera di Giorgio Caproni e di Vittorio Sereni, cit., p. 31: la poesia<br />
tende a «circoscrivere (an<strong>che</strong> a rischio dell’impoverimento e dell’autolimitazione della propria vena espressiva e<br />
ideale) un racconto poetico fatto di figure, di esperienze sensibili e psicologi<strong>che</strong>, entro un’economia formale e una<br />
precisione di <strong>lingua</strong>ggio».<br />
21<br />
E per avere un’idea del clima di quegli anni, si legga Franco Fortini, Dieci inverni, Bari, De Donato, 1973, p.<br />
30: «Erano inverni profondi, faticosi. Le rovine <strong>che</strong> avevamo intorno come allegoria di un riscatto possibile sparivano<br />
per dar luogo ad una città opulenta e meschina. […] Eppure bisognava impararne l’avvenire. Volevamo sperare di<br />
decifrarvi i destini personali e generali. Perché il mondo, come dice Schlegel, è e rimane la nostra unica spiegazione».<br />
16