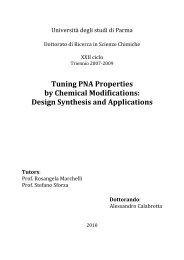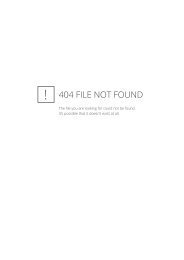Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
fenomeni non ha reazioni, ma torna al grado zero della poesia, percependo i suoi oggetti<br />
in maniera volutamente immediata. Non si tratta di superficialità del sentire, piuttosto di<br />
un troppo sentire al quale l’io sopravvive soltanto diminuendolo, tramutandolo in<br />
languore, in una «dolce pena» (Porto con me la dolce pena. Erro, in Poesie inedite), o<br />
trasformandolo nella leggerezza luminosa <strong>che</strong> esorcizza la fine. Il presente di tante sue<br />
poesie realizza quindi una «partecipazione inquieta a una vita ai confini della<br />
moralità»: 13 nell’hic et nunc dell’evento non rimane spazio per la riflessione morale o<br />
per la rielaborazione della coscienza, ma solo per una vitalità al limite, o meglio al di là<br />
del bene e del male. Questa è la salvezza di cui la poesia ci fa dono. Nella mancanza di<br />
conflitti morali si realizza il tentativo di sottrarre alla morte l’eternità di un istante. Per<br />
questo nelle sue poesie prevale una memoria a breve termine <strong>che</strong>, sebbene sia «immersa<br />
nella temporalità», 14 non contempla la profondità storica, ma dà l’impressione <strong>che</strong> la<br />
scrittura poetica si componga di appunti presi per fissare l’attimo. 15 In realtà gli studi<br />
condotti sugli epistolari con Saba e Montale e sui manoscritti rinvenuti dopo la sua<br />
morte attestano un importante lavoro di rielaborazione e una fitta trama di varianti. 16 In<br />
diversi casi le poesie venivano scritte come per fermare il ricordo di sensazioni vissute<br />
mesi prima, 17 e la sovrapposizione di presente e passato, di esperienza e finzione<br />
poetica, determinava quella chiarezza e quella precisione attraverso cui un episodio<br />
opaco, perché banale e privo di significati, si illuminava di un tempo assoluto, trattenuto<br />
prima di perdersi nell’oblio della dimenticanza. An<strong>che</strong> il ripetersi sistematico di certi<br />
avverbi è una spia importante e controllata del modo di percepire il tempo. Le<br />
illuminazioni, gli improvvisi delle sue poesie sono còlti nel momento di massima<br />
13<br />
Anna Vaglio, Invito alla lettura di Penna, Milano, Mursia, 1996, p. 110.<br />
14<br />
Così Daniela Mar<strong>che</strong>schi, Sandro Penna. Corpo, tempo e narratività, cit., p. 15.<br />
15<br />
Appunti è an<strong>che</strong> il titolo della seconda raccolta poetica di Penna, pubblicata a Milano dalle Edizioni della<br />
Meridiana nel 1950.<br />
16<br />
A questo proposito si vedano almeno: Eugenio Montale, Sandro Penna, Lettere e minute 1932-1938, a cura di<br />
Roberto Deidier, introduzione di Elio Pecora, Milano, Archinto, 1995; Umberto Saba, Lettere a Sandro Penna 1929-<br />
1940, a cura di Roberto Deidier, Milano, Archinto, 1997; e in particolare Roberto Deidier, L’officina di Penna. Le<br />
poesie 1939. Storia e apparato critico, cit., pp. 13;14-15; 21; 23: «Gli inediti giovanili di Confuso sogno hanno<br />
invece dimostrato il lento sedimentarsi della scrittura penniana nel corso degli anni venti e i suoi precoci debiti<br />
europei, specie verso Hölderlin, Baudelaire, Rimbaud»; «se da un lato Penna accredita il mito della poesia spontanea,<br />
della scrittura miracolo, relegando nell’ombra quel lungo e denso processo di chiarificazione interiore attestato dalle<br />
carte e ricostruito dal biografo [Elio Pecora], La vita… è ricordarsi di un risveglio marca indiscutibilmente l’inizio di<br />
quella nuova consapevolezza espressiva di cui il volume del 1939 rende testimonianza»; «Considerando i diversi tipi<br />
di nastro e di caratteri con i quali Penna ricopia a macchina i suoi versi […] è possibile stabilire, con una certa<br />
approssimazione, almeno quattro fasi redazionali, rispondenti ad altrettante copiature, tra gli esordi e il 1937»; «Il<br />
gioco variantistico condotto da Penna nei confronti di Saba risulta ambiguo; po<strong>che</strong> sono le lezioni accolte».<br />
17<br />
Così Elio Pecora, Sandro Penna: una <strong>che</strong>ta follia, cit., p. 104: «In dicembre, il giorno 8, come ripetendo e<br />
definitivamente fermando un momento dell’ultima estate, quando da Recanati era sceso alla stazione, scrisse i versi<br />
<strong>che</strong> intitolò “Estate”».<br />
43