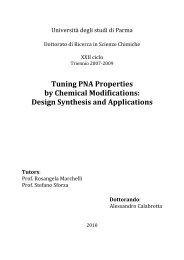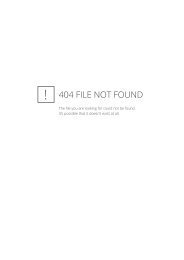Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
fa oracolare. Per abolire «lo stato di cose presente» l’autore deve porsi in una<br />
dimensione <strong>che</strong> sia già al di fuori, tra gli «spiriti curiosi in ascolto», da cui guardare alla<br />
vita con la sicurezza di chi ha rotto i legami con la norma e può vedere le cose libero dai<br />
condizionamenti della società. In questo senso si può interpretare la differenza<br />
linguistica tra il parlato estremamente colloquiale e abbassato di tono <strong>che</strong> troviamo in<br />
La spiaggia di Sereni e la <strong>lingua</strong> dalla «fermezza classica» 40 della poesia di Fortini, <strong>che</strong><br />
vuole affermare delle verità «prima del sonno» della ragione. Lo sguardo si volge ai<br />
limiti stessi della parola poetica, agli ostacoli <strong>che</strong> essa incontra nel suo cammino: «Tutto<br />
è diventato gravemente oscuro», e «La verità cade fuori dalla coscienza», quindi «Non<br />
sapremo se avremo avuto ragione». Al presente si sostituisce il futuro anteriore, un<br />
futuro <strong>che</strong> in qual<strong>che</strong> modo è già stato, e <strong>che</strong> complica la dialettica tra ciò <strong>che</strong> è già e il<br />
non ancora. Attraverso una dimensione sfaccettata si anticipa un tempo diverso, in cui<br />
convivono il prima e il dopo, il passato, certo, ma an<strong>che</strong> il “futuro del futuro”, il “dopo<br />
futuro”, perché anch’esso è solo una tappa di un processo <strong>che</strong> non si esaurisce. Sottratta<br />
dunque alle forme più rigide del tempo e dell’essere <strong>che</strong> ingabbiano il reale, ridotta a<br />
puro pensiero, la scrittura stessa si rivela in tale necessaria spoliazione: 41 «Nulla <strong>che</strong><br />
prima non sia perduto ci serve», scrive Fortini, indicando nella disappropriazione<br />
l’unica via per osservare la realtà senza infingimenti. Egli sembra volersi soprattutto<br />
liberare dalla percezione dei sensi, per attingere a una dimensione di pensiero e<br />
intelletto assoluti, <strong>che</strong> possano resistere a quel «Tutto» <strong>che</strong> è «divenuto gravemente<br />
oscuro». Il centro della poesia, an<strong>che</strong> a livello formale, è costituito dall’avversativa «Ma<br />
guarda», <strong>che</strong> lungi dall’introdurre nel dominio della vista, apre lo spazio della visione di<br />
dell’orizzonte immediato sono però la premessa di un movimento di natura diversa». Mi sovvengono, per contrasto<br />
alcuni versi dell’Idrometra di Giorgio Caproni, in cui si esprime un massimo grado di sfiducia nel futuro: «Di noi,<br />
testimoni del mondo, / tutte andranno perdute / le nostre testimonianze». L’atteggiamento di Fortini manifesta invece<br />
un intento testamentario, <strong>che</strong> è stato così descritto da Giovanni Raboni: «per non avallare il presente, <strong>che</strong> gli ripugna<br />
(e dunque, fra l’altro, per non accettare di rivolgersi, come tutti i poeti moderni, soltanto a se stesso), Fortini<br />
immagina (vuole immaginare) di rivolgersi ai posteri, <strong>che</strong>, in un futuro liberato, leggeranno i suoi versi. È chiaro <strong>che</strong><br />
il futuro grammaticale è solo un sintomo – una spia appunto – di questa volontà. Fortini, in un certo senso, diventa<br />
egli stesso quei posteri; ne prefigura e ne adotta il punto di vista; ne simula il distacco, il raccapriccio, l’ironica<br />
comprensione, la fredda pietà» (Giovanni Raboni, La poesia <strong>che</strong> si fa. Cronaca e storia del Novecento poetico<br />
italiano 1959-2004, cit., p. 259).<br />
40 Romano Luperini, Il futuro di Fortini, cit., p. 16: «il classicismo è assunto […] non come innocenza o evasione<br />
o ricerca di purezza, ma, tutt’al contrario, per far stridere passato e presente e per tale via ellitticamente parlare del<br />
futuro». E si legga an<strong>che</strong> Guido Mazzoni, Forma e solitudine. Un’idea della poesia contemporanea, cit., pp. 199-<br />
202. 41 Cfr. Roberto Galaverni, Il poeta è un cavaliere Jedi. <strong>Una</strong> difesa della poesia, cit., p. 85: «Credo <strong>che</strong> fosse per<br />
lui il modo di osservare il precetto del suo amato Kafka, secondo cui per scrivere è prima necessario perdere tutto. E<br />
appunto qui, nell’assenza di una diretta relazione sensibile con la realtà circostante nella solitudine di chi non<br />
possiede più nulla per sé, va trovata la percezione originaria delle cose da parte di Fortini. <strong>Una</strong> percezione del<br />
pensiero, dunque, piuttosto <strong>che</strong> dei sensi».<br />
168