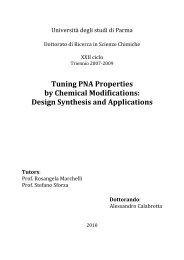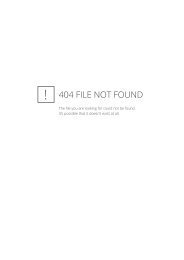Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
del segnato da Dio.<br />
Fra poco sarà buio, sarà l’urlío<br />
d’aria, dei cani alla catena e<br />
delle piccole fiere le veloci<br />
le disperate imprese.<br />
Ma prima di rispondere di no,<br />
ecco, guardiamo ancora, vi prego, i prati<br />
dove in pianto eravamo passati,<br />
le vigne e di alti nidi immenso l’albero!<br />
E fedeli chiediamo di portare<br />
un’altra volta ancora<br />
ai mormorii della fedele mezzanotte<br />
l’intelletto delle erbe e il nostro.<br />
(Franco Fortini, Qualcuno è fermo…, in Composita solvantur)<br />
Nella prima strofa al tempo presente si alterna il passato, il momento del ricordo viene<br />
introdotto da tre punti di sospensione esattamente a metà strofa, come se le due parti<br />
fossero speculari, come se nella prima un io già postumo osservasse una scena <strong>che</strong> ha a<br />
<strong>che</strong> fare con la propria esperienza passata e riconoscesse in questa i segni di<br />
un’esistenza comune. Presente e passato si confrontano sul terreno della negatività, <strong>che</strong><br />
sembra assumere tratti simili al décor dei versi dell’ultimo Caproni: il «paese chiuso /<br />
dove non c’era anima viva» potrebbe essere scambiato per uno dei «luoghi non<br />
giurisdizionali» menzionati nell’Ultimo borgo del Franco cacciatore, <strong>che</strong> prefigurano<br />
un paesaggio di morte o <strong>che</strong> sono già morte calata nella vita. Tuttavia, la seconda strofa<br />
reagisce a questa situazione di stallo quasi con un sobbalzo, uno scotimento: mentre<br />
nella prima il passaggio dal presente al passato avveniva con la sospensione creata dai<br />
tre punti, ora lo stacco è netto, il balzo nel futuro è evidenziato graficamente dallo<br />
spazio bianco, <strong>che</strong> implica un momento di rottura con cui il futuro si inserisce<br />
bruscamente nella dinamica temporale del testo. Il verbo al futuro preannuncia segni di<br />
morte e sofferenza («Fra poco sarà buio, sarà l’urlío»), le immagini evocano scene di<br />
violenza (il vento, il latrato «dei cani alla catena» le «disperate imprese» delle «piccole<br />
fiere»): è un mondo sconvolto da una bufera notturna, quasi una «bufera infernale <strong>che</strong><br />
mai non resta». An<strong>che</strong> questa seconda strofa è mossa da una dinamica interna articolata<br />
in una struttura ben precisa, <strong>che</strong> può essere scomposta in tre scene, ognuna di quattro<br />
versi. Della prima si è già detto. Ad essa fa seguito una avversativa («Ma prima di<br />
rispondere di no, / ecco, guardiamo ancora, vi prego, i prati»), <strong>che</strong> sposta il discorso al<br />
presente e mette al centro della scena (ma di fatto dell’intera strofa) il «guardiamo<br />
172