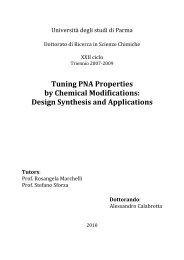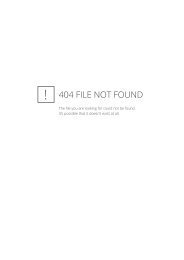Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
esistergli, ma difende an<strong>che</strong> da una realtà <strong>che</strong> nasconde un concentrato distruttivo<br />
totalizzante. Il rapporto tra io e natura si propone di interpretare il presente, non di<br />
ignorarlo o negarlo. 25 In una poesia del 1984 (La prossima abolizione della natura), poi<br />
inclusa, con altro titolo, in Composita solvantur, è lei a fornire ancora al poeta<br />
protezione e difesa contro l’assedio del vuoto, proponendosi come un mondo di ideali<br />
sfinito e vinto (come le utopie), ma in qual<strong>che</strong> modo salvifico:<br />
Le piccole piante mi vengono incontro e mi dicono:<br />
«Tu, lo sappiamo, nulla puoi fare per noi.<br />
Ma se vorrai entreremo nella tua stanza,<br />
rami e radici fra le carte avranno scampo».<br />
Ho detto di sì a quella loro domanda<br />
e il gregge di foglie ora è qui <strong>che</strong> mi guarda.<br />
Con le foreste riposerò e le erbe sfinite,<br />
vinte innumerabili armate <strong>che</strong> mi difendono.<br />
(Franco Fortini, Le piccole piante…, in Composita solvantur)<br />
Sebbene in questi versi si celi un sentimento semplice di appartenenza, di «solidarietà<br />
reciproca tra passati, presenti e futuri, e tra ordini e classi biologi<strong>che</strong> ed esistenziali», 26<br />
il problema rimane: una volta fattane esperienza, il limite mette in discussione il nostro<br />
stesso essere nel mondo, ai confini del nulla. Il desiderio di coincidenza si svolge in una<br />
doppia dinamica di fissione e fusione, composizione e dissoluzione, per cui accanto al<br />
carattere onnicomprensivo della natura, si pone, in maniera problematica, la bi-logica<br />
ambigua e sfuggente del rapporto tra l’io e il mondo, nel riflesso <strong>che</strong> ci definisce e ci<br />
sgomenta. 27 Allo stesso tempo le piante, come «allegoria dell’alterità», 28 segnano sì la<br />
distanza, ma an<strong>che</strong> la prossimità di tutto ciò <strong>che</strong> non rimane irrelato e <strong>che</strong> acquista un<br />
significato nell’uomo e per l’uomo. Questo pensiero può trovare il suo giusto<br />
completamento se consideriamo altre immagini <strong>che</strong> esemplificano la lotta contro la<br />
cancellazione totale (l’abolizione, appunto): in <strong>Una</strong> facile allegoria (Poesia e errore) il<br />
«pezzo di legno secco», è «calore futuro, disgregata vivezza», perché scalderà l’uomo<br />
nei mesi invernali. Il tempo grande dell’evoluzione, sebbene appaia come un tempo<br />
25 Tale prospettiva va dialetticamente integrata con quanto scrive Mengaldo: «la natura stessa, <strong>che</strong> occupa sempre<br />
più la poesia del Fortini anziano, non è tanto un’antistoria quanto, a guardar bene, un antipresente» (Pier Vincenzo<br />
Mengaldo, Per Franco Fortini, in La tradizione del Novecento. Quarta serie, cit., p. 265).<br />
26 Così Paolo Jachia, Franco Fortini. Un ritratto, cit., p. 121.<br />
27 Così Luca Lenzini, Il poeta di nome Fortini. Saggi e proposte di lettura, cit., p. 97: «quel <strong>che</strong> conta è <strong>che</strong><br />
manca la volontà d’immedesimazione romantica con la natura: la natura resta “altra” in Fortini; il bosco è<br />
definitivamente lontano».<br />
28 Ibidem.<br />
188