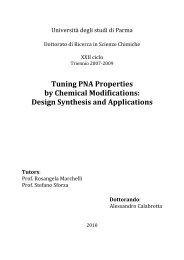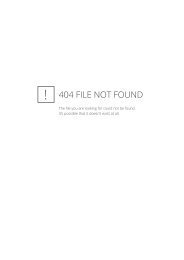Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
esserci <strong>che</strong> si confronta col pensiero della non-presenza, dell’esclusione. Il testo è<br />
basato su due isotopie: quella della vita <strong>che</strong> sboccia («il fanciullo acquatico e felice» e<br />
poi «gravido di luce») e quella della parola come essenza della vita stessa (il «verso <strong>che</strong><br />
lo dice» e poi il «silenzio» e infine la «festa di parole»). 23 Il segno poetico rinvia ad una<br />
realtà immateriale e attinge a una dimensione precedente la scrittura, in cui cerca le<br />
simmetrie naturali capaci di reggere e continuare il discorso. Piano onirico ed esistenza<br />
conscia si confondono «nella figurazione fra realistica, ipnotica e utopica del fanciullo»:<br />
il corpo è il luogo di collegamento tra ciò <strong>che</strong> si consuma e ciò <strong>che</strong> dura eterno, luogo<br />
della solitudine dell’uomo <strong>che</strong> tuttavia continua a cercare uno spiraglio, perché «la<br />
morte rappresenta l’ingiusta ipoteca della finitudine». 24 Ecco allora <strong>che</strong> manca una<br />
determinazione temporale se non l’immediatezza della visione, e la circostanza<br />
aneddotica sfuma in favore dell’astrazione: la vita <strong>che</strong> il poeta descrive appartiene ad<br />
una dimensione altra, perciò in questa poesia non ci sono verbi, non ci sono tempi<br />
verbali, non c’è il tempo. 25 Si giunge allora alla fusione dei tempi in una dimensione<br />
priva di conflitti, in cui tutto è còlto in una assolutezza <strong>che</strong> lo estrania da ogni umana<br />
collocazione: non c’è Proust, non c’è rivelazione del “tempo perduto”, 26 c’è invece la<br />
rappresentazione di un eterno presente in cui si accampano gli oggetti <strong>che</strong>, come in un<br />
gioco combinatorio, assumono l’evidenza di carte di tarocchi preziose e rivelatrici (il<br />
fanciullo, l’acqua, la luce, il sole e le parole). 27 Assistiamo ad una rappresentazione<br />
23<br />
Così Daniela Mar<strong>che</strong>schi in Sandro Penna. Corpo, tempo e narratività, cit., p. 28: «creatura limpida (pura e<br />
trasparente) <strong>che</strong> non sembra già più del mondo terrestre, si mostra “gravido di luce” cioè contiene in sé la luce.<br />
Quest’ultima appartiene al suo essere e, per tale ragione, si connette al “silenzio”, proprio dell’atemporalità<br />
dell’essere medesimo. Eppure si tratta di un silenzio <strong>che</strong> non annienta le parole, perché è nel misurarsi con l’oggettiva<br />
sostanza dell’altro, quale essa sia, <strong>che</strong> scaturiscono appunto queste. Dalla immaterialità della luce alla materialità dei<br />
suoni, dall’eterna grazia della primavera della vita alla presente (questa) realtà del poeta, la gioiosa “festa di parole”<br />
mette in risalto il mutuo, incessante scambio tra tutto quanto vive e sta nel cosmo, ovvero “la permanenza<br />
dell’intemporale nella temporalità” e viceversa».<br />
24<br />
Roberto Deidier, Penna tra Saba e Montale, in Umberto Saba, Lettere a Sandro Penna, cit., pp. 101-103. E si<br />
legga an<strong>che</strong> Robero Deidier, L’officina di Penna, cit., p. 8: «La liricità di Penna, tuttavia, individua un singolare<br />
punto di fuga rispetto alla grande tradizione petrar<strong>che</strong>sca, al cui stile e registro sembra pienamente attingere. Nel<br />
“monolinguismo” <strong>che</strong> la caratterizzerebbe, infatti, subentra un livello di microstoria e di parziale “realismo” (ma solo<br />
sul piano lessicale), <strong>che</strong> instaura una tensione dialettica tra la descrizione e la trasfigurazione sognante».<br />
25<br />
Si legga an<strong>che</strong> quanto scrive Stefano Petrocchi in Il taccuino bianco di Sandro Penna, in AA.VV., Sandro<br />
Penna. <strong>Una</strong> diversa modernità, cit., p. 97: «La con-fusione progressiva di figure umane ed elementi naturali è<br />
condotta con i modi ellittici della frase nominale, dell’andamento paratattico e dell’analogia». Questo procedimento<br />
rende il senso di a-storicità del reale <strong>che</strong> è oggetto dell’attenzione di Penna e rende il senso separatezza <strong>che</strong><br />
caratterizzano la poesia e il poeta.<br />
26<br />
Cfr. Daniela Mar<strong>che</strong>schi, Sandro Penna fra poesia e prosa, in AA.VV., Sandro Penna. <strong>Una</strong> diversa modernità,<br />
cit., p. 119.<br />
27<br />
Ivi, p. 102: «[…] Penna sottolinea il lieto impulso verso le cose, la risonanza interiore frutto dell’emozione<br />
della bellezza, piuttosto <strong>che</strong> il tripudio coloristico, ditirambico e panico, delle sensazioni. Non per nulla il “fanciullo<br />
acquatico”, creatura limpida <strong>che</strong> non sembra già più del mondo terrestre, si mostra “gravido di luce”, cioè contiene in<br />
sé la luce: quest’ultima appartiene al suo essere e, per tale ragione, si connette al “silenzio”, proprio dell’atemporalità<br />
dell’essere medesimo».<br />
70