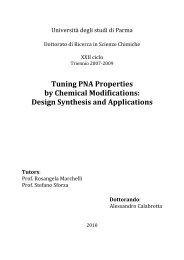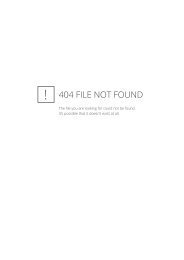Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Una lingua che combatte - DSpace@Unipr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
scrisse per l’edizione del Diario d’Algeria del 1947, <strong>che</strong> ha il valore di una vera e<br />
propria dichiarazione di poetica:<br />
Le singole date vanno comunque riferite, là dove appaiono, alle<br />
circostanze <strong>che</strong> originarono i versi e non al tempo dell’effettiva stesura. 62<br />
Il tempo <strong>che</strong> passa tra l’esperienza e la sua realizzazione lirica, lungi dall’essere un<br />
silenzio vuoto di accadimenti, si dimostra il tempo più vero della poesia, <strong>che</strong> si<br />
definisce come annotazione del dato biografico e insieme come sua dilatazione a valore<br />
esistenziale, <strong>che</strong> permette di sottrarlo ai limiti della contingenza. 63 Il <strong>lingua</strong>ggio tende ad<br />
inarcarsi su tonalità cupe, opprimenti atmosfere in cui si traducono i dettagli<br />
dell’esperienza: «Inquieto nella tradotta / […] / mi tendo alle tue luci sinistre», «un<br />
volto solo / <strong>che</strong> per sempre si chiude» (Città di notte, in Diario d’Algeria); «Io non so<br />
come sempre / un disperato murmure m’opprima», «E non è fiore in te <strong>che</strong> non<br />
m’esprima / il male <strong>che</strong> presto lo morde», «alla tua gioia / sono cieco ed inerme». Fino a<br />
giungere a toni espressionistici, <strong>che</strong> deformano la realtà in uno straziato paesaggio<br />
dell’anima: «E l’ombra dorata trabocca nel rogo serale, / l’amore sui volti s’imbestia»;<br />
per poi concludere: «fugge oltre i borghi il tempo irreparabile / della nostra viltà»<br />
(Diario Bolognese, in Diario d’Algeria), in cui bisognerà notare <strong>che</strong> l’ultimo verso è<br />
un’aggiunta successiva alla prima stesura, <strong>che</strong> precisa il più vago e “fatale” «disperato<br />
murmure» del secondo verso, come a ribadire il tempo necessario della rielaborazione,<br />
rispondendo all’amico: «Quello <strong>che</strong> mi dici del libro e della posizione di difesa “dal presente nel presente” mi sembra<br />
davvero esatto, mette al posto giusto certe impennate apparenti – <strong>che</strong> possono trovare facili consensi e altrettanto<br />
facili dissensi in un’aria sostanzialemente estranea a quella in cui pensi di essere» (Un tacito mistero. Il carteggio<br />
Vittorio Sereni-Alessandro Parronchi (1941-1982), cit., lettera 123, p. 301).<br />
62 Vittorio Sereni, Diario d’Algeria, Firenze, Vallecchi, 1947, p. 45. Ora in Poesie, cit., p. 417. All’altezza degli<br />
Strumenti umani, Sereni scrive una Nota <strong>che</strong> chiarisce ancora di più questo suo procedere, <strong>che</strong> potrebbe essere esteso,<br />
à rebours, an<strong>che</strong> a Frontiera e allo stesso Diario d’Algeria: «Per i singoli componimenti una datazione più rigorosa<br />
risulterebbe tutto sommato arbitraria. Sarebbe possibile, se mai, per ciascuno di essi stabilire una data di «partenza» e<br />
una di «arrivo»: nel qual caso però alcune «partenze» rischierebbero di figurare come anteriori persino al ’45. Un<br />
margine così largo di tempo non implica in alcun modo fasi di lavorazione protratte al segno dell’incontentabilità o<br />
del rigore dal punto di vista strettamente stilistico, bensì una serie di modifi<strong>che</strong> e aggiunte, di deviazioni e<br />
articolazioni successive, dilatazioni e rarefazioni offerte o suggerite, quando non imposte, dall’esistenza, dal caso,<br />
dalla disposizione dell’ora […]. Si dà quindi per inteso <strong>che</strong> là dove un riferimento temporale accompagna<br />
esplicitamente un testo, quel riferimento indica, senza eccezioni, una «partenza» o una fase e non rappresenta mai una<br />
data di composizione» (Vittorio Sereni, Gli strumenti umani, Torino, Einaudi, 1965, p. 95, poi in Poesie, cit., p. 469.<br />
Questa Nota è in parte citata an<strong>che</strong> da Dante Isella, Giornale di “Frontiera”, cit., p. 17).<br />
63 Alessandro Parronchi, a proposito del Diario d’Algeria, parla di «quella grazia di consistere in pochi momenti,<br />
sottratti al tempo, di vita piena» e distingue le due direzioni verso cui si muove il Diario: «indietro la limpidità di<br />
tanti paesaggi attraversati, parte vissuti parte sognati – in avanti il ricollegarsi dell’anima col suo centro intimo», da<br />
cui risulta <strong>che</strong> «il tessuto della poesia non resta fisso, non trova quei calchi mnemonici <strong>che</strong> danno un tono scadente –<br />
così spesso – alla poesia di Montale; ma an<strong>che</strong> dov’è preciso e unito, ha l’essenza del variabile, di ciò <strong>che</strong> ogni volta<br />
sorprende». Ora in Un tacito mistero. Il carteggio Vittorio Sereni-Alessandro Parronchi (1941-1982), cit., lettera<br />
XXVI, p. 89; lettera XXXI, p. 100; lettera XXXVI, p. 119.<br />
141